Psicopolitica: cittadinanza passiva e fine della libertà
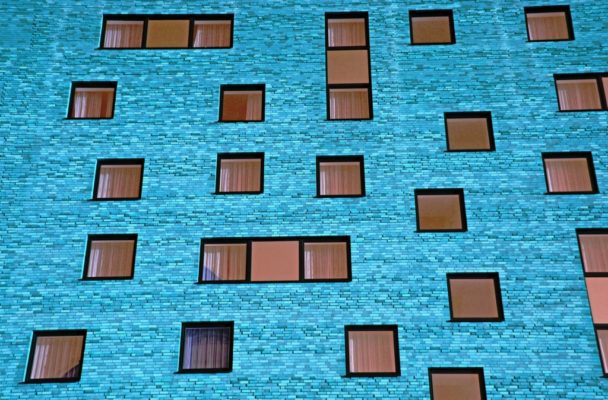
Francesco Paolella
Servirebbe un po’ di silenzio e di buio. Uno spazio dove rifugiarsi, non libero, ma almeno vuoto. L’importante sarebbe che fosse un vuoto singolare, nascosto, invisibile, irraggiungibile. Ma come vincersi tanto di scegliere di vivere al buio, nel vuoto? Servirebbe la quiete degli angoli scuri, trascurabili. Invece la connessione è ovunque, l’illuminazione degli schermi è continua e continuamente ci chiama, il dispositivo ci provoca all’azione (digitale), a condividere, a commentare, a commentare di nuovo. E tutta l’azione “politica” (in senso lato) si riduce alla passività dello spettatore. La nostra democrazia digitale funziona soprattutto per soggetti solitari, consumatori inesauribili, e ovviamente “imprenditori di se stessi”. Raramente si trova in un libro un incipit così efficace, Accade con l’ultimo lavoro del filosofo coreano Byung-Chul Han, Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere (traduzione di Federica Buongiono, Nottetempo, Roma, 2016). Ecco l’incipit: «La libertà sarà stata un episodio».
Han diventa così l’annunciatore della fine (serena, volontaria, mai traumatica) della libertà, così come abbiamo pensato e voluto la libertà moderna. Il totalitarismo digitale sfrutta la libertà di ognuno: non la costringe, non la controlla troppo, anzi la suscita continuamente, la rende più produttiva e compiaciuta. Oggi il soggetto è un servo assoluto, perché non ha più nemmeno un padrone contro cui ribellarsi.
Il consumo di informazioni, di immagini, di emozioni, proprio dell’economia digitale, funziona perché ognuno (come lavoratore, come spettatore, come consumatore, come elettore, tutti ruoli fusi assieme in un profilo) sente nelle proprie mani un potenziale illimitato e illimitatamente libero. Purtroppo l’esistenza materiale, e lo stesso mercato, non soddisfano per tutti (anzi…) questo bisogno di libertà sconfinata e scriteriata. Da ciò deriva una lotta interiore sempre più violenta: ecco l’epoca della depressione, dell’aggressività contro se stessi.
Nelle società della prestazione neoliberale chi fallisce, invece di mettere in dubbio la società e il sistema, ritiene se stesso responsabile e si vergogna del fallimento. La libertà si è svuotata; il potere produttivo del singolo è espropriato. L’illusione di essere comunque liberi, soggetti capaci di negare e creare, va di pari passo con l’illusione della privacy e del possesso – nonostante tutto – della propria immagine.
La rete ha distribuito e distribuisce, solleticando il narcisismo di cui ognuno è fornito, l’illusione di aver sotto controllo il proprio sé pubblico, pur denudandosi, volontariamente e continuamente, come dalle vetrine di un negozio.
Vince la trasparenza: il nuovo panottico digitale, ben più efficace e discreto di quello più vecchio, disciplinare, non ammette ombre, anomalie, distorsioni. Tutto è trasparente, deve esserlo, ma senza che la realtà dei rapporti di potere sia mai davvero emergente. L’informazione non produce che un circuito sterile di scandali e lamentele. Han ha ragione nell’affermare che la mediocrità, la media statistica, un tempo aborrita da romantici e filosofi, si è imposta naturalmente, irresistibilmente. E la lezione migliore che possiamo trarre da questo e dagli altri lavori di Han, è quella di fuggire la retorica esausta sul neoliberismo e di rendersi conto che ormai è il potere è uscito dai palazzi di governo, dai centri della speculazione e persino dagli uffici dei capi nelle fabbriche. O meglio: c’è ancora e sta anche bene in salute, ma non ha più bisogno di sorvegliare e punire per funzionare.
Non gli serve più sorvegliare, perché ci si sorveglia a vicenda. E ognuno si corregge da sé, in vista della piena conformità. Non serve più individuare un biopotere fuori, da qualche parte: ogni soggetto si da tutto, spontaneamente e interamente, in una sottomissione inconsapevole. Le repressioni e tutte le varie tecniche disciplinari diventano inutili e sono antiquate. La psicopolitica digitale studiata da Han, ha abbandonato ormai i corpi per dedicarsi alle anime (che, si sa, dei corpi sono le prigioni): si dedica alle emozioni, alla gioia delle prestazioni, alla fatica del lavoro, imposta e vissuta come un gioco, e alla religione del tempo libero, imposto e vissuto come un lavoro. Ed è proprio nel mondo del lavoro (che è ormai il mondo tout court) che il nuovo fanatismo della prestazione esplode con più evidenza. Lo schermo con cui si lavora (prima di tutto sulla propria immagine) non si spegne mai. Non si smette mai di produrre (informazioni, opinioni, gusti ecc., anche solo con un “like”) e di lasciar sfruttare il proprio lavoro, lasciando trasformare il proprio sé in un quanto statisticabile: il soggetto perde la propria memoria, perde la propria capacità di creare memoria, consegnandosi a una archiviazione continua e totale fuori di sé, e si trasforma in una cifra per big data.
I padroni sono benevoli: non minacciano ma motivano. Fanno sognare traguardi e premi. Gli uffici assomigliano sempre più a dei centri di fitness. Anche nel mondo del lavoro il potere più attendo all’estetica che all’ortopedia. Il soggetto è chiamato a farsi imprenditore di se stesso, investendo tutto su di sé, sul proprio potenziale e intanto lavorando gratis. Libertà e sfruttamento coincidono. L’anarchia si è avverata.
[cite]
tysm review
philosophy and social criticism
vol. 31, issue no. 34, july 2016
issn: 2037-0857
creative commons license this opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license.
based on a work at www.tysm.org
