Jean Genet e la posizione di partenza improvvisa
Leila Shahid
Mettere tutte le immagini del linguaggio al riparo e servirsene, poiché si trovano nel deserto in cui vanno cercate.
Jean Genet, Un captif amoureux
Se, nel 1970 e dopo i massacri di settembre, il primo contatto di Genet con i palestinesi è stato emotivamente forte, è senz’altro con le donne che ha avuto maggiore complicità, malizia condivisa, comunicazione reale… I campi sono un po’ la Palestina trasportata dai palestinesi nel loro esilio.
Sono la loro vita, la loro memoria, il villaggio che hanno portato con sé quando hanno dovuto mettersi in viaggio dopo la distruzione delle loro case nel 1948. Allora tutti pensavano che stavano fuggendo dalle zone di guerra, come i profughi del Vietnam, della Cambogia, del Salvador, ma che sarebbero tornati a casa qualche mese dopo, quando la situazione si fosse calmata. Sono partiti con un fagotto e il minimo indispensabile (spesso portandosi la chiave di casa, sicuri che presto sarebbero tornati). Non hanno mai fatto ritorno. Di questo esilio perpetuo, di questa partenza, è sempre stata la donna a sopportare il peso maggiore. Perché nella società araba è lei che tiene insieme la famiglia. Gli uomini hanno vissuto l’esilio come la più grande umiliazione della loro storia. Erano contadini, vivevano della loro terra. E quando si toglie la terra a un contadino, è come se gli si portasse via l’onore, come se lo si castrasse, lo si privasse dell’anima.
Per le donne era diverso. Non essendo loro a coltivare, l’esilio è stato sicuramente un’enorme tragedia, ma loro non hanno interiorizzato la terra, il villaggio, la cultura. Hanno imparato a sopportare la negazione della propria identità, della loro nazionalità. Interiorizzando l’identità palestinese e portandola con sé nei campi profughi del Libano, in Siria, in Giordania, hanno reinvestito in altre forme d’espressione, spesso culturali, che erano un po’ come le radici che le legavano alla loro terra.
Il ricamo è una delle forme di questa identità che hanno interiorizzato e ritradotto nel punto a croce sul tessuto. In origine il ricamo era il davantino dell’abito. Le contadine in Palestina portano lunghi abiti neri, blu mare o malva. E cominciano a ricamarli molto presto, perché sono gli abiti che indossano per il matrimonio. Già all’età di dodici anni, le ragazze collezionano fili di seta (il filo di seta che viene dalla Siria costa carissimo), poi tessono l’abito e cominciano a il ricamarlo. Dai dodici anni al matrimonio, che si celebra a sedici o diciassette anni, ricamano l’abito che indosseranno in quell’occasione. Ricamano anche un cuscino che è il simbolo della casa, del tetto coniugale. Quando si sono messe sulla via dell’esilio nel 1948, le donne sono partite con i loro abiti. E ovviamente, nell’orrore dell’esilio dei campi e con la vita malsana delle bidonville, la tradizione si è quasi estinta. Chi aveva ancora la possibilità di ricamare con fili di seta? Ormai il problema più immediato era sopravvivere. Ma la maggior parte dei profughi è riuscita comunque a ricreare nei campi una piccola Palestina ed è là che io ho ritrovato la mia Palestina, nel campo di Chatila. Era quasi più intensa della vera Palestina. Perciò trovo talmente bello che Genet, nelle prime pagine di Un captif dica: «Che cosa è più vero, il tratto nero sulla pagina o il bianco intorno?»
Cioè: che cosa e più forte? La Palestina, la terra in sé, o la patria che hai creato tu quando ti hanno tolto il diritto di vivere in questa terra?
In questa Palestina ricreata, c’era una forza che Jean Genet ha avvertito quando è passato per Amman nell’enorme campo profughi che si chiama Wahdate, e di cui parla in Un captif. Li ha scoperto che le donne avevano conservato il loro spirito, al contrario degli uomini, abbattuti dall’esperienza dell’esilio e dell’esproprio della terra. Quando entri in un campo le prime che trovi in piedi, testa alta e spalle dritte sono le donne, non gli uomini. Gli uomini stanno lì, con le spalle curve, la keffiah che penzola; sembrano completamente paralizzati, soprattutto i vecchi. Le donne sono molto forti, con i loro figli accanto, i feddayin; loro sono ancora in piedi perché hanno un fucile e, in un certo senso, il fucile restituisce loro quella forza che veniva dalla terra. Le donne colpivano enormemente Genet. Perché hanno una potenza, una dignità… E nessuno ha mai parlato come Genet delle donne donne in quanto tali, ma soprattutto donne del Terzo mondo, donne povere. Le comprendeva senza che parlassero, si creava complicità. Va detto che lui non parlava l’arabo e loro non parlavano il francese. La comunicazione con le palestinesi dei campi della Giordania era quindi affidata a strizzatine d’occhi. Lui le capiva e loro sentivano di essere capite. La cosa più straordinaria è che lui veniva da un Oriente ben preciso (non va dimenticato che era cresciuto in una scuola francese del Morvan, aveva studiato il catechismo, da bambino aveva cantato nel coro; era permeato di una cultura giudaco-cristiana che gli presentava l’Oriente come un grande mistero dove le donne sono velate e non ricoprono ruoli di responsabilità nella società), ed è arrivato qui, nel 1970, in Giordania, scoprendo che i veri “uomini” erano le donne. Ci sono, sono forti, prendono iniziative, comandano sugli uomini, anche se ufficialmente non hanno altra posizione che quella femminile!
Genet ne è rimasto molto colpito. Ma non voglio raccontare Un captíf amoureux, il romanzo in cui le ha descritte. Sono splendide, non foss’altro che per la forza dimostrata di fronte all’esercito giordano, o per quel loro lato malizioso, come quando smontano la seriosità dei maschi e li prendono in giro, o ne smitizzano la virilità, e scherzosamente dicono: «Quello li che ti pare un gran combattente, io l’ho strigliato e lavato; lo conosco, l’ho tirato fuori io dalla mia pancia».
Quindi è per il tramite delle donne che ha conosciuto veramente i palestinesi e ha cominciato ad amarli. Ma vorrei tornare al fascino che esercitavano su di lui i ricami, La prima volta che ha rivisto i davantini come quelli degli abiti delle contadine dei campi di Amman è stato a Rabat. Mia madre allora abitava con me lei è nata nel 1920 a Gerusalemme, ha trascorso tutta la sua infanzia in Palestina, è stata testimone della lotta palestinese contro il mandato e contro la creazione di Israele, poiché suo padre faceva parte del movimento nazionalista (tra l’altro è stato arrestato dagli inglesi e deportato per quattro anni). Dunque mia madre era ad Amman al momento dello scoppio della guerra del 1967 tra Israele e i paesi arabi, e durante l’esodo ha visto le donne che vendevano braccialetti e vestiti per sopravvivere in attesa dei camion di viveri mandati dalle Nazioni Unite. E rimase straziata vedendo le donne che vendevano i propri abiti perché era come se perdessero una seconda volta le loro radici, la loro terra.
Tornata a Beirut, prese contatti con alcuni gruppi che si occupavano dei campi profughi e, invece dei soliti lavori a maglia, propose di recuperare la tradizione nazionale del ricamo e salvare la cultura che l’abito contadino femminile rappresentava. Ma, poiché ricamare questi abiti richiedeva anni, suggerì di fare dei piccoli cuscini quadrati con un motivo principale che riprendesse quelli degli abiti. Fu così che insieme alle sorelle studiò i motivi motivi millenari dei vestiti comperati lungo la strada dell’esilio. Ognuno ha un suo significato, un suo nome; evoca un 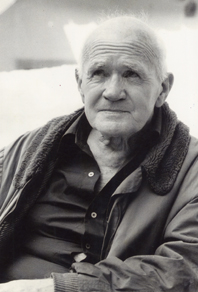 villaggio o una contrada. L’idea, infatti, non era di fare semplicemente dei ricami, ma di far vivere la cultura palestinese e resistere alla negazione della propria identità. È così che Jean, seduto nel mio salotto a Rabat, vedeva mia madre ricamare per delle ore. (Mia madre ha vissuto tutta la guerra della Palestina e tutta la guerra del Libano. t stata esiliata dalla Palestina e dal Libano. Il ricamo era come una terapia. Ogni volta che infili l’ago nel tessuto hai la sensazione di ricollegarti a qualcosa. Perché il punto a croce è come un nodo. Questo è stato il suo modo di resistere. La mia generazione ha fatto la resistenza con la rivoluzione, la sua con il ricamo.) E Jean, standosene seduto, si chiedeva che cosa ci facesse questa donna palestinese in Marocco, che ricopiava motivi che provenivano dai davantini che lui aveva visto sul seno delle donne palestinesi nei campi di Baqa e di Wshdate. Cercava di cogliere la relazione tra i campi profughi in Giordania, il salotto di Rabat, e l’ago di mia madre che si muoveva sul tessuto. E questa storia, questa vita che si ricama (e, non si può non riandare alle leggende greche come il filo di Arianna, la tela di Penelope, alla memoria, all’identità, allo spazio e al tempo) diventava subito per lui profondamente simbolica. Con mia madre, che date le sue origini sociali avrebbe dovuto irritarlo (nel libro ne parla in modo assai toccante), aveva instaurato un rapporto bellissimo perché in lei ritrovava la dignità. Mi parlava delle sue spalle e diceva: «Come è bella di spalle», perché ritrovava in lei la dignità delle donne che hanno saputo, ognuna a suo modo, resistere all’espropriazione e all’esilio e le domandava tante cose sui ricami che faceva, e lei gli raccontava la storia della confezione degli abiti. Continuava a farle domande su Gerusalemme, la sua infanzia, la sua famiglia, la storia.
villaggio o una contrada. L’idea, infatti, non era di fare semplicemente dei ricami, ma di far vivere la cultura palestinese e resistere alla negazione della propria identità. È così che Jean, seduto nel mio salotto a Rabat, vedeva mia madre ricamare per delle ore. (Mia madre ha vissuto tutta la guerra della Palestina e tutta la guerra del Libano. t stata esiliata dalla Palestina e dal Libano. Il ricamo era come una terapia. Ogni volta che infili l’ago nel tessuto hai la sensazione di ricollegarti a qualcosa. Perché il punto a croce è come un nodo. Questo è stato il suo modo di resistere. La mia generazione ha fatto la resistenza con la rivoluzione, la sua con il ricamo.) E Jean, standosene seduto, si chiedeva che cosa ci facesse questa donna palestinese in Marocco, che ricopiava motivi che provenivano dai davantini che lui aveva visto sul seno delle donne palestinesi nei campi di Baqa e di Wshdate. Cercava di cogliere la relazione tra i campi profughi in Giordania, il salotto di Rabat, e l’ago di mia madre che si muoveva sul tessuto. E questa storia, questa vita che si ricama (e, non si può non riandare alle leggende greche come il filo di Arianna, la tela di Penelope, alla memoria, all’identità, allo spazio e al tempo) diventava subito per lui profondamente simbolica. Con mia madre, che date le sue origini sociali avrebbe dovuto irritarlo (nel libro ne parla in modo assai toccante), aveva instaurato un rapporto bellissimo perché in lei ritrovava la dignità. Mi parlava delle sue spalle e diceva: «Come è bella di spalle», perché ritrovava in lei la dignità delle donne che hanno saputo, ognuna a suo modo, resistere all’espropriazione e all’esilio e le domandava tante cose sui ricami che faceva, e lei gli raccontava la storia della confezione degli abiti. Continuava a farle domande su Gerusalemme, la sua infanzia, la sua famiglia, la storia.
Nel 1982 siamo andati a Beirut. Si era dimenticato del ricamo. Con noi abitava una donna che aveva perduto la casa. Questa donna, seduta lì, ci vedeva correre da tutte le parti a causa dell’invasione di Beirut Ovest e voleva rendersi utile perché si sentiva un po’ come un’intrusa. Un giorno io e Jean rientriamo da uno dei nostri giri in città. Un edificio in cui abita mia madre è stretto e lungo, costeggia il mare e sul davanti c’è una strada in salita. Arriviamo in cima alla strada, da dove si vede il nostro palazzo di dodici piani, alzo gli occhi e… che cosa vedo sul balcone all’ottavo piano, il balcone di mia madre? Decine e decine di vestiti palestinesi stesi sulla veranda. E Jean mi dice: «Leila, guarda». E vediamo tutti quei vestiti in bella mostra sul balcone. Ci precipitiamo lungo la strada e saliamo all’ottavo piano gridando: «Ritiri dentro gli abiti, li ritiri. Un esercito israeliano era in città e gli abiti palestinesi erano stesi in veranda. Ho detto a quella donna: «Che cosa hai fatto? Perché hai messo i panni sul balcone?». Mi dice: «Non avevo nulla da fare. Siete andati via tutti e mi avete lasciata qui, nel cassone in camera di tua madre ho trovato tutti quei vestiti. Mi sono detta che era il caso di fargli prendere un po’ d’aria così le tarme non se li mangiano». Di sicuro non si rendeva conto che quegli abiti erano come bandiere, e che per gli israeliani vedere dalle macchine che pattugliavano quegli abiti appesi era come vedere bandiere palestinesi.
Questo fatto divertì molto Jean; gli fece cogliere il rapporto tra gli eventi e il significato di quei ricami visti in precedenza sui davantini delle donne di Amman, poi nel salotto di Rabat, e poi ritrovati sui balconi di Beirut, nel momento in cui la città era invasa dall’esercito israeliano. Vi scorgeva una forma d’espressione talmente più sottile di quelle maschili, una forma di comunicazione e di parola sulla Palestina che i normali discorsi politici non trasmettevano. E contemporaneamente il ricamo era un discorso, tutto ciò che si può dire sul rapporto con la propria terra, la propria identità, la propria memoria. Ma questo non era nelle parole esplicite, ma nei segni sottili, nei colori, nella simbologia estetica. [ …]
Ciò che nel ricamo affascinava Jean, infatti, era il gesto. Nel momento in cui si buca il tessuto, si fa un cerchio. E io, a proposito della sua vita, dicevo sempre: il cerchio è chiuso. Il cerchio della vita di Jean è chiuso, comincia da qualche parte con l’assistenza pubblica, passa attraverso la rivolta, la prigione, va verso Oriente da soldato, torna verso Oriente con i palestinesi e termina davanti ai cadaveri che trova ai suoi piedi a Chatila.
Un captif amoureux è anche questo. Quasi la tessitura della sua vita. In questo libro che è innanzi tutto un libro su Genet, ma anche sui palestinesi, su tutto ciò che per Genet è stato importante, è come se ci dicesse: «Ti ho sempre mentito. Non è vero che ho scritto perché i lavori mi sono stati commissionati». (Non smetteva mai di ripeterlo.) Ed è molto bella questa idea che il ricamo gli abbia ispirato la struttura del testo, e credo che l’accoglienza negativa del libro derivi dal fatto che la gente non l’ha capito. Quando ha consegnato il manoscritto a Gallimard, immediatamente tutti i benpensanti, i critici, i lettori, i direttori di collana hanno voluto sapere:«Che cos’è? Un saggio? Un’autobiografia? Un reportage? Un poema?». Dunque li ha completamente spiazzati perché si trattava di ciò che Jean chiama «il piccolo disordine nell’ordine».
E non riuscendo a trovare una definizione per il testo, hanno detto: «Non è importante, non è interessante, è un testo senile in cui Genet si fa beffe del mondo». Non hanno capito che era proprio il contrario. Davanti alla morte Genet fa quello che si era rifiutato di fare per settanta anni. Si mette a nudo, totalmente, con una limpidezza e una trasparenza che non posso definire che mistiche.
Nelle immagini della tessitura, della rete, della ragnatela che tanto spesso ritornano in Un captif, si ritrova quel modo speciale che Genet aveva di abitare il mondo. Quando uscì di prigione andò a Damasco per poi tornare a Parigi. A Parigi tornò di nuovo dentro. Quando uscì, partì per la Germania, poi andò in Grecia e a Tangeri. Poi tornò ancora a Parigi, da Parigi parti per l’America e dall’America tornò ad Amman, poi a Rabat, da Rabat a Beirut, e infine a Parigi.
È vissuto tessendo la sua vita attraverso i continenti, i popoli, le culture, le lingue. Un andirivieni senza sosta che, come il suo libro, distruggeva spazio e tempo.
Nel nomadismo dei palestinesi in esilio c’è lo stesso itinerario di spostamento perpetuo. Per questo lo hanno affascinato molto di più i palestinesi in esilio che quelli che sono rimasti nella loro terra.
Genet si è sempre messo «in posizione di partenza improvvisa», come dice in Chatila, per abbandonare la cultura, la lingua con cui era nato e cresciuto, per andare verso un’altra cultura, un’altra lingua. Perché è nello spazio intermedio, nel bianco tra i due neri che esistono le cose reali. Là nella fessura che vedeva la traccia principale della vita che gli stava a cuore. Proprio là dove c’è qualcosa che rompe l’ordine.
Quel che si dovrebbe fare con l’opera di Genet è proprio questo: ispirarsi al gesto, e non necessariamente appiattirsi su una fedeltà formale al testo o al messaggio.
In Un captif, che è un libro sulla scrittura e sulla creazione (e anche sulle Pantere nere e i palestinesi), c’è un patrimonio di proposte di creatività. Una creazione che si colloca tutta nella realtà del mondo d’oggi. Con i neri, i bianchi, gli arabi, i palestinesi, l’Islam, la cristianità, il conformismo e la rivoluzione. Non è qualcosa che si limita a una frontiera nazionale o alla causa palestinese o dei neri d’America. È universale.
Sarebbe stupido credere che si limita a una sola frontiera.
In questo andirivieni, in questo tessuto c’è un universo intero. La scelta è aperta a tutti. C’è un invito alla scrittura, alla creazione. C’è qualcosa che assomiglia a una lunghezza d’onda che si ritrova e passa attraverso lo spazio e il tempo facendo sì che la letteratura, la musica, la pittura abbiano un linguaggio comune che trascende gli esseri umani nella loro dimensione quotidiana. Spero che altri sperimentino, con Genet o altri scrittori, lo stesso coraggio, per creare tutte le cose che nel niente, nel deserto aspettano. Jean lo diceva nel migliore dei modi: «Mettere tutte le immagini del linguaggio al riparo e servirsene, poiché si trovano nel deserto in cui vanno cercate»… Questa frase l’ho letta quando il suo amico Jacky mi ha dato il manoscritto. E Jacky, che conosceva Genet perfettamente e lo aveva lasciato la sera prima per non doverlo mai più rivedere, mi disse: «Strano, questa nota scritta a mano ieri non c’era». Guardai. Anche nei caratteri, nel bianco della pagina, c’era la tensione febbrile, il tremito della mano di jean che stava per morire e aveva bisogno di mettere in esergo al Captíf queste poche righe. Le avrò lette mille volte cercando di attraversare il muro della morte che ci separa e chiedendomi: . «Che cosa ha voluto dire?».
E ora parliamo di inventare, di essere all’origine del nuovo e all’improvviso interpreto questa frase ancora in un altro modo. Le immagini sono nel deserto in cui vanno cercate. È una sfida lanciata a tutti i creativi: bisogna andare sempre altrove, là dove c’è deserto.
