Etienne Balibar: «L’universale non unisce, divide»
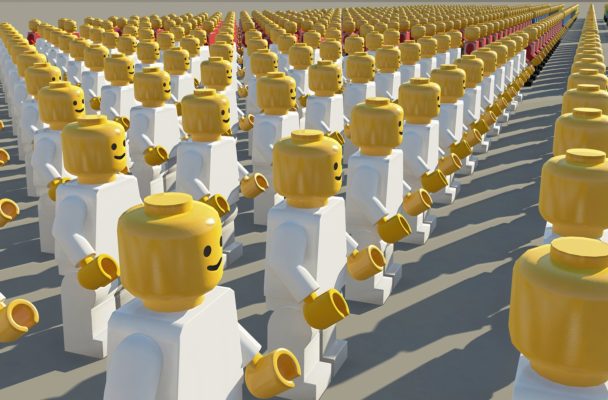
Lei ha recentemente pubblicato un libro sulla questione dell’universale (« Des Universels », Galilée, 2016). Ora, questa nozione che sembra così famigliare appare spesso oscura. Se dovesse darne una definizione di fronte a studenti dell’ultimo anno, che cosa direbbe?
Direi che è un valore che indica la possibilità di essere uguali senza per forza essere gli stessi, quindi di essere cittadini senza dover essere culturalmente identici. Nella nostra epoca l’universalismo è talvolta associato all’accordo unanime e, di primo acchito, a una sinistra “benpensante”, che si presume molle e naïve. Ora, per lei l’universalismo è tutt’altro che un idealismo. A leggerla, si direbbe che ogni universalismo è foriero di tensioni, se non di violenza. In primo luogo il mio obiettivo non è quello di difendere una “posizione di sinistra”, ma di discutere dell’universalismo come questione filosofica. Ma, certo, sono di sinistra. Ora, la sinistra è attraversata da tutti i conflitti connessi alla questione dell’universale. L’universale non unisce, divide. La violenza è una possibilità permanente. Ma sono i conflitti interni che cerco innanzitutto di descrivere.
Quali sono i principali?
Il primo è che l’universalismo si iscrive sempre in una civiltà, anche se ricerca formulazioni in temporali. L’universalismo ha un luogo, delle condizioni di esistenza e un luogo di enunciazione. L’universalismo è l’eredita di grandi invenzioni intellettuali: per esempio i monoteismi abramitici,la nozione rivoluzionaria dei diritti dell’uomo e del cittadino, che fonda la nostra cultura democratica, il multiculturalismo in quanto generalizzazione di un certo cosmopolitismo, etc. Io sostengo dunque la tesi che gli universalismi sono concorrenti, e lo sono in un modo tale che non ha senso parlare di un universalismo assoluto.
È quasi una legge della storia: un universalismo che si costituisce non ne sostituisce mai completamente un altro. E questo perché i conflitti possono essere riattivati. Questa è anche la ragione per cui trovo Hegel così interessante, a condizione di leggerlo a contropelo: Hegel non ha mai cessato di lavorare sul conflitto tra universalismi, in particolare il cristianesimo e l’illuminismo, sperando di “superare” le loro contraddizioni.
Ora, quello che oggi noi possiamo osservare è che gli universalismi religiosi sono immersi in una crisi interminabile, e al contempo anche l’universalismo fondato sui diritti dell’uomo è entrato in una profonda crisi. Abbiamo un universalismo la cui crisi non è ancora finita contro un universalismo la cui crisi è appena cominciata: ecco ciò che, tra le altre cose, spiega la violenza del confronto.
Per la maggior parte delle persone “universalismo” è sinonimo di unione e fraternità. Ora, lei dice che al cuore dell’universalismo c’è anche l’esclusione. Che cosa significa?
Certo, in teoria, c’è contraddizione tra l’ideale universalista e l’esclusione. Il problema è quello di comprendere come questi contrari giungano a diventare il diritto e il rovescio di una stessa medaglia. La mia tesi è che l’esclusione penetra nell’universale tramite la comunità e, simultaneamente, tramite la normalità.
Quando si istituiscono comunità che hanno come ragion d’essere la promozione dell’universalismo in certe forme (imperi, Chiese, nazioni, mercati, …), si formulano anche delle norme di appartenenza alle quali gli individui devono conformarsi. Se prende l’idea che il cristianesimo si fa della comunità, vede che essa prevede eletti e dannati. E se prende una comunità politica moderna come quella incentrata sui diritti dell’uomo, che si è instaurata intorno all’idea di nazione, si vede che non sono solamente gli stranieri propriamente detti ad essere esclusi, ma anche quelli che non sono “veri nazionali” o che vengono considerati inadatti alla cittadinanza attiva. Beninteso, tutto ciò è l’oggetto di una contestazione che modifica i confini della cittadinanza. Non è da tanto, ad esempio, che le donne sono elettrici e gli operai sempre veramente eleggibili. Ma la questione del razzismo apporta un grado di conflittualità supplementare.
Tempo addietro, avevo sostenuto che il razzismo moderno è come l’iscrizione del rimosso coloniale nel cuore della cittadinanza. È un lato oscuro della nazione repubblicana che non cessa di ritornare grazie ai conflitti della mondializzazione. Proprio oggi, in Francia, abbiamo l’illustrazione tragica di ciò in virtù di un certo uso della laicità. Nel momento in cui la nazione è sempre più incerta dei suoi valori e dei suoi obiettivi, la laicità si presenta sempre meno come garanzia di libertà e uguaglianza tra i cittadini e si mette a funzionare come un discorso di esclusione.
Del resto, quello che in questo vi è di comune con l’universalismo religioso, è che l’argomento che giustifica l’esclusione consiste quasi sempre nel dire che gli esclusi sono quelli che rifiutano l’universalismo, o che sono incapaci di comprenderlo correttamente: “nessuna libertà per i nemici della libertà” (o presunti tali). In questo si ritrova una grande costante dell’ Occidente, ma anche dell’Oriente: non è l’universalismo in quanto tale ad essere violento ed escludente, lo è la combinazione dell’universalismo e della comunità. E siccome in fondo quella combinazione non la si può evitare, bisogna trovare il modo di civilizzarla: un compito politico fondamentale ai miei occhi.
Lei si spinge piuttosto in là con questa idea, ad esempio quando afferma che l’universalismo e il razzismo hanno “la stessa fonte”.
Attenzione, non dico che l’universalismo in quanto tale è razzista, né che il razzismo è la forma di universalismo nella quale viviamo. Semplicemente, non voglio che si possa credere che siano due cose che non hanno nulla a che vedere tra loro. Ecco perché abbiamo bisogno di imparare a pensare filosoficamente la condizione spuria delle istituzioni nelle quali viviamo. La fonte comune all’universalismo e al razzismo – questi due opposti – è l’idea della specie umana così come essa è stata fabbricata dalla modernità borghese, di cui uno dei principali rappresentanti è Kant. Come può Kant essere al tempo stesso il teorico del rispetto incondizionato della persona umana e il teorico della diseguaglianza culturale delle razze? In questo consiste la contraddizione più profonda, l’enigma stesso.
Ora, tutto ciò ha a che vedere innanzitutto con il modo in cui Kant definisce il progresso, che non consiste solamente nello stabilire un orizzonte per l’uomo in generale, ma anche nell’erigere a norma certe caratteristiche relative al genere, alla nazionalità, o all’educazione.
Anche se ci sono della varianti, questo discorso è comune ai rivoluzionari francesi e americani del XVIII secolo e ai movimenti di emancipazione sociale del XIX, sui cui valori ancora ci basiamo. Ma quello che è fondamentale ai miei occhi è che un simile universalismo autorizza anche la resistenza. Nel XVIII secolo, la francese Olympe de Gouges e la britannica Mary Wollstonecraft hanno fondato il femminismo politico proclamando che l’identificazione dell’universale con una norma maschile contraddice il postulato dell’eguale libertà e dell’accesso ai diritti per tutti e tutte.
Si può quindi contestare l’universalismo in nome dei suoi stessi principi, come ha fatto anche tutta una parte del discorso anticolonialista: ad esempio Toussaint Louverture e Frantz Fanon, William E. B. Du Bois, Aimé Césaire. È l’altra faccia della tensione che lavora ogni universalismo: può giustificare le discriminazioni, ma anche rendere possibili la rivolta e l’insurrezione.
Nel suo Saeculum. Culture, religion, idéologie (Galilée, 2012), lei osserva che gli choc più violenti non sono tanto quelli che contrappongono un universalismo a un particolarismo, ma quelli che oppongono due universalismi rivali tra loro. Da questo punto di vista lo jihadismo stesso è un universalismo estremamente aggressivo. Vada quindi a discutere dell’universalismo democratico e delle sue contraddizioni a Raqqa, in Siria!
È vero, gli spazi di libertà si riducono … In tutti i paesi che cadono sotto la dittatura è impossibile pensare e discutere senza rischiare la propria libertà o la vita. Le mail che ricevo dalla Turchia in questo momento mi impediscono spesso di dormire. Ma su questo punto credo che vadano fatte delle distinzioni: lo Stato islamico è una variante locale dello jihadismo, che non va confuso con il fondamentalismo musulmano in generale. E a fortiori il fondamentalismo non va confuso con l’islam, profondamente diviso tra diversi tradizionalismi e vari modernismi.
Come nel passato osserviamo che una dittatura può trarre risorse ideologiche dal riferimento all’assoluto, ma è l’islam a essere universalista non lo Stato islamico. Ed è quest’ultimo a essere barbaro, non l’islam. Fatto sta che lo Stato islamico è un vero problema per l’islam. Su questa materia gli animi sono talmente esacerbati che è molto difficile farsi comprendere. Dopo gli attentati del gennaio 2015 avevo scritto un articolo su Libération che mi è stato molto rimproverato. Riportava questa frase: “la nostra sorte sta nelle mani dei musulmani”. Per me questo non significava: “musulmani, modernizzatevi urgentemente o siete fottuti e noi con voi!”. Significava piuttosto che, se la resistenza non viene dallo stesso islam, allora le cose si aggraveranno in maniera irreversibile. Non era un modo di rigettare le responsabilità sull’altro, che del resto è anche una parte di noi stessi. Ma è vero che ognuno occupa un certo posto e si trova quindi costretto a parlare un determinato linguaggio.
Personalmente, certo, tendo ad accordare un privilegio alla laicità, e me lo si è obiettato. Ma che devo? Non mi trasformerò in musulmano o in cattolico, sono stato comunista; sa, è un esperienza religiosa molto formativa… Per questo ho anche scritto che bisognerebbe inventare una sorta di eresia generalizzata che rendesse il discorso religioso e quello laico capaci di trasgredire i propri stessi interdetti.
Lei ha scritto molto sull’Europa (da ultimo Europe, crise et fin?, Le Bord de l’eau, 2016) e non esita a dire “Noi, Europei”. Che reazione ha quando sente Jean-Luc Mélenchon proclamare che la Francia è una “nazione universalista”?
Se potessi interloquire con lui gli direi che posso accettare questo discorso purché sia inteso come l’equivalente di “noblesse oblige”, cioè: “République oblige”. La République obbliga a un certo universalismo che non può più fondarsi sull’identificazione della République con la nazione. Per rimanere repubblicana, la Francia dovrebbe superare se stessa e formulare l’idea di un’estensione della cittadinanza oltre le frontiere. Dunque, “Francesi, ancora uno sforzo …”.
Per quanto riguarda l’Europa, l’intera questione consiste nel sapere se si possono risolvere i problemi dei francesi al di fuori di un contesto continentale. Sono convinto di no, e questo anche se l’Europa dà il peggio di sé come in Grecia. Ogni programma fondato sulla rinuncia al progetto europeo è destinato a sprofondare nello sciovinismo, se non nel trumpismo.
Quando affermo questo, persone come la mia amica Chantal Mouffe mi rimproverano e mi dicono: “ma in che pianeta vivi? L’identità nazionale è il solo ambito che può permettere di difendere le classi popolari contro il capitalismo selvaggio!” . Credo che si sbaglino, ma certamente bisogna dimostrarlo. Il mio punto fermo è questo: non voglio rinunciare né alla critica sociale né all’internazionalismo.
Quello che è originale in una figura della sinistra postmarxista come lei, è che rifiuta con la stessa energia la rigidità identitaria e quella che chiama l’“ibridarsi senza forntiere”, Per lei non c’è universalismo possibile senza coscienza identitaria. Ogni universalismo è radicato.
Certo, perché siamo soggetti umani, che non possono vivere senza domandarsi “chi sono?”. Nessuno può vivere senza identità o cambiarne a caso, ma d’altra parte l’imposizione di una sola identità non è mai stata possibile senza violenza. Secondo me la teorica americana Judith Butler ha ragione su questo punto, sempre che non si confondano le sue parole con le varianti conformiste dei discorsi queer o postmoderni, i quali affermano che si può cambiare identità senza fine e in modo casuale. In fondo si tratta di una contraddizione insuperabile che si può solo cercare di gestire.
Il filosofo Vincent Descombes ha ben mostrato che la nozione di identità è paradossale, dato che la si attribuisce agli individui mentre riguarda un’appartenenza. Ma io aggiungerei: si parla della propria identità, o di ciò che la mette in relazione con gli altri, sia per affermare quello che si possiede in comune, sia – al contrario – per distinguersi, se non per ritrarsi da ciò che è comune. Una cosa non va senza l’altra.
La nuova difficoltà è che oggi partecipiamo tutti a comunità multiple i cui criteri di riconoscimento non sono intercambiabili. Per questo esploro una strada capace di pluralizzare l’universale senza edulcorarlo o rovesciarlo in una somma di particolarismi. Questa strada consiste nella costruzione di strategie di traduzione generalizzata tra le lingue, le culture e le identità; strategie che abbiano una portata sociale e non solamente filologica o letteraria.
Se vogliamo, traduzione e conflitto sono i due poli dialettici del mio lavoro sulla violenza dell’universale. Credo che essere qualcosa di indeterminato non sia vivibile e riconosco che non è facile essere più cose allo stesso tempo. Ma non è impossibile e bisogna anche che la maggior parte di noi possa avere accesso a questa condizione senza dover vivere un’esperienza di spossessamento di sé. Il cosmopolitismo di cui abbiamo bisogno esige una certa forma di disagio identitario che mi arrischierei a definire attivo, o agente.
Intervista rilasciata a Jean Birnbaum e pubblicata su Le Monde Idées il 09.02.2017. La traduzione è di Alessandro Simoncini
[cite]
tysm review
philosophy and social criticism
issn: 2037-0857
creative commons license this opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license.
based on a work at www.tysm.org
