Civilizzati e barbari nel corpo esangue dell’Occidente. Dialogo con Alberto Abruzzese

MARCO DOTTI
“Un’ombra si proietta sui di noi, l’ombra della barbarie”. Lo scriveva, di recente, un commentatore di colonne in cronaca. Chi sia quel “noi” e da dove derivi l’ombra e di quale barbarie stesse parlando attiene a un senso comune che, da troppo tempo, oltre che scalzare il buon senso, ha ridotto a caricatura ogni atteggiamento veramente – e, di conseguenza, duramente – criitico. Chi sono i barbari? E “noi”, civilizzati?
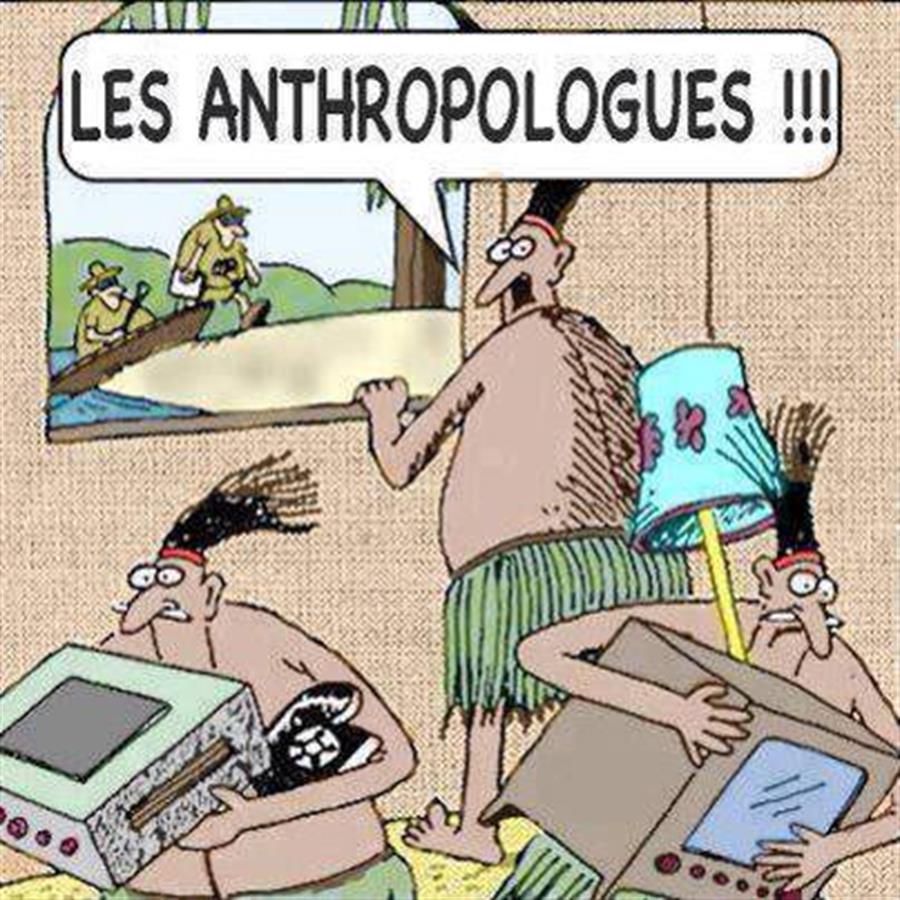 Nel tuo Punto zero, tu lavori su molte faglie critiche, ma una di queste è proprio il nesso civiltà-barbarie all’interno di quella che potremmo chiamare semiosfera. Il barbaro è una creazione della civiltà, non solo in senso semiotico, ma reale, scriveva Lotman. Dopo un lungo esilio, il barbaro – la sua immagine, la sua ombra – è tornato a affollare il nostro spazio reale e il nostro, non meno reale, immaginario. Il barbaro come una “massa semiotica” estranea, non solo “straniera”, alla civiltà sembra irrompere da tutti i confini: scuola, casa, frontiere, Europa, altra Europa, non Europa, facebook, etc … Tu però parli di un crepuscolo dei barbari, di una fine corsa del barbaro. Come mai? Potremmo delineare una fisionomia del barbaro in questo punto zero del suo percorso?
Nel tuo Punto zero, tu lavori su molte faglie critiche, ma una di queste è proprio il nesso civiltà-barbarie all’interno di quella che potremmo chiamare semiosfera. Il barbaro è una creazione della civiltà, non solo in senso semiotico, ma reale, scriveva Lotman. Dopo un lungo esilio, il barbaro – la sua immagine, la sua ombra – è tornato a affollare il nostro spazio reale e il nostro, non meno reale, immaginario. Il barbaro come una “massa semiotica” estranea, non solo “straniera”, alla civiltà sembra irrompere da tutti i confini: scuola, casa, frontiere, Europa, altra Europa, non Europa, facebook, etc … Tu però parli di un crepuscolo dei barbari, di una fine corsa del barbaro. Come mai? Potremmo delineare una fisionomia del barbaro in questo punto zero del suo percorso?
Barbaro è detto il balbuziente, colui che non dispone pienamente o addirittura non dispone del tutto delle facoltà di linguaggio del civilizzato in quanto individuo pienamente umano e cioè pienamente in possesso delle qualità che, secondo questo paradigma, renderebbero l’umano differente dall’animale e da ogni altra cosa vivente sulla terra.
Il “noi” occidentale che pronuncia la propria distanza dal barbaro – e si allarma quando lo veda riemergere dall’ombra in cui è stato rimosso o relegato o soppresso – è dunque il frutto di una progressiva distanza tra il soggetto politico del mondo e coloro che lo abitano: il terzo assente dalle declinazioni sociali della prima e seconda persona.
Hai ragione, Lotman è maestro riguardo alle questioni che ho cercato di affrontare nel mio saggio procedendo un poco in modo random. Ragionare sul barbaro – come è percepito e come entra in gioco nello spazio e nel tempo delle civiltà umane – ci aiuta a ripensare la natura dei conflitti, anche se è difficile quanto inseguire la pallina in una partita di ping pong. Lo scambio tra barbaro e civilizzato è istantaneo. L’uno rimanda immediatamente all’altro.
Al barbaro è imputata la colpa di non essere un soggetto civilizzato ma in un certo senso questi proietta nel barbaro la paura che egli ha di tornare ad essere barbaro. Il barbaro è all’insegna dell’esclusione; è un confinato; viene nominato tale in quanto porta in se stesso la colpa di non essere civilizzato; le sue azioni sono colpevoli a fronte delle azioni di quanti si ritengono innocenti (individui che non nuocciono, non fanno danno) e dunque superiori d’elezione e di diritto nell’agire e nel governare il mondo.
Nel barbaro, i civilizzati vedono il rischio che, per la sopravvivenza della propria doppia identità di civilizzati e civilizzatori, rappresenta la sua naturale “invadenza”: la sua necessità vitale di invadere l’altro, persona o territorio che sia. In comune al barbaro e al civilizzato c’è dunque la paura che qualcosa di se stessi manchi o venga a mancare. Tanto per il barbaro quanto per il civilizzato le invasioni sono mosse dal desiderio di invadere per non essere invasi.
Nel dirsi civilizzatore il civilizzato si prepara a farsi barbaro. Il barbaro non si nomina tale, se lo fa è già un civilizzato e un civilizzatore potenziale: se riconosce nella propria persona un soggetto di barbarie, lo fa trasformando la propria condizione di sopravvivenza in tecnica, in violenza, e dunque riconoscendosi soggetto in conflitto con l’altro che sente resistergli e attaccarlo con eguale violenza.
Il barbaro agisce nel nome e insieme contro il nome di chi lo nomina. Scatta, nel dire qualcuno barbaro o civile (civilizzato e civilizzatore), un impulso a dominare l’altro. Questo impulso umano ad esercitare potenza sul mondo dipende dal vivere in-divisibile tra civiltà e barbarie. L’una inestricabile dall’altra.
Ripeto: l’idea di barbaro dipende in tutto dall’idea di civilizzato e questa dall’idea di barbaro: sono – una in due e due in una – la cultura fondativa del progresso. Del potere in quanto strategia di sopraffazione del proprio nemico. Paradossalmente, della sua stessa necessità. Al fine di impedire che venga oltrepassato il punto di equilibrio tra barbarie e civiltà, il civilizzatore – soggetto di tale equilibrio, o meglio di tale finzione di equilibrio – è disposto ad adottare la stessa violenza imputata al barbaro, è deciso a dichiararsi soggetto depurato di ogni ambivalenza e doppiezza, unica e ultima possibile garanzia di sopravvivenza del potere in quanto civilizzazione, volontà sovrana sul mondo: “al di là del bene e del male”. La vicenda novecentesca del nazismo sta a dimostrarlo.
Il presente della globalizzazione sembra annunciarlo. Misurati sul dritto e rovescio dei canoni dello sviluppo “civile” del mondo, a produrre ora le fluttuanti linee di confine tra civiltà e barbarie sono modelli, canoni, di vita culturale, religiosa, sociale, etica ed economica, per quanto quest’ultima abbia sempre più una sua particolare e terribile forza invasiva su tutti gli altri modelli e ne sia sempre più il regista, il burattinaio.
Questo è il nostro finale d’epoca, il “momento critico” di relitti e derelitti del tempo e dello spazio della civilizzazione che invadono, accerchiano e penetrano al proprio interno e al loro esterno: sono percepiti come barbari tanto da chi è disposto o crede di essere disposto a includerli, magari per farli fruttare nel corpo esangue della civiltà occidentale, quanto da chi li esclude credendosi ultima barriera di difesa dei vecchi regimi della modernità.
È il “momento” di profondi rigurgiti di una civilizzazione che precipita nelle forme di imbarbarimento di cui si è sempre immaginata – e ha preteso di farsi immaginare – esente. Di generazioni che hanno voluto e dovuto convincere e convincersi di una natura umana buona e compassionevole, misericordiosa, a fronte dei soprusi della società, del capitalismo e dell’economia. E di altre generazioni in cui la civiltà delle nazioni e popoli garantiti dalla storia dei vincitori è ancora una terra da raggiungere, un futuro da costruire, un destino da condividere. O di imperi nascenti in nome di altri dei e dunque di altri costumi e valori. Di altra violenza.
Ogni distinzione tra barbaro e civilizzato sarà sempre meno “chiara”. Questa è l’ombra emersa sul mondo attuale: la rivelazione della tragedia incarnata nella commedia umana di una tale “ingiusta” – ingiustamente “naturale” – distinzione…
In Punto zero ho parlato di “crepuscolo dei barbari” proprio in questo senso: nella con-fusione non più distinguibile del crepuscolo – l’intervallo tra il prima del sorgere del Sole e il dopo del suo tramonto – il tempo della dialettica trascolora. Sprofonda. Si perde.
Walter Benjamin scriveva – e, non a caso, lo scriveva in una delle sue famose, ma forse poco ascoltate Tesi sulla storia – che non esiste documento di civiltà che non sia, al contempo, un documento di barbarie. A me pare che questa affermazione di Benjamin, disarmante proprio perché di una lucidità acuminata, non sia stata portata alle sue estreme conseguenze, cosa che invece Benjamin ci invitava a fare (colgo l’appello in quel suo grido “non lasceranno in pace nemmeno i morti”). Tu invece ne fai un punto chiave, per ridefinire questo rapporto civiltà-barbarie sulla base di un terzo spesso escluso dal discorso: il documento. “Non c’è documento…” dice Benjamin. E proprio sul documento le buone intenzioni di molti vanno a cozzare – penso alle recenti polemiche di Eco che, se non vogliamo ridurre a una Lina Sotis della semiotica, dobbiamo ritenere si rivolgesse moralisticamente alla produzione barbara, più che al bon ton di qualche scalmanato su facebook. Il barbaro interno – il “giovane” o l’uomo perso nel suo “universo liquido” – erode la società del “documento”, la società letteraria, il circolo insomma… Tu sei tra i pochi che va oltre questa dimensione nostalgico difensiva, rispetto alla mole di produzione barbara…
È la stessa soggettività della civilizzazione come atto di necessario sterminio di ciò che le resiste a perpetrare il proprio crimine su se stessa in quanto forza legiferatrice, ordinatrice di colpe e di pene. Per sopravvivere a se stessa è obbligata a divorare se stessa (a partire a questa sua natura, sarebbe bene riflettere con minore retorica sul principio di “responsabilità” del quale, pur con ogni buona intenzione, si tende a fare così grande uso).
Benjamin è maestro in veggenza nel suo stesso conferire uno straordinario fascino alle meraviglie del progresso, fascino proporzionato alle rovine che esso si lascia alle spalle. “Non lasceranno in pace nemmeno i morti”. Questa frase è illuminante. Appunto preveggente.
L’immaginario dell’industria culturale di massa è sempre stato dotato di una eccezionale forza rivelatrice. A parte l’insistenza con cui è andato sviluppando la simulazione di scenari catastrofici sempre più ravvicinati nel tempo – mondi in cui la differenza tra “case del potere e della bellezza” e “case della desolazione” si compenetrano in una stessa barbarie di sudditi e sovrani, di piacere e sofferenza – è caduta non solo ogni linea di confine tra razionalità strumentale dei moderni e follia, caos, ma è caduto anche ogni confine naturale tra la vita e la morte.
Lampante la frequenza con cui è trattato il tema dello zombie. Per una ragione in particolare: il fatto che se ne parli al plurale, dicendo “gli” zombie invece che “lo” zombie. Significa che c’è nell’immaginario una pulsione a ricostruire come società le rovine stesse della sua vita passata, estinta: a dare un futuro di “individui” e dunque una dialettica del potere e del conflitto – ai morti che “ritornano” dalla qualità indistinta e muta della morte, dal mondo senza più linguaggio ma purtuttavia vivente del “fango”.
Credo che sia da guardare con massima attenzione ai motivi per cui la fiction operata da linguaggi non-alfabetici, “analfabeti”, sta riuscendo a trattare pubblicamente, di continuo e su vasta scala, rappresentazioni del mondo così rivelatrici (appunto apocalittiche). Così sociologicamente e filosoficamente pregnanti. Per quanto sia la scrittura (romanzi e sceneggiature) a fornire di contenuti le immagini dell’industria di massa, la potenza delle immagini – tanto più fantasmagoriche quanto più numeriche – va operando in una direzione che le modalità espressive del sapere scritto e letto non possono più eguagliare.
È nelle forme di produzione, fruizione e riproduzione dell’immaginario che sta accadendo qualcosa di fondamentale: di cosa sia e stia diventando il mondo, di come si percepisca il nostro presente e il nostro futuro, si parla saltando e “tagliando” tutte le complesse operazioni che appesantiscono il discorso scientifico, storico, sociologico, filosofico affidato alla scrittura e alle tradizioni del libro.
Si tratta in sintesi di piattaforme espressive che trasmettono la propria verità in quanto verità del desiderio. È il desiderio a consumarne le immagini in modi che si avvicinano alla natura indecifrabile, subliminale, del sacro, lasciandosi alle spalle i vincoli religiosi e sociali che lo hanno oscurato.
Di fronte a questa svolta sempre più evidente, i modelli di sapere istituzionali – scambiando il problema del sapere umanistico con il conflitto tra scienze dure e scienze umane – rivendicano la necessità che le forme di produzione e consumo del “significato emotivo” del mondo che abitiamo recuperino le qualità razionali dei linguaggi tradizionali.
Al contrario bisognerebbe convincersi dell’urgenza di procedere in direzione opposta, rovesciata: a dovere riuscire a semplificare i propri apparati in modo da rispondere direttamente alla complessità in cui siamo immersi e in cui si è chiamati ad agire, sono proprio le piattaforme espressive della scrittura e delle conoscenze di cui essa è strumento (non di rado, anche il solo fine).
La scrittura sapienziale s’è accumulata, aggrovigliata sino ad essere inestricabile, sino a dovere ricominciare sempre di nuovo dal principio, oppure sino a divulgare questa sua stessa sconfitta – paradosso di una civilizzazione fondata sulla promessa e certezza di felicità – in una testualità sempre più semplificata. Inutilmente e dannosamente semplificata persino a fronte dei suoi meri fini utilitaristi. Infatti, l’opposizione tra cultura alta e divulgazione non può funzionare nell’immaginario catastrofico contemporaneo in quanto esso è indifferente alle tradizionali gerarchie tra sapienti e ignoranti.
Semmai, l’intensità emotiva, psicosomatica, dell’immaginario di consumo è una forma di critica, di decostruzione istintiva e rituale, che tende a scardinare l’individuo dalla corazza del proprio ruolo sociale ricomponendo la “persona” che tali gerarchie hanno storicamente e socialmente diviso in padroni e servitori. Dalle rispettive opposizioni tra educazione scientifica e divulgazione si dovrebbe passare ad una mossa congiunta tra processi dis-educativi e processi de-vulgativi.
Società liquida, affetti liquidi, relazioni accelerate. Il medium è il messaggio, diceva McLuhan, ma tu giustamente commenti che oggi il medium è un acceleratore di relazioni. Dobbiamo averne paura? Mi pare tu la prenda come una strategia, una possibile strategia del soggetto, una “mossa del cavallo”, un rischio estremo ma forse anche un pericolo che salva, per “rinascere a nuova vita” … Ci spieghi questo passaggio?
Dato il brevissimo intervallo di tempo che divide la vita di Benjamin da quella di McLuhan (pur così diverso par varie buone e cattive ragioni), ho sempre pensato che quest’ultimo sia stato in certa misura la reincarnazione del primo. Sicuramente per il metodo e per la spregiudicatezza, l’azzardo, e a volte persino il carattere enigmatico che faceva del loro discorso una sorta di “approssimazione”: un sapere approssimativo nel senso di avvicinamento al nodo reale della realtà. Un invito a pensare molto oltre e molto lateralmente alla propria scrittura, pur così assertiva, fulminante. Per quanto siano altri gli autori che si citano a tale proposito, Benjamin e McLuhan sono stati eccelsi mediologi della “vita quotidiana”, con uno scarto – nel loro rispettivo orientamento della ricerca – che richiama quello tra Edgar Morin e Michel De Certeau.
Del significato che assume la velocizzazione del mondo ad opera del rapporto tra desiderio e tecnologia, ha parlato il libro di Alessandro Baricco (I barbari. Saggio sulla mutazione, 2013), al quale nel mio Punto zero ho dedicato varie pagine perché, pur costituendo uno dei migliori recenti contributi sull’argomento, è paradigmatico per il suo modo di vedere nel barbaro le qualità del civilizzatore ma senza definire una adeguata distanza critica dal civilizzato.
La “mossa del cavallo” è il gesto necessario ad ogni mutazione. L’andare lateralmente per andare dritto. La ferita che tocca infliggere e infliggersi per progredire nella propria “vocazione”.
Leggendo Benjamin e McLuhan ci viene fatto capire che la velocizzazione della vita quotidiana ad opera della soggettività tecnologica dei moderni mette in gioco il barbaro in quanto discontinuità del civilizzato: il dispositivo ha funzionato per le avanguardie storiche e queste hanno funzionato per l’industria culturale di massa. E ora?
Bisogna avere paura della velocizzazione?
È più facile rispondere rovesciando la domanda: è la paura del soggetto moderno di perdere il controllo sulla vita quotidiana – su una vita quotidiana che sembra liquefarsi tra le sue mani – a farlo precipitare verso il proprio destino per mezzo di una eccezionale accelerazione delle sue stesse forme espressive? A questa domanda credo che si debba rispondere affermativamente. E includerei nella paura del soggetto moderno le paure delle singole persone che lo abitano: la paura quotidiana di perdere terreno o di essere invase riguardo alle piccole cose della vita pubblica e privata, familiare e istituzionale, interiore e esteriore.
Tutte le retoriche con cui letteratura e filosofia hanno affermato l’ideologia della “lentezza” sono falsa coscienza, e come accade per ogni eccesso di falsa coscienza, non fanno che accelerare ciò che vorrebbero frenare. Non fanno che andare all’origine della voragine temporale dell’identità. Sta qui – sul tempo dei mutamenti, sulla implicazione che essi hanno in campo politico – la questione che attraversa il dibattito presente tra chi vede nell’avvento delle reti l’imbarbarimento della società oppure la liberazione dai suoi vincoli, la rivoluzione dei suoi valori: la Civilizzazione “vera” in virtù del suo “giusto mezzo”.
Credo che a tale proposito sia necessario convincersi che i giudizi sulla natura positiva o negativa degli effetti delle reti siano misurati sull’idea – tipicamente moderna, progressista e civilizzatrice – di rivoluzione (azione politica tanto radicale da permettersi, grazie allo stato di necessità che la ispira, persino la revoca e sospensione delle sue qualità più umane e umanitarie): mutamenti dall’oggi al domani, da uno stato di diritto ad un altro.
Da una condizione di vita a un’altra, Idea, questa, peraltro alimentata dai ritmi dello sviluppo industriale a fronte delle epoche precedenti, oggettivamente assai distante dalla specifica qualità delle mutazioni antropologiche che caratterizzano l’abitare in rete: mutazioni che, in qualità se non in durata, richiamano invece i transiti plurimillenari dal regime dei raccoglitori al regime del culture stanziali. E via procedendo.
La prima parte del libro è dedicata al rapporto col dolore, la carne, il corpo, il “soggetto… Scrivi che “quello dei diritti civili è un campo dove è la sofferenza degli altri a fare da concime”. Non era il campo della civiltà, dell’alterità finalmente incontrata, quello dei diritti civili? Lo stesso dicasi per gli universali: se gli universali funzionano sempre meno, l’universalismo ne fa le veci… In sostanza, una società di simulacri non poteva che trasformare il diritto in simulacro. In questo senso, nessuno sembra aver colto il passaggio e le differenze tra alterità e diversità…
L’alterità non muta la sostanza, è la diversità a metterla in discussione. Una distinzione fondamentale è proprio quella tra il corpo, fisico e sociale, di un individuo e la carne che lo attraversa dell’interno all’esterno e viceversa: ci sono pagine di Roberto Esposito che mi hanno aiutato a comprendere meglio il significato di questa distinzione e a ritrovarla già pienamente realizzata in McLuhan, in cui la carne costituisce anche le rete di relazioni digitali in cui il corpo è immerso, spingendosi bel oltre la propria pelle.
La frase (più una sentenza e dunque brusca) “quello dei diritti civili è un campo dove è la sofferenza degli altri a fare da concime” vuole dire che i diritti procedono a prezzo di altri diritti: nasce proprio dalla scarsa mia convinzione sulle retoriche – apparentemente post-moderne e anti-moderne – sull’altro, scritto con a piccola o maiuscola che sia.
Ogni gioco sull’alterità che ci resiste o che tentiamo di negare, per quanto sia il frutto di una nobile e forse “utile” letteratura, a me sembra perfettamente organica al soggetto moderno, al suo progetto. Le analisi simmeliane e benjaminiane sulla metropoli e sullo “straniero” – il quale arriva ad abitare la città dall’esterno delle sue mura di cinta, là dove s’apre lo spazio di foreste, deserti, belve e disordine, diventando proprio grazie alla sua alterità soggetto propulsore della civiltà urbana – mi sembra bastino a cogliere i travestimenti ideologici che il soggetto moderno è stato capace di realizzare proprio in virtù, per mezzo, di tutto ciò che gli si oppone.
Ex Oriente lux, ex Occidente luxsus – ha detto, recentemente, Bergoglio, citando Stanislav Lec, che era però un umorista. Tu, che dell’immaginario del consumo ti sei occupato a lungo, scrivi che “l’Occidente sta ri-generandosi in chiave anti-moderna: anti-umanista, anti-sociale, anti-sapienziale”. Per un altro verso, però, “il ‘noi’ dei moderni sta cedendo dal proprio interno: estensione e intensità – le doti di un’identità forte – sono infatti risorse che creano potenza ma a prezzo di un’usura sempre più elevata che fa implodere la soggettività e le sostanze da loro beneficate”.
Diciamo che non è facile distinguere nelle turbolenze del presente tra processi disgregativi e processi di ricomposizione della modernità, tra processi rigenerativi e generativi dei suoi valori e dei suoi mezzi. Paradossalmente, si potrebbe dire che quanto più lo spirito moderno dovesse uscire dalla stretta in cui si è chiuso, tanto più sarebbe per così dire costretto a potenziare la propria tragedia invece del suo desiderio di pacificazione: e qui mi riferisco alla svolta presente e più ancora futura del capitalismo finanziario con la sua determinazione, volontà, di distruggere ogni istituzione della società moderna. Certo è che la volontà di potenza che si manifesta in questi processi costituisce anche le ragioni di una sempre più forte usura e stanchezza della natura umana.
La tecnologia delle reti costituisce l’unico versante radicalmente positivo – meglio dire oggettivo – di civiltà sempre più stanche di se stesse o di culture emergenti in quanto sempre più rapite in vortici simili a quelli che l’occidente ha consumato. La rete è al momento il teatro in cui le persone singole vanno esprimendosi negli spazi intermedi, liminari o nodali, tra chi se ne serve in termini di vecchi e nuovi poteri.
Le reti – i social network, facebook e quant’altro di virtuale e interattivo – rendono visibile le dimensioni di due opposti movimenti: sciami dal basso verso l’alto e informazioni dell’alto verso il basso. L’impero che, rispetto ad altri imperi calanti o nascenti, è più consapevole della propria decadenza, del suo tempo scaduto, a rischio, è quello della cristianità.
La pregnanza simbolica che hanno assunto Ratzinger e Bergoglio riguardo alla salvezza del genere umano, dimostra quanto questi movimenti dal basso e dall’alto possano sovrapporsi per contrasto. Il problema – la cosa che viene avanti – in ogni annuncio di Bergoglio al popolo dei credenti e dei non credenti (un impero è tale perché si ritiene sovrano anche al suo esterno) risulta sempre più chiaro: mira alla ricostruzione dal basso del potere di dio mediante la chiesa degli esseri umani.
Mentre invece Ratzinger è il papa che annuncia la rigenerazione di dio mediante la restaurazione della potenza universale della sua chiesa. Due immagini di uno stesso prisma: quella umana, intrisa di vita quotidiana e sottoposta al vento del tempo e quella celeste e insieme antidiluviana dell’Anticristo in quanto potenza che precede la salvezza.
La sofferenza. È da qui che dobbiamo ripartire? O l’infelicità come condizione antropologica ineludibile, che dobbiamo imparare a abitare? Ripensi da qui la questione del soggetto, come soggetto contingente?
Condizione antropologica ineludibile è la necessità per ciascuno di sopravvivere attraverso l’infelicità di qualcun altro. Dico necessità in quanto ineludibile condizione di bisogno di cui si nutre ogni essere vivente, ogni organismo. Quella condizione conflittuale, sino all’ultimo sangue, che la civilizzazione ha creduto di potere contenere sotto il manto di dispositivi di potere in grado di governarla, controllarla e asservirla. Vorrei evitare qualsiasi confusione con i principi di carità laica o cristiana che appunto dalla sofferenza altrui – del vicino che non gode dei tuoi stessi beni – fanno dipendere la propria visione del mondo e le proprie azioni, limitandosi ad una propria militanza personale e/o ad una propria partecipazione politica. In opposizione all’altruismo, quanto può apparire scandaloso mettere in primo piano la sofferenza a partire dal proprio esclusivo interesse? Persino le sacre scritture alludono a questo rovesciamento (“ama il tuo prossimo come te stesso”).
Desidero non soffrire e per fare questo devo ricorrere a dispositivi che limitino la sofferenza prodotta dal sistema di potere in cui vivo. Spesso, esplicitamente o implicitamente, il pensiero ha girato attorno a questa sorta di egoismo strumentale nella speranza che potesse essere una soluzione per la sofferenza collettiva. La fiducia nell’effetto placebo delle retoriche sul e del “benessere” come scopo della società, ne è un ingrediente. Il problema irrisolto è che il desiderio non ha confini e fa violenza anche sulla persona, sull’individuo che vuole salvarsi dal dolore di sé. Questi dimentica e rimuove il fatto di essere violenza proprio in quanto individuo. Quali siano le sue azioni.
In una società che ha visto fallire i suoi obiettivi primari – giustizia, uguaglianza, qualità della vita – si impone allora, direi oggettivamente, la realtà di una sconfitta, senza più vie d’uscita: la sconfitta dei valori ai quali i sistemi “occidentali” si sono storicamente ispirati. Dunque si tratta di una sconfitta dovuta a ciò che crediamo di essere. Sconfitta – pari al suo trionfo storico – dell’Umanesimo.
Di un sapere politico di lunghissima durata, capace di assorbire nei propri canoni ogni deviazione dai suoi principi fondativi facendo capo a una idea di essere umano di per sé “libero” e “eletto” per virtù civile e/o divina. L’idea di un antropocentrismo e di un individualismo assoluto della carne e dei corpi in cui siamo immersi. Sto usando la prima persona plurale, ma penso che la si possa usare solo negando ogni sua legittimità. È il “noi” del quale parlo nel mio saggio criticando la volontà di potenza individuale e insieme collettiva che esprime. La prima persona singolare che si arma della prima persona plurale e questa che si arma di uno stato o di una religione. Un tema ampiamente trattato, ma quasi mai risolto, dalla letteratura sulla crisi della democrazia, divisa com’è tra un “noi” ingiusto nei confronti di altri “noi” ed altri “io”. Tra l’individuo e il “noi” che gli è sovrano.
È proprio l’Umanesimo ad avere deteriorato la qualità delle classi dirigenti istruendole in ciò in cui non avrebbero dovuto credere e riducendo così ogni loro competenza e reputazione sul mondo reale che la realtà sociale, la realtà socialmente costruita, nasconde. La cultura umanista è causa del male che pretende di estirpare.

Map of Bohemia as a rose, with Prague at the centre, (Vetter and Kilian for Bohuslav Balbin’s History of Bohemia “zomb
Con i suoi contenuti non pare davvero possibile risolvere la crisi profonda di chi ha la responsabilità di affrontare, riparare e lenire una crisi epocale come quella presente. Insisto: sospetto, inefficace ed anzi dannoso il tentativo oggi prevalente, promosso su scala globale, di riqualificare le scienze umane con una iniezione di scienze “dure” (è questa l’ideologia, la filosofia strumentale, burocratica e manageriale, che sta distruggendo le istituzioni della formazione: dalla scuola all’università). Da dove ripartire? Da persone in cui siano messe in discussione le credenze che sono state loro inculcate, le idee che esse hanno appreso su se stesse e sugli altri. I valori su cui si sono formate.
Ecco un modo non ideologico di prendere coscienza dell’avvento delle reti. L’idea di un soggetto contingente è il possibile derivato della dimensione poietica che le reti, pur attraversate dalle grandi dorsali della soggettività moderna, stimolano in ogni dove.
Sono lo spazio di fondamentali trasformazioni del modo di sentire e pensare procedendo attraverso le cose del mondo e della sua carne per mezzo di pratiche esperienziali assai più che sapienziali. Tanto che i “dotti” – Umberto Eco, appunto – percepiscono sempre più come insulse le chiacchiere dei nativi del web. In merito a questa mutazione, vado cercando di adeguarmi.
Sto tentando di farlo, senza ancora riuscire a superare un livello troppo sintetico, povero, e molto approssimativo: vorrei almeno arrivare a scrivere e dire senza più carichi bibliografici e eccessivi impianti teorici, anche perché sono convinto che ormai bisognerebbe farne a meno, così da arrivare alle scelte essenziali che il nostro fine d’epoca impone. Dalla elaborazione dei contenuti e motivazioni del “che fare”, gli ignoranti sono stati sempre inevitabilmente esclusi per essere tuttavia inclusi solo a misura della forza delle loro passioni.
La persona, duenque. Se per ogni fase di smarrimento delle certezze sui cui basare le proprie azioni si sente il bisogno di trovare un valore inemendabile da cui ripartire, la domanda è questa: cosa c’è di certo, di assolutamente indiscutibile, su cui basarsi?
Quale è il “fatto” che i delusi dal relativismo post-moderno e della sua “debolezza” pretendono di ricostruire? Quale è la verità che non ha bisogno di dimostrazione?
È qui che si colloca una riflessione sulla sofferenza e la morte. Sul dolore della carne. Il dolore che appartiene tanto al carnefice quanto alla vittima. Il disagio e la morte che riguardano qualsiasi identità. Amica o nemica che sia per l’altra.
A me pare che il teatro di una riflessione su questa sola certezza umana non possa che essere la persona. Intendo per persona (etimologicamente “nessuno”) quella entità, senza di per sé doti e attributi, che assume un carattere, una qualità individuale, la qualità di individuo, solo in virtù delle “voci” che – riempiendo la virtualità del suo vuoto e da esso attratte – fanno vivere la natura altrimenti impenetrabile, anonima, della sua “maschera” puramente biologica, della sua “macchina” animale, del suo sistema neuronale.
La persona si fa individuo situandosi e incarnandosi in una serie di dispositivi antropologici, ambientali, familiari, formativi, culturali, esperienziali, storici, sociali, territoriali, e via dicendo, che è impossibile disporre in un ordine sequenziale poiché si tratta delle “concorrenze” di una continua attività combinatoria, autopoietica, destinata a costruire l’identità della persona.
A farla parlare e agire. È dall’insieme di lungo periodo di queste “concorrenze” che la civilizzazione ha progressivamente ricavato dalle persone individui e dagli individui soggetti. Certo è che la formazione, in questo transito da persona a individuo e da individuo a società svolge un ruolo specifico, determinante o meno che sia. Sarebbe urgente creare le condizioni di una inversione di marcia. Come? Partire dall’esperienza comune della sofferenza e del dolore che la persona “patisce” a ragione delle sue stesse passioni. Della violenza che ha in comune con se stessa e con i sistemi sociali.
La persona non sfugge ed è anzi alla base della violenza espressa da ogni essere vivente a causa della sua necessità di sopravvivenza. La persona produce dunque violenza nelle sue relazioni con l’altro che gli abita accanto, e in tal modo altera e corrompe l’agire stesso degli apparati sociali modificando i loro fini anche quando questi – pur inscritti nella falsa coscienza e nello spirito coercitivo dell’occidente – si propongano scelte orientate a valori e pratiche tese a moderare la conflittualità, ridurre gli squilibri, migliorare la vita quotidiana.
La violenza dei singoli – ad esempio il cieco familismo e clientelismo, la esasperazione dei conflitti di genere dentro e fuori della famiglia, la competizione per motivi di carriera, di potere personale, di interesse, l’egoismo e culto della propria persona – non può che far deviare il corpo sociale anche quando virtuoso, che si tratti di istituzioni, stati, partiti, movimenti, in quanto vi produce una serie di turbative a catena. I risultati di un partito o di una azione amministrativa o di un governo o di una università ne saranno irreparabilmente trasformati in peggio del peggio.
È impossibile non accorgersi che la “morte” della politica di cui tanto si parla, la sua debolezza e inefficacia quali siano i fini che essa si propone, dipendono in larghissima misura dalle sue divisioni interne in interessi personali. Forma di potere, la politica, minata dai rapporti di potere che se la contendono.
Il grande dibattito sulla necessità di compensare la crisi di reputazione e responsabilità dei nostri ceti dirigenti privilegia l’idea di rafforzare e riqualificare i contenuti della formazione scientifica e professionale, partendo dal concetto di persona di cui s’è detto in termini di primato umanista – credendo quindi che il problema si risolva, si possa risolvere, riqualificando gli stessi contenuti della soggettività storicamente e socialmente data, sviluppando gli stessi saperi e metodi di una medesima cultura di appartenenza.
Protraendo lo stesso soggetto dell’umanesimo anche quando aggiornato, armato di nuove teorie e tecniche (che, diciamocelo sinceramente, sono pericolosissime se messe in mano ai moderni, ai civilizzatori). Nessuna consapevolezza o dichiarazione del fatto che, se le nostre classi dirigenti sono così clamorosamente fallite – tanto più a fronte della complessità del presente, del carattere sostanzialmente inedito della crisi in atto e a venire – il motivo, come ho detto, non può che essere il fallimento dei modelli tradizionali di formazione basati sull’umanesimo. Sul suo carattere esclusivo e insieme universalista.
Prima di arrivare a formare professionisti capaci, bisognerà allora formarne la loro vocazione: essa viene prima e non dopo. Dunque bisogna formare persone prima di formare ruoli sociali. E questo difficile salto di qualità non può che essere praticato attraverso una radicale critica dell’umanesimo e di tutte le sue “illusioni” di felicità a venire: ripensare gli effetti della modernità alla luce della sofferenza e morte che ha prodotto e continua a produrre.
Nessun “principio speranza”. Prendere le distanze dalle azioni che la società ci obbliga a compiere e, se inevitabile per il soggetto che incarniamo dentro e fuori di noi, compierle almeno senza più illusioni.
Tentando così di contribuire alla riduzione del loro danno attraverso il raffreddamento della fiducia e partecipazione che impongono.
[cite]
philosophy and social criticism
issn: 2037-0857
creative commons license this opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license.
based on a work at www.tysm.org


