Rousseau: alienazione e utopia
Luciano Parinetto
Come si rileva nella prefazione dell’edizione roussoiana della Pléiade (e come hanno ricordato, anche in Italia, Alatri e Colletti): [1] « numerosi uomini politici africani o asiatici si sono messi a leggere Rousseau nel momento in cui i loro paesi accedevano all’indipendenza […]; eminenti uomini di Stato vietnamiti, guineani, senegalesi, ecc., hanno affermato che le loro carriere erano state orientate verso la politica dalla lettura delle opere di Rousseau; e infine […] Fidel Castro ha dichiarato a un giornalista francese che Jean-Jacques era stato il suo maestro e che egli aveva combattuto Batista con il Contratto sociale in tasca». [2]
Si tratta di una Rousseau-Renaissance che, certo, non si richiama al Rousseau sentimentale, irrazionalista, protoromantico o, addirittura, cattolico caro a non pochi interpreti reazionari; e neppure al Rousseau scolasticamente castrato e ridotto a semplice ed innocuo pedagogista, ma a quel Rousseau che – come egli stesso scrive nelle Confessioni – aveva visto «que tout tenait radicalement à la politique, et que, de quelque façon qu’on s’y prît, aucun peuple ne serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait être»;[3] e che – giusta l’interpretazione di Kant, ricordata anche da Cassirer – aveva tanto radicalmente risolto il problema della teodicea da… eliminarlo, sganciando completamente il problema dell’emancipazione dell’uomo da quello dell’esistenza della divinità e della sua giustizia e provvidenza. L’uomo roussoiano, infatti, per dirla con Cassirer, invano attenderebbe redenzione «da aiuti esteriori. Nessun Dio ce la può dare; l’uomo deve divenire il salvatore e il creatore di se stesso…».[4]
Si tratta di una espressione che curiosamente richiama un’analoga frase dell’Internazionale ricordata qualche decennio fa da Lukàcs proprio per caratterizzare la radicale a-religiosità dell’uomo dopo Marx: «Dio, la natura divina, il principio trascendente non ha più nessuna influenza e non può avere influenza sulla vita degli uomini. L’uomo deve dunque rassegnarsi: l’unico che possa dargli un’esistenza sensata, è lui stesso; in questa lotta per una vita più sensata, come dice l’Internazionale, nessun Dio lo può aiutare…».[5]
Certo, non si può pretendere di ridurre Rousseau ad un ateo o ad un a-religioso (la filosofia della religione occupa, anzi, nella sua opera – come ha ricordato anche Colletti – [6] un ruolo rilevante); tuttavia è pur vero che nonostante la religione civile e la professione di fede del vicario Savoiardo, l’uomo che egli ci propone cade autonomamente nel peccato della diseguaglianza ed altrettanto autonomamente può proporre la possibilità di redimersene (entrando a far parte dello stato della volontà generale) come se dio neppure esistesse o come se non si prendesse a cuore il destino politico dell’uomo, che, in Rousseau, finisce per coincidere con la totalità del destino umano.
L’uomo roussoiano si trova dunque – non meno dell’uomo marxiano, anche se in prospettiva diversa, – ad essere arbitro assoluto di se stesso, ed è strano che finora questa convergenza tematica non sia stata sottolineata, ed anzi, da parte marxista (da Della Volpe, per esempio) si sia preferito riportare l’uomo naturale di Rousseau ad una metafisica radice platonico-cristiana che, a mio avviso, rischia di fraintenderne la reale carica rivoluzionaria, nonché di rendere incomprensibile il fascino che esso tuttora esercita su chi opera per ottenere una società radicalmente nuova e disalienata.[7] Per il Platone de La repubblica, infatti, l’uomo, su questa terra, è del tutto deterministicamente ed inflessibilmente obbligato a seguire modelli di vite (τά τωυ βίών παραδείγματα)[8] che ha scelto (se così si può dire, visto che quei modelli non sono infiniti ma solo «assai più numerosi» di coloro che stanno scegliendo) prima di venire al mondo e dei quali è schiavo.[9] Non è dunque autocreatore di se stesso nella storia. Per Rousseau, invece, l’uomo va concepito in maniera sostanzialmente storicistica: «L’homme est un, je l’avoue; mais l’homme modifié par les religions, par les gouvernements, par les lois, par les coutumes, par les préjugés, par les climats, devient si different de lui méme, qu’il ne faut plus chercher parmi nous ce qui est bon aux hommes engénéral, mais ce qui leur est bon dans tel temps ou dans tel pays».[10]
L’uomo naturale, poi, non è una οὐσία, una substantia, un’anima, ma un progetto, un modello, uno schema alla luce del quale proporre un radicale mutamento della società presente.
Per Rousseau, l’uomo artefice di se stesso e del proprio destino nella collettività è colui che è stato in grado – mediante quella specie di epochizzazione che è consentita dal risolutivo confronto della categoria dell’uomo naturale con l’oggi socio-economico immerso nella diseguaglianza di prospettare la rivoluzione che deve portare alla società giusta del Contratto sociale. Perciò la categoria dell’uomo naturale non può essere disgiunta da quelle – altrettanto fondamentali in Rousseau – di alienazione e di diseguaglianza ed ha un rilievo utopico evidente, anche se pochi ancora l’hanno riconosciuto.
Ha quindi totalmente torto Cassirer quando tradisce lo spirito e la lettera del Discorso sull’origine della diseguaglianza contrabbandando come ineguaglianza fisica (e quindi, per Rousseau, irrilevante e comunque non toglibile) l’ineguaglianza della proprietà e facendo del tema della proprietà privata e della diversa ripartizione dei beni un problema che in Rousseau «assume un’importanza secondaria»,[11] laddove, in verità, si tratta della leva dei principali motivi rivoluzionari del pensiero roussoiano, per questo, tra l’altro, oggi tanto in auge.
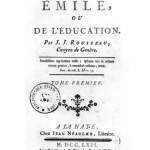 Come è noto, prima di Rousseau, il verbo alienare e il termine alienazione hanno – presso gli economisti – il generico significato di cessione, vendita, trasferimento di proprietà.
Come è noto, prima di Rousseau, il verbo alienare e il termine alienazione hanno – presso gli economisti – il generico significato di cessione, vendita, trasferimento di proprietà.
Sono espressioni intese negativamente dal giusnaturalisti poiché significano per essi la perdita della libertà originaria dell’uomo al momento della stipulazione del contratto che lo immette in società. Per essi, dunque, alienazione ha anche il significato di mutamento e questo mutamento può assumere – per esempio in Hobbes – il senso di una traslazione dallo stato di natura. allo stato di diritto (in questo caso tirannico) che trasforma l’uomo primitivo in uomo civile.
La stratigrafia dei significati del termine alienare diventa più complessa in Rousseau, nei cui scritti – oltre alle su citate implicazioni economiche e politiche – acquista anche sfumature etiche e filosofiche che preludono – almeno in parte – alla complessa molteplicità di allusioni che il termine assumerà in Fichte, Hegel, Feuerbach e Marx: complessità che, ai nostri giorni (è un segno dei tempi!), diventa, in diversi ambiti filosofici, genericità, confusione e talvolta copertura ideologica.
Sul piano politico, anzitutto, l’alienazione ha, per Rousseau, un valore positivo che è il simmetrico opposto di quello che il termine assumeva in Hobbes, dove, infatti, l’alienazione si presenta come il principale veicolo della costruzione dello stato assolutistico. Invece per Rousseau, essa è il veicolo stesso della libertà e della indipendenza dell’uomo.
Secondo l’esposizione del Contratto sociale, gli uomini primordiali allorché gli elementi che contrastano la loro conservazione nello stato di natura prevalgono sulle forze di cui ciascun individuo dispone, devono, per conservarsi, associarsi mediante una reciproca cessione di diritti, le cui clausole sono riassumibili nella seguente: «aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté». [12] Ma questa alienazione, ben più che alla radice della primordiale comunità umana, va considerata come schema-progetto per la trasformazione dell’uomo ( inserito in una collettività fondata sulla diseguaglianza) nell’uomo libero ed eguale della comunità della volontà generale, evocata utopicamente nel Contratto sociale.
Ciò che per Rousseau consente all’uomo primordiale (e a quello della diseguaglianza) il toglimento dei propri predicati essenziali in quelli – altri – veramente politici, è appunto quella alienazione mediante la quale «chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons encore chacque membre comme partie indivisible du tout».[13]
L’atomismo egoistico dell’individuo in situazione presociale (od anche in situazione socio-politica di diseguaglianza) viene dunque superato mediante l’alienazione sulla quale si fonda la polis giusta (non una realtà, ma un progetto da attuare nel futuro, anche se in Rousseau, mediante un πρόρоν-ϋστερον tipicamente utopico, essa spesso assume la maschera nostalgica della polis repubblicana greco-romana o quella, meno stimolante, della originaria repubblica ginevrina), vale a dire «un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté ».[14]
Questa persona collettiva, questo io intersoggettivo (la cui traslazione gnoseologico-metafisica prenderà il nome della kantiana appercezione trascendentale e del fichtiano io puro), è popolo, stato, volontà generale che tende al bene comune e la cui sovranità «ne peut jamais s’aliéner». [15]
Trascurando, per ora, l’interessante accenno ad un disegno di movimento dialettico, insito nello schema: stato di natura-alienazione-toglimento dell’alienazione nel moi commun (e non per trovarvi -come nell’Anti-Dühring engelsiano, giustamente criticato da Della Volpe, l’esempio di quel «gran numero di quelle svolte dialettiche di cui si serve Marx» e che in Rousseau gia si rinverrebbero « con la differenza di un capello»; non per scoprire, per l’ennesima volta, che, ridotti ad uno schema generale ed astratto, tutti i movimenti dialettici si rassomigliano, da Platone a Mao; bensì Per indicare una delle possibili concrete e controllabili fonti della dialettica hegeliana), è senz’altro da rilevare che la nozione roussoiana di alienazione riguarda soprattutto e immediatamente l’ambito sociologico (che tuttavia, in Rousseau, si presenta in guisa di totalità) e che è da intendere soprattutto come un valore positivo, costituendo la radice stessa della possibilità di autosussistenza della collettività statale.
E tuttavia questa nozione rivela – ad uno sguardo meno approssimativo – significati che possono essere considerati come veri e propri precorrimenti della complessa tematica dell’alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx.
Che si tratti di anticipazioni non casuali è dimostrato dal fatto che la lettura di opere di Rousseau incide radicalmente sulla formazione del pensiero, oltreché di Kant e di Fichte, anche di Hegel. E fra gli inediti Kreuznacher Exzerpte marxiani del 1843 si sa che, oltre a quello dello spinoziano Trattato teologico politico, v’è un riassunto del roussoiano Contratto sociale le cui annotazioni sarebbero certo preziose per stabilire esattamente quale fu l’influenza del Rousseau politico sul giovane Marx. [16]
È noto, per esempio, che la primitiva formulazione hegeliana della dialettica è affidata alla categoria della positività, che sostanzialmente è costruita sull’analisi del divenir-altro della polis antica e del cristianesimo originario: temi, come si vedrà, anch’essi tutt’altro che lontani dall’ambito di pensiero roussoiano.
A questo proposito è da notare che proprio il significato del divenir-altro è uno dei più tipici già della nozione roussoiana di alienazione.
Si veda, a questo proposito, il capitolo Du législateur (VII del libro II) del Contratto sociale, non a caso considerato emblematico dal Marx della Questione ebraica. In esso il legislatore (vale a dire la leva che trasforma la volontà atomistica in volontà generale), è assai significativamente definito come
«celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple» e pertanto «doit se sentir en état da changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui même est un tout parfait et solitaire en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale à l’existance physique et indépendante que nous avons reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte àl’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui». [17]
Mutamento (changer), trasformazione (transformer), alienazione (altérer), sostituzione (substituer), toglimento (ôter), estraneazione (ôter à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères) sono dunque tutti significati che, prima che in Hegel, Feuerbach e Marx, la nozione di alienazione presenta già in Rousseau, sia pure, ovviamente, in senso peculiaramente roussoiano vale a dire in quanto valori positivi, legati alla liberazione e non alla servitù dell’uomo: l’uomo primordiale (o anche diseguale), snaturato ed estraniato mediante l’alienazione roussoiana infatti diventa, per essa, autentico cittadino.
Qui, dunque alienazione (oppostamente che in Marx) è quasi sinonimo di rivoluzione: un termine che negli Enciclopedisti aveva ancora un significato aveva ancora un significato prettamente astronomico e che in Rousseau, pur non escludendo il significato (li mutamento politico, sia in senso progressista che in senso reazionario, [18] esprime anche il mutamento fisico [19], il mutamento temporale, [20] il mutamento sociale (per esempio, l’inizio della proprietà privata), [21] il mutamento tecnologico, [22] la μμετάνοια sentimentale. [23]
Mi pare, quindi, che abbia ragione Mario Rossi, quando rileva «che Rousseau ha distinto alienazione da estraneazione, ha dimostrato che nella società preborghese l’alienazione è estraneazione, asservimento, e ha proposto l’istanza di sostituire l’alienazione-estraneazione con una alienazione riappropriazione si’ che ciascuno, unendosi a tutti, non obbedisca che a se stesso e resti libero come prima»; e «che la categoria dell’alienazione [ … ] viene sviluppata da Rousseau in senso rivoluzionario (come estraneazione, asservimento, che sollecita l’istanza dell’emancipazione)». [24]
Si potrà semmai discutere, invece, se quel senso rivoluzionario sia totalmente da collocare (e da esaurire) nella «ideologia borghese rivoluzionaria», [25] o se il suo lievito utopico – proprio perché considerato dopo Marx – non conservi ancora qualche carica.
Se, nel Contratto sociale, Rousseau prospetta il termine alienazione sul piano politico e si mostra perfettamente consapevole dell’importanza di definirne non equivocamente il significato («Il y a là bien de mots équivoques qui auroient besoin d’explication; mais tenons-nous-en à celui d’aliéner»),[26] non è detto che quel termine, in altre opere, non si arricchisca di nuovi significati.
Nella Nuova Eloisa (un romanzo epistolare che abbastanza equamente Diderot definì – in faccia all’autore stesso – feillu, «c’est à dire chargé de paroles et redoutant», come afferma lo stesso Rousseau, che a sua volta non esita a collocarlo fra i «livres efféminés qui respiraient l’amour et la mollesse») [27] per esempio, la categoria di alienazione trova applicazione anche alle analisi del campo erotico.
Anticipando quella totale dislocazione nell’altro che Hegel e Feuerbach considereranno anche nel campo della psicologia religiosa (ma di Hegel bisogna tener conto anche del giovanile frammento Sull’amore, la proprietà e la corporeità, dove l’alienazione di ciascuno degli amanti porta al superamento della loro singola determinatezza nel totum dell’unificazione uno dei personaggi principali della Nuova Eloisa scrive a Giulia – individuando uno dei nessi fondamentali della psicologia erotica -: «lo non mi appartengo più, lo confesso, la mia anima alienata vive tutta in te. Così sono anche più capace di sentire le tue pene, e più degno di condividerle».[28]
Se qui l’alienazione è pur sempre una forma di cessione, si tratta, tuttavia – a differenza che nell’alienazione politica – di un divenir altro che introduce al pathos erotico, a una pena d’amore in cui Rousseau gia rileva la ambívalente unità di piacere e dolore («Uno dei miracoli dell’amore è il piacere che proviamo soffrendo»). [29]
D’altra parte anche nel rapporto erotico legalizzato nel matrimonio, ha luogo -secondo Rousseau – un’alienazione: in esso – scrive Giulia – [30] la donna «deve render conto della sua condotta a un altro; ha non soltanto impegnato la sua fede, ha alienato la sua libertà».
Anche il dolore è qui veicolo della alienazione.
Per esempio, nelle malattie inguaribili dell’uomo, «tutte le sue facoltà sono alienate dal dolore, e siccome il male è senza rimedio, egli non ha più l’uso della sua volontà né della sua ragione».[31] Nello stesso senso, Giulia morente allude alla sua « anima alienata». [32] Nelle Confessioni, d’altra parte, il verbo alienare è anche inteso nel senso di mutare un sentimento 0 un legame affettivo nel suo opposto.
Rousseau per esempio, usa il verbo alienare secondo questo significato quando descrive i tentativi di Diderot e Grimm di mettergli contro i suoi stessi famigliari. In questa situazione essi «semblèrent prendre tache d’aliéner de moi les Gouverneuses (Teresa Le Vasseur e sua madre), leur faisant entendre que si elles n’etaient pas plus à leur aise c’était mauvaise volonté de ma part…» . [33]
Alienare – in questo stesso testo – significa ancora estraniare in senso negativo, allorché Rousseau allude al suo radicale distacco dalla madre di Teresa («Toutes ces réflexions aliénèrent enfin mon cœur de cette femme, au point de ne pouvoir plus la voir sens dédain». [34]
In un contesto simile il termine alienazione viene eguagliato a quello di rivoluzione inteso come fenomeno psico logico, μμετάνοια, conversione all’opposto del sentimento: «je redevins craintif, complaisant, timide en un mot le même Jean-Jacques que j’avais été auparavant. Si la révolution n’eût fait que me rendre à moi même et s’arrêter là, tout était bien; mais malhereusement elle alla plus loin et m’emporta rapidement à l’autre extrême». [35]
Alienazione, nel vocabolario roussoiano, può anche essere intesa come toglimento in senso negativo: «Toute intémperance est vicieuse, et sourtout celle qui nous ôte la plus noble de nos faculté. L’excès du vin dégrade l’homme, aliène au moins sa raison pour un temps, et l’abrutit à la longue». [36]
Ma, se torniamo alla Nuova Eloisa, l’aspetto del divenir altro presente nel termine alienazione è destinato ad uno sviluppo sinfonico quando Rousseau considera quella che per Marx sarà una delle cause fondamentali dell’origine dell’alienazione della divisione del lavoro: la differenziazione e l’opposizione città-campagna. [37]
Si legge, nella Nuova Eloisa, « Il primo svantaggio delle grandi città è che gli uomini diventano diversi da quello che sono, e che la società assegna loro per così dire un altro essere». [38]
Siamo qui in presenza di una alterazione ben diversa da quella che compie il legislatore secondo il Contratto sociale: si tratta di uno snaturamento che porta l’uomo all’infelicità ed all’imperfezione e non alla libertà nella volontà generale. È, infatti, un’alienazione intenzionata alla diseguaglianza. Quella dell’alienazione cittadina è una analisi che sta molto a cuore a Rousseau che – nei panni di Saint Preux – ce ne dà una larga fenomenologia.
Il campione paradigmatico esaminato in proposito è Parigi: quella Parigi in cui Saint Preux si reca a vivere, abbandonando la Svizzera, che, nel contesto, assume il ruolo, altrettanto paradigmatico della campagna in quanto contrapposta alla città. La tipicità della contrapposizione è sottolineata da milord Edoardo, che scrive a Saint Preux: «Le prime vostre osservazioni si sono fissate su gente semplice e quasi appena uscita dalle mani della natura, quasi per servirvi da termine di paragone. Esiliato nella capitale del popolo più celebre dell’universo, siete per così dire balzato all’estremità opposta…». [39]
La metropoli come estremità opposta dello stato di natura – vale a dire come fase culminante dell’alienazione negativa – ci viene descritta come un luogo che, ideologicamente, occulta sotto una superficiale e solo apparente uguaglianza la sostanziale diseguaglianza e lo snaturamento dell’uomo, poiché, mentre i campagnoli (più vicini alla natura) sono ancora «uomini che pensano con la propria testa», la metropoli attua «l’uniformità degli abitanti della città, dove ognuno si mostra eguale agli altri piuttosto che come realmente è», sicché, se dei campagnoli si può dire che «il loro cuore e il loro spirito non sono deformati dall’arte; non hanno imparato a conformarsi ai nostri modelli, e non c’è rischio di trovare in loro l’uomo dell’uomo invece dell’uomo della natura»;[40] dei cittadini, invece, nonostante la superficiale uniformità che li caratterizza, si deve dire che sono individui scissi: in città «gli uomini ai quali si parla non sono quelli coi quali si conversa; i sentimenti non gli nascono dal cuore, i loro lumi non gli stanno nello spirito, i loro discorsi non esprimono i loro pensieri, di loro non si scorge altro che l’aspetto esterno, e in una società uno si trova pressappoco come davanti a un quadro mobile, nel quale il pacifico spettatore è l’unico essere semovente».
«Non ho ragione – esclama Saint Preux -di chiamar deserto quella folla, e di spaventarmi d’una solitudine nella quale altro non trovo che una vana apparenza di sentimenti e di verità, un’apparenza che muta a ogni istante e si distrugge da sé, nella quale non vedo altro che larve e fantasmi che colpiscon la vista e dileguano non appena si cerca di afferrarli?». [41]
L’uomo alienato dallo stato di natura in una società ingiusta, l’uomo artificiale, l’uomo dell’uomo estraniato non è più dunque uomo, ma larva d’uomo, miserabile fantasma e l’uomo in qualche modo più vicino alla natura (se in quella situazione è ancora possibile rinvenirne) a sua volta è minacciato dall’estraneazione, poiché si trova solo in quel deserto di maschere.
L’uomo fantasma sopra descritto è definito da Rousseau borghese ed è accuratamente distinto dall’uomo libero e dal cittadino [42] i quali, tuttavia, se immersi nell’alienazione della metropoli, possono a loro volta perdersi in essa, «provare l’ebbrezza che questa esistenza agitata dà a coloro che la vivono» e possono sentirsi storditi «come un uomo davanti agli occhi del quale si fanno scorrere rapidamente una quantità di oggetti».
Esclama Saint-Preux: «Non uno di quelli che mi colpiscono mi parla al cuore, ma tutti insieme lo turbano e ne sopprimono gli affetti, tanto che a momenti dimentico persino chi sono e a chi appartengono. Ogni giorno uscendo di casa metto sotto chiave i miei sentimenti, per assumerne altri, convenienti ai frivoli oggetti che mi aspettano. Insensibilmente giudico e ragiono come vedo che tutti giudicano e ragionano. Se qualche volta tento di scuoter via i pregiudizi e di vedere le cose come sono, ecco che subito mi aggredisce una verbosità che potrebbe somigliare a un ragionamento. Mi si dimostra con la massima evidenza che soltanto il semifilosofò considera la realtà delle cose; che il vero sapiente non le considera che sulle apparenze; che deve prendere i pregiudizi per principi, le convenienze per leggi; che la sublime sapienza consiste nel vivere come i pazzi. In tal modo costretto a mutar l’ordine delle mie affezioni morali; costretto a stimare delle chimere e a far tacere la natura e la ragione: vedo deformare il divino modello che porto dentro di me e che insieme era oggetto dei miei desideri e regola delle mie azioni…». [43]
Di questa situazione alienata Rousseau vede molto bene che la donna porta il peso ancora più acutamente dell’uomo. Ed infatti alla caratteristica alienazione delle borghesi parigine egli dedica molte interessanti analisi. [44]
Ma, in questo caso, l’alienazione cittadina non fa che sommarsi all’alienazione caratteristica della condizione femminile se e vero che anche una donna sensibilissima, come Giulia, alla natura, non estraniata dall’abitare in città, ammette che «affettare sensibilità nel turbine delle passioni; fingersi lieta e contenta pure in preda a mille pene; con l’anima agitata aver volto sereno; dir sempre l’opposto di quanto si sente; esser falsa per dovere, e bugiarda per modestia: questa è la condizione solita di qualsiasi ragazza della mia età. In tal modo trascorrono i giorni più belli sotto la tirannia delle convenienze». [45]
Se la tirannia delle convenienze aliena anche la donna di campagna, la metropoli borghese riduce l’uomo a manichino da palcoscenico e sulle stesse scene riproduce l’uomo parziale che essa crea. Vi sono pagine molto interessanti in cui Rousseau denuncia la falsa totalità dell’uomo rispecchiato dalla commedia borghese-metropolitana: «Ora si copiano nel teatro le conversazioni d’un centinaio di salotti parigini. Fuori di li non s’impara niente dei costumi francesi. In questa grande città ci sono cinque o seicentomila anime delle quali non si fa mai parola sulla scena. Molière ebbe l’ardire di dipingere borghesi e artigiani non meno che marchesi; Socrate faceva parlare cocchieri, falegnami, calzolai, muratori. Ma gli autori d’oggi son gente d’altra levatura, si stimerebbero disonorati se sapessero cosa capita nella bottega d’un mercante, nell’officina d’un operaio… ». [46]
è quasi una denuncia del teatro cittadino come teatro di classe!
Comunque questo teatro è anche una spia efficace dell’alienazione borghese: « Sulla: scena come in società, si ha un bell’ascoltare quanto si dice, non si sa mai niente di Ciò che si fa; e del resto perché saperlo? Non appena uno ha parlato, chi mai va a informarsi della sua condotta, non ha forse fatto quanto doveva fare, non è forse giudicato? Il galantuomo qui non è colui che fa buone azioni, ma colui che dice belle cose… ». [47]
Nella Lettre à M. D’Alembert (sugli spettacoli), Rousseau ha insistito sulla alienazione del teatro borghese, delineandone anche un’alternativa.
Anzitutto si tratta veramente di un’alienazione, nel senso della disclocazione dell’altro, in quanto la disposizione comune dello spettatore pare consistere nel «bésoin d’attacher incessamment son coeur sur la scène, comme s’il étoit mal à son aise au dedans de nous». [48]
È un «amusement étranger» in senso pregnante, poiché estrania, invece di collegarlo, il singolo dalla collettività: «L’on croit s’assembler au spectacle, et c’est là que chacun s’isole; c’est là qu’on va oublier ses amis, ses voisins, ses proches, pour s’intéresser à des fables, pour pleurer les malheurs des mortes, ou rire aux dépens des vivants».[49]
Quello che ha di mira polemicamente Rousseau – secoli prima di Brecht – è dunque anche il carattere culinario, digestivo del teatro, che, pur distanziandosi dallo spettatore (tout ce qu’on met en représentation au théâtre, on ne l’approche pas de nous, on l’en éloigne), [50] nello stesso tempo non lo pone in vigile situazione critica, ma lo dà in pasto alla peggiore soggettività, poiché, «le thêátre, qui ne peut rien pour corriger les meurs, peut beaucoup pour les altérer. En favorisant tous nos penchants, il donne un nouvel ascendent à ceux qui nous dominent; les continuelles émotions qu’on y ressent nous énervent, nous affoiblissent nous rendent incapables de résister à nos passions». [51] Ed è proprio questa arrendevolezza incontrollata alle sensazioni soggettive che può servire da tramite per l’ideologizzazione dello spettatore, nel quale uno spettacolo può inoculare la prona sopportazione di un assetto sociale alienato.
Se si legge – nello stesso scritto – la polemica valutazione roussoiana del Misanthrope di Molière, non come un giudizio moralistico, ma come una lucida analisi del mecanismo di una ideologizzazione dello spettatore, il parere di Rousseau sembrerà, se si vuole, discutibile, ma, comunque indubbiamente suggestivo.
Molière, cioè, secondo Rousseau, s’è messo, in questa commedia, dal punto di vista dei signori e dei padroni; ha descritto chi è scontento di questo mondo (cioè dell’assetto del mondo che è loro utile) come un pedante e lo ha messo in ridicolo, contrapponendogli la moderazione e la dolcezza di Filinto, il portatore del positivo nel dramma. Ma Filinto è un personaggio che può permettersi di essere moderato, di non essere acerbamente critico della società in cui vive, proprio perché è un ricco, un padrone.
«Ce Philinte est le sage de la pièce; un de ces honnêtes gens du grand monde dont les maximes ressemblent beaucoup à celles des fripons; de ces gens si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien, parce qu’ils ont intérêt que rien n’aille mieux; qui sont toujours contents de tout le monde, parce qu’il ne se soucient de personne; qui, autour d’une bonne table, soutiennent qu’il n’est pas vrai que le peuple ait faim; qui, le gousset bien garni, trouvent fort mauvais qu’on déclame en faveur des pauvres; qui, de leur maison bien fermée, verroient voler, piller, égorger, massacrer tout le genre humain sans se plaindre, attendu que Dieu les a doués d’une douceur très méritoire à supporter les malheurs d’autrui». [52]
Se, a questo punto, si usa il metro roussoiano di valutazione del teatro, vale a dire il criterio secondo il quale « les s ‘ectaclès sont faits pour le peuple et ce il est que par leurs
par leurs effets qu’on peut déterminer leurs qualités absolues» [53] apparira indiscutibilmente fondato il giudizio negativo sul Misanthrope, che si rivela una scuola per accettare i padroni.
Se, attraverso la magia dello spettacolo, lo spettatore con Filinto, rappresentato simpaticamente e non come il misantropo, rappresentato come un assurdo ed inaccettabile pessimista, allora coinciderà col punto di vista di classe padronale, di quel personaggio: si alienerà in esso. E’ vi si alienerà con la complicità di un alienato, poiché a differenza di Diderot, Rousseau ritiene che il ruolo dell’attore non sia che un «trafic de soi même, quelque chose de servile et de bas», [54] nel quale egli va perdendo l’umanità poiché proprio l’abilità che «le rend propre à les sortes de personnages», il suo ésprit stesso, lo pone «hors le plus noble de tous, celui d’homme, qu’il abandonne». [55]
Rousseau chiarisce questa valutazione con un paragone fra l’oratore e l’attore: «L’orateur [ … 1 ne représent que lui même, il ne fait que son propre rôle, ne parle qu’en propre nom, ne dit ou ne doit dire que ce qu’il pense; l’homme et le personnage étant le même être, il est à sa ce, il est dans le cas de tout autre citoyen qui remplit l’onctions de son état. Mais un comédien sur la scène, étalant d’autres sentiments que les siens; ne disant que, ce on lui fait dire, représentant souvent un être chiméri, s’anéantit, pour ainsi dire, s’annule avec son héros; dans cet oubli de l’homme, s’il en reste quelque chose, est pour être le jouet des spectateurs». [56]
Annichilimento, oubli de l’homme, riduzione ad essere per l’altro (lo spettatore), queste le caratteristiche dell’alienazione dell’attore.
Che tuttavia, non è che un aspetto della generale alienazione del teatro.
Poiché Rousseau è dell’avviso – radicalmente utopico – che il teatro stesso (almeno nel suo aspetto presente) vada tolto.
E la nuova forma di spettacolo da lui prevista è radicalmente altra perché osa proporre un’inversione arditissima: «donnez les spectateurs en spectacle; rendez-les acteurs eux-mêmes». [57]
Si tratta della rivoluzionaria sostituzione della festa allo spettacolo teatrale che, abbastanza provocatoriamente, Jacques Derrida ha paragonato al teatro della crudeltà di Artaud. [58]
O, piuttosto, della magistrale profezia di quello che il teatro sarà in una collettività liberata dalla diseguaglianza capitalistica, vale a dire, non più obbligata ad obliarsi-ideologizzarsi in un teatro che sorge sulla Trennung dalla vita, ma immersa, col tramite del teatro festa, nel centro stesso della vita sociale, in indissolubile Vereinigung con essa.
«Ne faut il donc aucun spectacle dans une république? Au contraire, il en faut beaucoup. C’est dans les républiques qu’ils sont nés, c’est dans leur sein qu’on les voit briller avec un véritable air de fête A quels peuples convient il mieux de s’assembler souvent et de former entre eux les doux liens du plaisir et de la joie, qu’à ceux qui ont tant raison de s’aimer et de rester à jamais unis? [ … ] Mais n’adoptons point ces spectacles exclusifs qui renferment tristement un petit nombre de gens dans un antre obscur; qui le tiennent craintifs et immobiles dans le silence et l’inaction; qui n’offrent aux yeux que cloisons, que points de fer, que soldats, qu’affligeantes immages de la servitude et de l’inégalité. Non, peuples heureux, ce ne sont pas là vos fêtes. C’est en plein air, c’est sous le ciel qu’il faut vous rassembler et vous livrer aux doux sentinierits de votre bonheur […]. Mais quels seront enfin les objets de ces spectacles? Qu’y montrera t on? Rien, si l’on veut. Avec la liberté, partout où règne l’affluence, le bien être y règne aussi. Plantez au mileu d’une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez y le peuple, et vous aurez une fête. Faites mieux encore: donnez les spectateurs en spectacle; rendez les acteurs eux mêmes; faites que chacun se voie et m’aime dans les autres, afin que tous en soient mieuxunis». [59]
Per dirla con le parole di un famoso “nemico” di Rousseau: «verrà il momento cui l’arte degli artisti sarà assorbita nel bisogno di feste degli uomini: l’artista solitario che espone la propria opera sarà scomparso: essi allora sarano in prima fila tra coloro che hanno inventiva per la gioia e per le feste». [60]
Quest’idea di teatro tolto in festa collettiva e repubblica, in cui «tout devient commun à tous», [61] pur appoggiandosi all’utopia retrovolta πόλις della spartana o all’utopizzata campagna svizzera, è, in realtà, la profezia dell’autocelebrazione d’una collettività liberata dall’alienazione della proprietà privata.
Una profezia che ha tentato di adempiersi forse con la festa dell’ente supremo di Robespierre; che, ai nostri giorni, pareva parzialmente adempiersi non certo nel teatro della crudeltà di Artaud, non a torto demistificato da Marcuse, [62] ma nei festivals degli hyppies e che, comunque, indica un luogo ancora utopico, dopo la rivoluzione, un luogo dove «tout devient» gioiosamente «commun à
tous , dove si fa l’amore e non la guerra.
Niente quindi di più crudamente altro, rispetto alla festa profetizzata da Rousseau, del teatro borghese specchio fedele della borghese scissione fra apparire ed essere fra parlare ed agire che riconduce ad una più basilare Trennung, alla profonda diseguaglianza sociale di cui Parigi è quasi un paradigma figurato, significativo anche perché presuppone la scissione citta campagna dalla quale nasce anche il teatro borghese.[63]
«In realtà scrive Saint Preux Parigi è probabilmente la città nella quale le fortune sono più diseguali, dove insieme regnano la più festosa opulenza e la miseria più deplorevole». [64]
È dunque l’osservatorio più utile per constatare come non si edifica una democrazia: «Dans une democratie, ou les sujets et le souverain ne sont que les mêmes hommes considérés sous différents rapports, sitôt que le plus petit nombre l’emporte en richesses sur le plus grand, il faut que l’Etat périsse […] Alors le gouvernement n’a plus de force, et le riche est toujours le vrai souverain. Sur ces maximes incontestables il reste à considérer si l’inégalité ii’a pas atteint parmi nous le dernier terme où elle peut parvenir sans ébranler la république». [65]
C’era dunque qualcosa di marcio nella repubblica elvetica (oltre che a Parigi), ma, anche qui, si trattava di un paradigma che serviva a illuminare tutte le situazioni di diseguaglianza economica, anche quella in cui il capitalista arcaico può dire al lavoratore con un’ironia che non è sfuggita al Marx del Capitale:[66] «Permetterò che voi abbiate l’onore di servirmi, a condizione che mi diate il poco che vi resta in cambio della fatica che sostengo nel comandarvi»!
In questo testo dell’Economia politica, come in altri, del Discorso sull’origine della diseguaglianza e della stessa Nuova Eloisa, Rousseau è uno dei primi espliciti testimoni non solo del nesso proprietà privata-diseguaglianza socio-politica (il testo del II Discorso è troppo celebre perché qui lo si ripercorra analiticamente), ma, preludendo a Hegel e a Marx, della dialettica dipendenza del padrone dal servo.
L’uomo -scrive, per esempio, nel II Discorso – «a causa di una quantità di nuovi bisogni», è «asservito per così dire a tutta la natura, e soprattutto ai suoi simili, di cui in un certo senso diventa schiavo anche quando ne diviene il padrone: se è ricco ha bisogno dei loro servizi…». [67]
Non solo la proprietà privata (un’istituzione di cui Rousseau – in maniera opposta all’apologetica dell’economia borghese – mostra l’origine storica in una violenza sopraffattrice che può essere tolta solo col toglimento di quella forma di proprietà stessa) è alla radice della dicotomia sociale servo-padrone; essa provoca anche quelle profonde antinomie (segnalate sempre nel II Discorso) che possono essere considerate come il più vicino precorrimento roussoiano della nozione marxiana di alienazione nel senso che mostrano come – nella situazione di diseguaglíanza – ciò che l’uomo crea per progredire nella civiltà gli si rivolti contro come una potenza estranea e nemica e lo domini.
«Le catene della servitù – dice, per esempio, il II Discorso – si sono formate soltanto per opera della mutua dipendenza degli uomini ».[68]
La giustizia di classe – per fare un’esempio tratto dallo stesso testo non è che il risultato del progetto del padrone «di usare a suo stesso vantaggio le forze stesse i coloro che lo assalivano, di trasformare i suoi avversari in suoi difensori, di ispirare loro delle altre massime e di dare loro delle altre istituzioni che gli fossero altrettanto favorevoli quanto il diritto naturale gli era contrario».[69]
E gli esempi potrebbero essere moltiplicati.
Quello che importa notare, a questo punto, ritornando alla Nuova Eloisa, è che in Rousseau, assieme al precorrimento della nozione di alienazione marxiana, è presente anche la preparazione dell’analisi dell’ideologia.
Essa è strettamente legata all’estraneazione metropolitana ed alla divisione del lavoro.
Se, infatti, l’alienazione della città è anch’essa conseguenza di ciò «che sa tentare l’umana industria per cavare l’uomo civile da una solitudine nella quale nulla gli manca e tornare a immergerlo in un abisso di nuovi bisogni» [70] e questa creazione di bisogni fittizi si collega la moltiplicazione sempre più capillare della divisione del lavoro, è fatale che la società si divida in classi.
«Presso i Romani e presso i Greci gli stessi uomini erano ufficiali in campo, magistrati in città, e mai codeste due funzioni furono meglio riempite che allorché erano gli strani pregiudizi che le separano e le disonorano» oggi, osserva, per esempio, Rousseau. [71] L’analisi dell’ideologia è appunto appoggiata alla separazione e all’opposizione delle classi all’interno del corpo sociale.
Nella Nuova Eloisa si possono leggere – a questo proposito – affermazioni parzialmente anticipatrici come le seguenti: «Non occorre conoscere il carattere delle persone, ma soltanto i loro interessi per indovinare a un dipresso che cosa diranno su ogni cosa. Quando un uomo parla, non è lui ma per ì dire è il suo abito che esprime tiri parere; e ne muterà senza tante storie mutando di stato.
Dategli successivamente una lunga parrucca, un’uniforme d’ordinanza o una croce pettorale: lo sentirete successivamente predicare con pari zelo le leggi il dispotismo e l’inquisizione. Esiste una comune ragione per la toga, un’altra per la finanza, un’altra per la spada. Ognuna dimostra benissimo che le altre due sono cattive, conseguenza che è poi facile applicare a tutte e tre. In questo modo nessuno mai dice cosa pensa, ma che cosa è opportuno che faccia pensare agli altri, e in loro l’apparente zelo per la verità, non è mai altro che la maschera dell’interesse. Crederete magari che almeno le persone private e indipendenti avranno un loro modo di pensare: niente affatto; sono anche loro macchine che non pensano, e che si fanno pensare meccanicamente». [72]
Se nella prima parte di questo testo ciò che (con un ϋστερου-πρότερου storico forse non molto plausibile) si è definito – certo in modo impreciso – ideologia si mostra nell’aspetto di coscienza falsa (e naturalmente a proposito delle classi che poteva avere sott’occhio Rousseau), nella seconda parte appare evidentemente come falsa coscienza (cfr. l’immagine delle macchine che non pensano e che si fanno pensare).
È poi da sottolineare la definizione della ragione di classe come ragione relativa al proprio ambito sociale, cioè come maschera dell’interesse del ceto cui inerisce e come strumento essenziale a far pensare gli altri non secondo il punto di vista della totalità sociale ma secondo un’interesse parziale.
Qui – evidentemente – Rousseau (e Herder non sarà da meno) dimostra di non credere, come invece la χοιυή illuministica, in un’unica Ragione.
E, tanto meno, in una ratio del dominio sul tipo di quella ipotizzata da Horkheimer e Adorno in Dialettica dell’illuminismo. La sua ragione è, infatti, una dialettica unità di razionalità e sentimento (che quindi vieta ogni interpretazione di tipo irrazionalistico, sentimental-romantico) e forse proprio per questo può additare il limite ideologico del rapporto ragione-classi sociali.
Occorre poi sottolineare che, se anche Rousseau non giunge certo ad affermare (come il Marx della Prefazione a Per la critica dell’economia politica) che «non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza»;[73] tuttavia è assai vicino ad una simile configurazione di classe della coscienza, quando, per esempio, afferma nel Discorso sulle ricchezze, che «potrebbero esservi delle cause che fanno cambiare modo di pensare agli uomini col mutare del loro stato», sicché, «vostro malgrado le vostre idee e i vostri principi cambieranno con la vostra condizione e […] vostro malgrado, quando non sarete più quello che siete non penserete più come pensate oggi».[74]
È da notare ancora che Rousseau fa portatori della coscienza falsa i notabili delle classi analizzate, mentre considera succubi della falsa coscienza le persone private e indipendenti.
Risultato di questa situazione ideologica è – ancora una volta – un’alienazione: in questo caso la cessione della facoltà di pensare e di giudicare: «In questo modo ci sono altri pochi uomini e poche donne che pensano per tutti gli altri e per conto dei quali tutti gli altri parlano ed agiscono».[75]
Sicché chi voglia vivere nella metropoli borghese e conservare indipendenza di giudizio è obbligato ad assumere una maschera che si configura come un’ulteriore alienazione. Deve, cioè, «mutare di principi come muta di società, modificare il proprio spirito quasi ad ogni passo, e adattare le proprie massime all’apparenza. Bisogna che ad ogni visita si spogli della propria anima, se ne ha una; che ne indossi un’altra dei colori della casa, così come un servo indossa una livrea; e che allo stesso modo la lasci uscendo e se gli pare ripigli la sua propria fino alla prossima occasione. Ma c’è di più; ognuno si mette continuamente in contraddizione con se stesso, senza che nessuno ci trovi a ridire».[76]
Rousseau vede benissimo che la radice di tutte queste contraddizioni è l’assetto della società capitalistica, la cui legge è «accumulare incessantemente»[77] contro gli altri, poiché, «come è possibile arricchirsi senza contribuire a impoverire gli altri?».[78]
Ed è dalla insaziabile avidità del capitalismo (sia pure qui ancora arcaico) che discendono tutte le contraddizioni della società su esso costruita: «Moltiplicate le porte di ferro, le serrature, le catene, le guardie, i sorveglianti, innalzate dovunque forche, ruote, patiboli, immaginate ogni giorno nuove torture, indurite la vostra anima alla vista di tutte le sofferenze dei poveri, istituite cattedre e collegi ove si insegnino solo i principi che vi fanno comodo; attirate, pagate sempre nuovi scrittori per rendere ancor più ínfame il furto commesso dal povero e ancor più rispettato quello commesso dal ricco; immaginate ogni giorno nuove distinzioni per autorizzare nell’uno e punire nell’altro le medesime azioni sotto nomi diversi. Ma siate certi che la vostra insaziabile avidità non servirà che ad alimentare quella degli altri, che le vostre furfanterie non faranno che accumulare intorno a voi una folla di altri bricconi che ve le restituiranno malgrado le vostre precauzioni e la vostra esperienza».[79]
La legge della progressiva accumulazione, che Rousseau non indaga teoreticamente, ma che descrive, con indignazione morale formidabile, nella sua fenomenologia, riporta l’uomo a quello che era per Hobbes lo stato originario: l’uomo è lupo per l’altro uomo. Ma questo stato originario non è, in realtà, che la società capitalistica, un regno ferino, in cui anche la beneficenza, lungi dal togliere l’accumulazione, ne è ancella e le serve, anzi, da copertura morale[80] e in cui l’ideologia travisa tutto, asservendo a sé, con l’educazione e la cultura, le coscienze.
Si tratta di una fenomenologia dell’ideologia che ha i suoi fondamenti in testi roussoiani più noti (il I e il II Discorso, per esempio), nei quali le sovrastrutture culturali vengono strettamente connesse alla base economica e alla classe sociale della cui conservazione risultano funzioni.
E forse l’immagine marxiana che paragona l’alienante sovrastruttura religiosa a dei fiori immaginari che occultano le catene (strutturali) che inchiodano l’uomo al suo servaggio[81] è derivata proprio dal I Discorso roussoiano, laddove, a proposito della sovrastruttura culturale della società della diseguaglianza, si dice appunto che «les sciences et les arts, moins despotiques (du gouvernement) et plus puissants peut être, étendent des guirlandes defleurs sur les chaînes de fer dont ils (les hommes) sont chargés». [82]
Come forse potrebbe essere di origine insospettatamente roussoiana la famosa immagine che paragona la religione all’oppio per il popolo.
Si legge, infatti, nella Nuova Eloisa, che «la devozione è un oppio per l’anima». [83]
Certo, i precorrimenti marxiani di Rousseau non si esauriscono a quel poco cui abbiamo accennato: Della Volpe e, più recentemente Colletti, hanno, in proposito, aperto delle prospettive che vanno accolte ed approfondite.
Meno evidenziato è stato, invece, il nesso Rousseau-Hegel, sul quale val la pena di soffermarsi brevemente.
Se risponde a verità (come testimonia a più riprese l’attendibile e sempre importante Rosenkranz, che aveva sotto gli occhi «alcuni estratti da Rousseau che hanno un aspetto molto piacevole» del giovanissimo Hegel del periodo di Tubinga) il fatto che già nello Stift il futuro autore della Fenomenologia leggesse Le confessioni ed altri testi roussoiani che poteva consultare anche nella biblioteca ducale; [84] se è vero come ha affermato Jean Hyppolite – che l’itinerario della coscienza nella Fenomenologia è ispirato ad un processo-prospettato anche nel Bildungs-Roman
dell’epoca -di conquista del vero mediante il pedagogico passaggio attraverso l’errore (scambiato in un primo momento per il vero stesso), processo, tra l’altro, riportabile
anche all’iter che si svolge nell’Emilio roussoiano, che «Hegel avait lu… à Tubingen» e che appunto considerava «le rapport entre l’évolution de l’individu et l’évolution de l’espèce»,[85]come, più tardi, la Fenomenologia; allora si ha la prova della rilevante importanza che -non solo pel formativo periodo giovanile –la lettura di Rousseau riveste nei riguardi dei principi del pensiero hegeliano.
A mio avviso – cosa che non ha sottolineato neppure il Lukàcs del Giovane Hegel – l’impostazione originaria che assume la dialettica hegeliana è debitrice in buona parte a letture roussoiane.
È noto che il motore stesso della dialettica hegeliana è il divenir-altro, l‘alienazione intesa in questo senso senso. Ed è noto – come si e detto – che le prime analisi hegeliane del divenir-altro si svolgono col ricorso alla categpria di positività che è appunto la prima forma che assume in Hegel la nozione di alienazione. La categoria di positività nel giovane Hegel, lungi dall’essere il risultato di astratti pensamenti della riflessione, è, al contrario, sulla scorta di analoghe indagini di Lessing e di Herder, un concreto strumento di indagine filosofica, politica e storiografica insieme che, permettendo una ricostruzione attendibile del passato, spiega attraverso di esso il presente infelice e prospetta un futuro che sia radicalmente altro da esso.
Positività, in altre parole, è l’originarsi del divenir-altro di istituzioni politiche e religiose nel senso del loro sclerotizzarsi, del loro ossificarsi, del loro divenir opposte rispetto a come si presentavano originariamente, del loro divenire oppressive dell’uomo mentre all’inizio ne tutelavano la libertà.
Le analisi giovanili hegeliane della positività vertono soprattutto sul divenir altro del cristianesimo e della polis repubblicana greco-romana: un divenir-altro che si riflette nell’oggi scisso in cui l’uomo ha perso la dimensione della politicità e – mercé il cristianesimo – scambia una parte di sé (la propria soggettiva singolarità atomistica, isolata dai necessari ma occultati rapporti con la collettività e falsamente autonomizzata) per un tutto.
Se è vero che nell’indagine sul divenir altro del cristianesimo il giovane Hegel aveva alle spalle le riflessioni di Lessing e di Kant sulla trasformazione – ad opera dei discepoli – della religione del Cristo in quella sul Cristo; non pare dubbio che nell’indagine sul divenir altro delle πόλεις antiche e sulla responsabilità che per questo divenir-altro aveva assunto il cristianesimo egli sia debitore di Rousseau, ed in particolare dello straordinario capitolo finale del Libro IV del Contratto sociale.
È infatti «nell’ultimo capitolo del Contrat Social («De la religion civile») che Rousseau, elaborando, alla luce del nesso singolo-stato, la dottrina della religione civile e tracciando una rapida fenomenologia degli aspetti delle varie religioni che si sono presentate nella storia per quanto riguarda il loro rapporto con la collettività statale, presenta delle analisi sulla religione nazionale antica, sulla religione di Gesù, sulla religione dell’uomo, su quella del cittadino e su quella del prete, nonché sullo spirito del cristianesimo, in cui il criterio (positivo o negativo) di giudizio è enucleato dalla tendenza che hanno tali religioni a connettere o a separare l’individuo alla sua comunità: è dunque una valutazione che lega strettamente il problema della religione e quello dell’alienazione, e che in molte formulazioni (per es. il giudizio su Gesù, il quale «fit que l’Etat cessa d’être un», o quello che connette «l’ésprit du christianisme» ad una situazione di schiavitù: «Le christianisme ne prêche que servitude et dépendence… Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves», e di scissione dell’uomo religioso dall’uomo che vive in collettività: «république chrétienne: chacun de ces mots exclut l’autre») rappresenta senza dubbio il luogo di nascita della stessa meditazione giovanile hegeliana sull’alienazione; insieme, ovviamente, alle influenze che su di essa hanno potuto esercitare le analisi lessinghiana e kantiana [ … ] e naturalmente alle annotazioni fichtiane sulla Ubertragung (trasposizione) e sulla Entäusserung (alienazione) che l’esperienza religiosa compie, dislocando fuori della coscienza, nella divinità, ciò che riguarda invece l’ambito della coscienza stessa». [86]
Ma un testo se possibile ancor più straordinario (e finora, per quel che ne sappia, mai adeguatamente segnalato) a proposito della radice roussoiana della dialettica hegeliana si rinviene proprio all’inizio di quell’Emilio che Hegel avait lu à Tubingen.
Si tratta, in questo caso, della sovrapposizione – quanto mai pre hegeliana – del tema della scissione e poi conciliazione tolta dell’intero e del tema socio-politico del rapporto uomo collettività.
Vale la pena citare il brano per esteso: «L’homme naturel est tout pour lui; il est l’unité numérique, l’entier absolu, qui n’a de rapport qu’à lui-même ou à son semblable. L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l’unité commune; en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. Un citoyen de Rome n’était ni Caïus, ni Lucius; c’était un Romain…». [87]
Per Rousseau, dunque -se usiamo le parole di Alatri – [88] «una volta stabilito che la fonte del male è l’ineguaglianza e che la società esistente è basata sull’ineguaglianza, e una volta appurato che all’ideale e ipotetico stato di natura – che non conosceva l’ineguaglianza – non è possibile tornare, perché quella condizione, seppure è mai esistita, e comunque irrecuperabile, non resta altra strada, per la rigenerazione dell’ umanità, che quella di cambiare radicalmente la natura della società, rifondarla su nuove basi, darle come fondamento un Datto che le assicuri, nello stato di aggregazione, gli stessi vantaggi di cui l’uomo avrebbe goduto prima che quello sato di aggregazione sociale si fosse stabilito».
Un simile progetto – indubbiamente foriero di rivoluzione – è impiantato su uno schema inconfondibilmente dialettico (e, si diceva, quanto mai pre hegeliano) in quanto fa iniziare il processo da un‘unité numérique o enlier absolu (uomo naturale) che si aliena, si altera, divien-altro, nell’unité fractionnaire (uomo sociale della diseguaglianza), la quale, a sua volta , mediante un toglimento (notare i pregnanti termini dénaturer, ôter, transporter che anticipano la complessità della nozione hegeliana dell’Aufhebung) viene superata nell’unité commune (cittadino della volontà generale), che conserva l’unité originaria, ma tolta in modo che essa non sia più l’assoluta e atomistica unité numérique della posizione primordiale, ma le moi dans l’unité commune, del momento che giustificataniente potrebbe venir definito come negazione della negazione.
Ancora da notare è il fatto che la posizione rappresenti una totalità solo in sé (l’homme naturel est tout pour lui), un absolu solo soggettivo e che, mediante la scissione, la separazione del momento della negazione (unité fractionnaire) si giunga alla vera, autentica, assoluta totalità oggettiva del momento della negazione della negazione (chacque particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité et ne soit plus sensible que dans le tout).
Notevolissimo pure il fatto che il contenuto di una siinile dialettica non sia affatto uno schema logico formale ma – proprio come nel giovane Hegel – la storia del verificarsi di una positività socio politica e del suo toglimento. Non mi pare neppure casuale che il testo citato concluda con l’esempio del romano repubblicano, cioè dell’uomo in cui non è ancora germinata la scissione dell’individuo dal cittadino che è – come direbbe il Marx del 18 Brumaio – una resurrezione dei morti decisamente non archeologica, bensì utopica, carica di futuro rivoluzionario, ansiosa di ricostituire nella sua unità – non più originaria ma vagliata dalla storia – l’uomo scisso all’epoca della decadenza delle poleis antiche e consacrato e confermato, nella sua dilacerazione, dal cristianesimo.
A questo punto mi sembra indubbio si possa affermare abbastanza tranquillamente che non e neppure un caso che il giovane Hegel – lettore di Rousseau – nello scoprire la dialettica abbia ripercorso la medesima strada di un maestro che – almeno in gioventù – gli fu tanto caro.
Nel contempo apparirà chiaro che quella rivoluzione che in Germania camminava sulla testa (cioè nella dialettica e nelle idee dei filosofi) mentre in Francia procedeva sui piedi (cioè nelle cose) non è atomisticamente isolabile, perché anzi aveva avuto per padrino quello stesso Rousseau che aveva tenuto a battesimo la stessa rivoluzione francese dandole per svegliarino l’utopia dell’uomo naturale.
Il concetto-progetto dell’uomo naturale roussoiano si fonda su una concezione del progresso che – a prima vista – potrebbe essere scambiata per reazionaria.
Cancellare tutta la storia della civiltà – alla luce dell’uomo naturale – affermando che si tratta della storia della progressiva diseguaglianza (e quindi alienazione) dell’uomo, non è tuttavia un tornare indietro. Solo chi intenda il concetto di Progresso come continuità temporale comunque buona potrebbe affermarlo. Ma, come ha ben chiarito Ernst Bloch, quest’ultimo concetto potrebbe benissimo coincidere col « feticcio di un semplice succedersi » e giustificare perfino il trionfalismo di una classe senza fiuturo come quella che nell’imperialismo celebra le sempre nuove fasi del capitalismo, come se ad esso fossero ancora aperte infinite esclusive carriere, come carte da giocare di fronte al socialismo. [89]
La concezione discontinua che della storia presenta invece Rousseau, se paradossalmente proponeva «la soppressione dell’incivilimento sino allora raggiunto, come un triste tratto di tempo a paragone del felice evo remoto, lo stato naturale», pur essendo un concetto «astratto, assurdamente esagerato, sottolineava, tuttavia, gli esistenti regressi dell’avvicendarsi contro una assolutamente astratta idolatria della successione del tempo in sé», [90] era cioè un preveggente preservativo anche di ogni concezione deterministica della rivoluzione di tipo socialdemocratico da Seconda Internazionale e soprattutto ambientava l’utopia dell’uomo naturale in una prospettiva della storia a salti e a rotture che è indubbiamente congeniale al discorso escatologico o rivoluzionario.
Ma la dimensione escatologica dell’uomo naturale roussoiano non è stata finora sufficientemente sottolineata.
Nonostante i testi roussoiani siano abbastanza chiari, in proposito, e nonostante ormai molti interpreti contemporanei – e si cita per tutti lo Starobinski- abbiano sostanzialmente rettamente inteso il carattere di concetto-progetto dell’uomo naturale e dello stato di natura di Rousseau, pochi hanno insistito sul carattere utopico di questa fondamentale nozione.
Paolo Casini, per esempio, scrive che Rousseau «nello sforzo di costruire la sua ipotesi, ne ammette esplicitamente il carattere utopistico e congetturale; e si richiama alle analoghe ipotesi che i geologi formulano sulla evoluzione del globo (è chiara l’allusione alla recentissima teoria della terra di Buffon)». [91]
Per una simile interpretazione è dunque logico che l’uomo roussoiano «allo stato di pura natura» appaia «proiettato nel passato», [92] ma si tratta di un rovesciamento ottico, poiché l’uomo roussoiano non è utopistico bensì utopico, e come tale si proietta non nel passato ma nel futuro.
Come Marx ha perfettamente riconosciuto (nel già richiamato Diciotto Brumaio), talora i ritorni al passato sono gravidi di futuro. Talora l’ideologico sogno della resurrezione della πόλις antica o dell’Antico Testamento sono validi stimoli alla reale prospettazione nel futuro di rivoluzioni. In questi casi l’ideologia si rovescia in utopia.
L’uomo naturale di Rousseau è uno di questi casi, è un πρότερου-ϋστερου, è talmente un non-essere-ancora, talmente proiettato nel futuro che pare inattingibile (un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes), [93] eppure su lui si deve orientare qualsiasi intrapresa che tenda a togliere l’uomo della disuguaglianza dal suo stato e a renderlo libero ed uguale nella volontà generale mediante quel contratto sociale che, a sua volta, non c’è mai stato e non c’è ancora.
È importante non confondere – come han fatto Voltaire e tanti altri, più o meno interessatamente, dopo di lui – l’uomo naturale, questo progetto utopico, con l’uomo primordiale o col buon selvaggio, di cui pure Rousseau parla a lungo e volentieri, quasi a voler dimostrare che v’è stata e v’è -in qualche remota parte del mondo – un’umanità che potenzialmente, imperfettamente, è più adeguata di quella della civiltà della diseguaglianza al progetto dell’uomo naturale e che dunque questa nozione non è assurdamente utopistica, che l’uomo può prospettarla e che alla luce di questa prospettiva può promuovere la rivoluzione della società presente.

Utopia, numero 3 (marzo 1972)
Insistere – come ha fatto Della Volpe (che, del resto, con Rousseau e Marx, aveva scritto un testo vivo, brillante e per nulla accademico) – sulla provenienza platonico-cristiana della metafisica persona naturale di Rousseau e nel contempo non coglieme la carica utopica significa castrare il pensiero roussoiano della prospettiva rivoluzionaria.
Che quest’uomo – come ha giustamente rilevato il Marx della Questione ebraica – sia stato interpretato dalla borghesia radicale della rivoluzione francese e da Robespierre come un atomo (e dunque ancora in seno all’alienazione), non vuol dire altro che il pensiero borghese ha interpretato riduttivamente –a propria immagine e somiglianza – la nozione roussoiana.
Anzi, proprio in Marx si può rinvenire un ricorso del roussoiano uomo naturale in quell’uomo onnilaterale che forse non a caso – i Manoscritti economico-filosofici del 1844 collegano all’utopia della resurrezione della natura, tema quanto mai roussoiano.
Come in Rousseau, in questo Marx il tema dell’utopia e quello della natura si incrociano ed è un peccato che Della Volpe, che ha tracciato una sia pur opinabile linea di collegamento tra il Marx della Critica del programma di Gotha e Rousseau a proposito del grande tema del diritto diseguale del quale dovrà fruire il cittadino liberato dalla diseguaglianza, abbia trascurato di vedere come quella nozione sia collegata al concetto di uomo onnilaterale.
Tra l’altro, interpretare in prospettiva utopica l’uomo naturale roussoiano, permette anche di coglierne il radicale valore epochizzante.
A questo proposito mi pare che abbia torto Bernard Groethuysen a considerare la soluzione roussoiana del ritorno all’uomo naturale e quella del Contratto naturale come le «deux solutions du conflit auquel il était en proie… née d’un même esprit d’opposition», [94] poiché, in realtà, se si considera l’aspetto epochizzante dell‘uomo naturale, non si tratta che di un’unica soluzione.
In altre parole, l’uomo naturale è la categoria con la quale Rousseau mette tra parentesi quanto nella società della diseguaglianza non risulta che incrostazione di successive alienazioni e con la quale fa quindi emergere un modello di uomo disalienato, razionale, che, contestando il presente e il passato (e la loro diseguaglianza) può proporsi di atturare una società razionale, basata sul contratto sociale. L’una nozione risulta così indissolubilmente legata all’altra, come del resto – e sarebbe suggestivo approfondire il confronto – in Marx l’uomo onnilaterale (sia nei Manoscritti del ’44, sia, ancora una volta, nel Capitale) è legato alla razionalizzazione dei rapporti della collettività umana con se stessa e con la natura.
Note
Una prima versione del saggio è apparsa, con il titolo “Alienazione e utopia in Rousseau”, sul mensile Utopia (anno II, numero 3, marzo 1972, pp. 8-16). Una seconda versione, notevolmente ampliata e da cui traiamo il testo, con il titolo “Prologo in Rousseau” costituisce il primo capitolo di Nostra signora dialettica (Luciano Pellicani editore, Roma 1991).
[1] Cfr. Paolo Alatri, Introduzione a Gian Giacomo Rousseau, Scritti politici, UTET, Torino 1970, p. 46; cfr. anche Lucio Colletti, Rousseau critico della “società civile” in Id., Ideologia e società, Laterza, Roma-Bari 1970, p. 196.
[2] Cfr. Paolo Alatri, cit., p. 46.
[3]Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, 1, Oeuvres autobiographiques, Aux éditions du Seuil, Paris 1967, p. 277.
[4] Cfr. Ernest Cassirer, Il problema Gian Giacomo Rousseau, traduzione di Maria Albanese, La nuova Italia, Firenze 1968, p. 54 e 59.
[5] Cfr. Wolfgang Abendroth, Hans Heinz Holz e Leo Kofier, Conversazioni con Lukàcs, De Donato, Bari 1968, p. 76.
[6] Cfr. Lucio Colletti, oltre al saggio sopra citato, soprattutto Idea della società cristiano borghese in Id., Il marxismo e Hegel, Laterza, Roma-Bari 1969.
[7] Cfr. Galvano Della Volpe, Critica dell’uomo astratto in Rousseau, in Id., Rousseau e Marx, Editori Riuniti, Roma 1962, pp. 19-40.
[8] Cfr. Platone, La repubblica, versione di Francesco Gabrieli, Sansoni, Firenze 1950, p. 379.
[9] Ibid.
[10] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert (sugli spettacoli) in Id., Du contrat socíal, Garnier, Paris 1954, p. 134.
[11] Cfr. Ernest Cassirer, op. cit., p. 38.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, cit., p. 243.
[13] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, cit., p. 244.
[14] Cfr. Idem.
[15] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, cit., p. 250.
[16] Si può vedere la lista dei luoghi roussoiani riassunti nell’inedito marxiano in Marx-Engels, Gesamtausgabe, Erste Abteilung Band 1 Zweiter Halbband, Berlino 1929, pp. 120-121.
[17] Jean- Jacques Rousseau, Du contrat social, cit., p. 261.
[18] Cfr., per esempio, il Discorso sulla diseguaglianza, Universale economica, Milano 1949, p. 15 e p. 96.
[19] Cfr. ibidem, p. 46.
[20] Cfr. ibidem, p. 51.
[21] Cfr. ibidem, p. 72.
[22] Cfr. ibidem, p. 77.
[23] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Giulia o la nuova Eloisa, Rizzoli, Milano 1964, pp. 282-283.
[24] Cfr. Mario Rossi, La formazione del pensiero politico di Hegel, Feltrinelli, Milano 1970, p. 228; Il sistema hegeliano dello stato, Feltrinelli, Milano 1970, p. 161.
[25] Cfr. Cfr. Mario Rossi, Il sistema hegeliano dello stato, cit., p. 288.
[26] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, cit., p. 239.
[27] Cfr.Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, cit., p. 292 e 289.
[28] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, La nuova Eloisa, cit., p. 113.
[30] Cfr. ibidem, p. 261.
[30] Cfr. ibidem, p. 274.
[31] Cfr. ibidem, p. 409.
[32] Cfr. ibidem, p. 742.
[33] Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, cit., p. 268.
[34] Cfr. ibidem, p. 283.
[35] Cfr. ibidem, p. 282.
[36] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., p. 210.
[37] Cfr. Marx-Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 21: «La divisione del lavoro diventa una divisione reale solo dal momento in cui interviene una divisione fra il lavoro manuale e il lavoro mentale». A pagina 40: «La più grande divisione del lavoro materiale e intellettuale è la separazione di città e campagna».
[38] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, La nuova Eloisa, cit., pp. 289-290.
[39] Cfr. ibidem, p. 548.
[40] Cfr. ibidem, pp. 578-579.
[41] Cfr. ibidem, pp. 251-252.
[42] Cfr. ibidem, p. 259.
[43] Cfr. ibidem, pp. 271-272.
[44] Cfr. ibidem, pp. 282-294.
[45] Cfr. ibidem, p. 227.
[46] Cfr. ibidem, p. 268.
[47] Cfr. ibidem, p. 271.
[48] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., p. 133.
[49] Cfr. ibidem, p. 134.
[50] Cfr. ibidem, p. 141.
[51] Cfr. ibidem, p. 168.
[52] Cfr. ibidem, pp. 152-153.
[53] Cfr. ibidem, p. 134.
[54] Cfr. ibidem, p. 186.
[55] Cfr. ibidem, p. 187.
[56] Cfr. ibidem.
[57] Cfr. ibidem, p. 225.
[58] Cfr. Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, a cura di Gian Renzo Morteo e Guido Neri, Einaudi, Torino 1968, p. XXVII.
[59] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., pp. 224-225.
[60] Cfr. Friedrich Nietzsche, Scelta di frammenti postumi dell’inverno 1879-1880, in Id., Aurora, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Mondadori, Milano 1971, p. 265.
[61] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., p. 226.
[62] Cfr. Herbert Marcuse, Controrivoluzione e rivolta, traduzione di Silvia Giacomoni, Mondadori, Milano 1973, p. 135. Artaud afferma che il teatro deve andare per le strade, verso le masse; deve sconvolgere crudelmente e distruggere la coscienza e l’ inconscio compiacenti: lo spettatore deve essere travolto dal teatro come da un turbine di forze superiori. Ma Marcuse chiede: «Oggi, quale mai linguaggio, quale mai immagine può frantumare e ipnotizzare spiriti e corpi che in pacifica coesistenza (a volte traendone addirittura profitto) vivono il genocidio, la tortura e il veleno? E se Artaud vuole una costante sonorizzazione, suoni rumori e grida scelti anzitutto per la loro qualità vibratoria […] noi chiediamo: il pubblico, anche quello naturale delle strade, non si è da tempo abituato ai rumori e alle grida violente, normali componenti delle comunicazioni di massa, degli sport, delle strade e dei luoghi di divertimento? Rumori e grida non spezzano l’oppressiva abitudine alla distruzione, si limitano a riprodurla».
[63] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., pp. 169 ss.
[64] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, La nuova Eloisa, cit., p. 248.
[65] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, cit., p. 216.
[66] Cfr. Karl Marx, Il capitale, I, Editori Riuniti, Roma 1964, p. 809, nota 232.
[67] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, Discorso sull’ineguaglianza, cit., p. 81.
[68] Cfr. ibidem, p. 66.
[69] Cfr. ibidem, p. 83.
[70] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, La nuova Eloisa, cit., p. 437.
[71] Cfr. ibidem, p. 249, nota.
[72] Cfr. ibidem, p. 249, nota.
[73] cfr. Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1957, p. 11.
[74] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, Discorso sulle ricchezze, in Irin Fetscher, La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto democratico di libertà, Feltrinelli, Milano 1972, Appendice seconda, pp. 268-269.
[75] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, La nuova Eloisa, cit., p. 250.
[76] Cfr idem.
[77] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, Discorso sulle ricchezze, cit., p. 269.
[78] Cfr. idem.
[79] Cfr. ibidem, p. 271.
[80] Cfr. ibidem, p. 269.
[81] Cfr. Karl Marx, Introduzione a Per la critica della filosofia hegeliana del diritto in Id., Scritti politici giovanili, a cura di Luigi firpo, Einaudi, Torino 1950, p. 295.
[82] Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, in Id., Du contrat social, cit., pp. 3-4.
[83] Cfr. Gian Giacomo Rousseau, La nuova Eloisa, cit., p. 723.
[84] Cfr. Karl Rosenkranz, Vita di Hegel, introduzione e note a cura di Remo Bodei, Vallecchi, Firenze 1966, pp. 33, 35, 39.
[85] Cfr. Jean Hyppolite, Genèse et structure de la Phénomenologie de l’Esprit, Aubier-Montaigne, Paris 1946, I, p. 16.
[86] Cfr. Luciano Parinetto, La nozione di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx, La Goliardica, Milano 1967, pp. 3-4.
[87] Jean-Jacques Rousseau, Emile, Garnier, 1957, p. 9.
[88] Cfr. Paolo Alatri, Introduzione a Gian Giacomo Rousseau, Scritti politici, cit., pp. 32-33.
[89] Cfr. Ernst Bloch, Differenziazioni nel concetto di progresso, in Id., Dialettica e speranza, a cura di Livio Sichirollo, Vallecchi, Firenze 1967, p. 5
[90] Cfr. idem.
[91] Paolo Casini, Rousseau, Cei, Roma-Milano 1966, p. 22.
[92] Cfr. idem.
[93] Cfr. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’inégalité, in Id., Du contrat social, cit., p. 35.
[94] Cfr. Bernard Groethuysen, Philosophie de la révolution française, Gonthier, Paris 1956, p. 127.
