DAMIANO PALANO
Il tempo della disperazione
Al termine del Disagio della civiltà, dopo aver mostrato come il processo della civilizzazione fosse il risultato del controllo progressivamente esercitato sul corredo pulsionale degli esseri umani, Freud veniva a contrapporre l’una all’altra le due forze elementari che riteneva di avere scoperto, Eros e Morte. E proprio nelle righe finale, aggiunte nel 1931, segnalava come i pericoli maggiori per il genere umano giungessero dalla pulsione di morte e dalle tendenze aggressive che ne discendevano:
«Il problema fondamentale del destino della specie umana, a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l’evoluzione civile degli uomini riuscirà a dominare i turbamenti della vita collettiva provocati dalla loro pulsione aggressiva e autodistruttrice. In questo aspetto proprio il tempo presente merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda, fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione»[1].
È facile riconoscere in quelle parole il riflesso cupo della stagione di barbarie che si avvicinava. L’insieme delle trasformazioni epocali inaugurate dalla prima guerra mondiale aveva d’altronde indotto il padre della psicoanalisi a rivedere sensibilmente il proprio quadro teorico generale. E anche se l’interesse per i temi politici era affiorato già dal grande affresco di Totem e tabù, le dinamiche della società attrassero l’attenzione Freud soprattutto a partire dallo scoppio del conflitto e dopo il crollo dell’Impero, un evento che rappresentò anche per il medico viennese il tramonto del «mondo di ieri» in cui aveva vissuto (e creduto) e l’inizio di un’era di disordine. Il cammino che doveva condurre Freud al Disagio della civiltà e al riconoscimento sconcertante della «pulsione di morte» – col quale prendeva atto che la tendenza aggressiva «rivela nell’uomo una bestia selvaggia, alla quale è estraneo il rispetto per la propria specie»[2] – era anche un percorso intellettuale di disillusione rispetto ai grandi sogni della scienza positiva. L’ambizione di poter guarire gli esseri umani dal loro disagio, portando alla luce le correnti misteriose che si agitavano nel fondo della psiche, si trovava alla fine a urtare contro un ostacolo insuperabile, aprendo le porte a un cupo pessimismo, per molti versi simile a quello che aveva indotto i grandi realisti del passato a descrivere il «legno storto» della «natura umana».
La pista indicata dal Disagio della civiltà e da altri scritti freudiani degli anni Venti, come soprattutto Massenpsychologie und Ich Analyse[3], doveva in seguito essere battuta anche da molte altre indagini, più o meno fedeli rispetto agli insegnamenti del padre del psicoanalisi, tra cui è quasi inevitabile ricordare Massenpsychologie des Faschismus di Wilhelm Reich, Escape from Freedom di Erich Fromm, o Eros and Civilisation di Herbert Marcuse, ma tra cui sarebbe ingiusto dimenticare anche suggestivi testi come Psicanalisi della guerra atomica e Psicoanalisi della guerra di Franco Fornari[4]. E anche negli ultimi anni un sentiero di riflessione di questo tipo è stato seguito, seppur ormai marcando una sostanziale distanza da Freud, per esempio da Massimo Recalcati, che in alcuni suoi interventi giornalistici si è spinto a interpretare fenomeni politici come il terrorismo di matrice islamista, alla ricerca di una spiegazione collocata al livello della «psicologia della massa», ossia delle generali condizioni psicologiche che contrassegnano una determinata società[5]. Per quanto suggestive siano le sollecitazioni che provengono da queste indagini, il crinale su cui esse si muovono – al confine tra l’ambito della psicologia del singolo individuo e la sterminata landa delle condizioni economiche, politiche e culturali di una determinata società – non può che essere sempre estremamente scivoloso, ed è così quasi inevitabile cedere a semplificazioni che finiscono con lo smarrire, al tempo stesso, la specificità delle motivazioni individuali e l’autonomia (oltre che la complessità) dei fenomeni politici. Se infatti la ricostruzione ‘psicologica’ del quadro culturale di una determinata fase storica può offrire formidabili elementi per interpretare fenomeni politici o anche le scelte che un singolo individuo si trova a compiere, una simile impostazione rischia quasi sempre di spingere verso il riduzionismo psicologico. Un riduzionismo in base al quale – saltando ogni anello intermedio – non solo fenomeni politici e culturali complessi vengono ricondotti a determinanti psicologiche, ma secondo cui persino la stessa condizione del singolo appare riducibile alle dinamiche della psicologia di massa, proprio secondo quello schema che tracciava Freud al termine del Disagio della civiltà, quando scriveva che la consapevolezza degli esseri umani del potere raggiunto sulle forze naturali spiegava «buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione».
È proprio questo scivoloso crinale, affollato di insidie, che decide di percorrere Franco Berardi nel volume Heroes. Suicidio e omicidi di massa, il suo libro probabilmente più inquietante – se non altro per le storie individuali che vengono considerate come ‘esemplari’ – ma in cui giunge anche a completa maturazione un pessimismo dalle radici profonde[6].
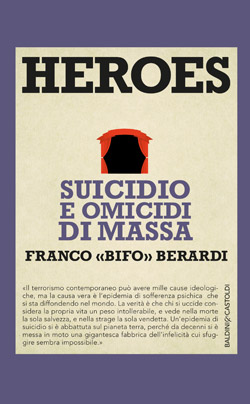
Nel libro di Berardi vengono infatti ripercorse le storie personali di folli criminali che utilizzano armi micidiali per sterminare decine di innocenti, prima di togliersi la vita, ma queste vicende sono assunte come spie di un disagio generale, che non coincide solo con la patologia di casi estremi, perché riflette piuttosto la diffusione di massa di comportamenti patologici. Non è neppure necessario sottolineare come nella lettura che sorregge Heroes si annidino molteplici rischi, che non sono solo quelli di semplificare fenomeni inevitabilmente complessi. E non va neppure mai dimenticato che le ipotesi di Berardi sul disagio dell’«ipermodernità» non hanno – né pretendono di avere – un valore sul piano clinico (un valore che d’altronde non avevano neppure le ipotesi freudiane sul fondamento e sul destino della civiltà), e vanno piuttosto a collocarsi sul terreno di un’interpretazione ‘culturale’ del presente, dalla quale non sono peraltro mai assenti le preoccupazioni più strettamente ‘politiche’ sulle possibili modalità di azione in un contesto tanto fortemente segnato dalla «mutazione»[7]. A dispetto di tutte queste cautele, il pessimismo di Berardi non può essere probabilmente archiviato in modo frettoloso, e non se possono liquidare le estremizzazioni come il semplice vezzo intellettuale di un ‘provocatore’ culturale aduso all’iperbole. Perché a ben guardare, al netto delle estremizzazioni e delle provocazioni (che certo ci sono), il ritratto che Berardi ha delineato, investigando da vicino la mutazione tecnologica degli ultimi due decenni, coglie davvero alcuni aspetti cruciali. E vale dunque senz’altro la pena prendere sul serio le sue ipotesi, evitando di ricondurre le sequenze del suo itinerario all’interno della griglia interpretativa del «post-operaismo» italiano (che almeno nel suo caso appare oggi molto simile a una gabbia distorcente), e rendendo il dovuto merito a uno sguardo che – non da oggi – si è rivelato capace di cogliere tutte le insidie della trasformazione.
L’effige di Franco Berardi – con quel soprannome «Bifo», con cui ancora alle scuole medie cominciò a firmare le proprie opere – rimane per molti versi incastonata, come un tassello insostituibile, nel mosaico di quella «rive gauche in minore» che fu la Bologna degli anni Settanta. Una Bologna forse persino immaginaria, ma non per questo meno nitida nei suoi contorni, in cui stanno le ballate malinconiche di Francesco Guccini, gli esperimenti di Roberto Roversi e Lucio Dalla, il poliziotto Antonio Sarti e l’extraparlamentare eternamente fuoricorso Rosas, il «mediattivismo» goliardico di Radio Alice, il mao-dadaismo di «A/traverso», il Settantasette e il convegno sulla repressione, i dolori sentimentali di Boccalone e le performance di Roberto «Freak» Antoni, e in cui un posto d’onore non può che essere occupato proprio da Franco Berardi, che del movimento bolognese – politico, ma anche culturale e artistico – fu più che un semplice animatore. Ma proprio il fatto che l’immaginario collettivo lo abbia rivestito degli abiti (peraltro tutt’altro che adatti alla sua personalità) del ‘reduce’, insieme probabilmente alle doti istrioniche che lo rendono ancora oggi un formidabile affabulatore, ha finito col precludere la possibilità che in Italia si sviluppasse intorno alla sua riflessione e alle sue ipotesi un dibattito serio, come invece accade da anni all’estero, dove i libri di «Bifo» sono tradotti e discussi. Confrontandosi con la riflessione di Berardi, le pagine che seguono tentano invece di cogliere gli elementi più preziosi dell’indagine sul disagio dell’«ipermodernità» che l’intellettuale bolognese ha avuto modo di condurre nel corso degli ultimi decenni. Ma, al tempo stesso, cercano anche di portare alla luce un rischio che si annida nella sua prospettiva. Un rischio che affonda le radici nella stessa logica di un percorso ormai lungo quasi mezzo secolo, e il cui esito – paradossalmente – tende a configurare una sorta di ‘rimozione’ del conflitto dallo spazio dalla teoria.
Il mondo insensibile
Non è certo sorprendente che Franco Berardi definisca Heroes come un libro «orribile» (H 211). Per gli squarci che apre sul disagio di un’umanità tanto sofferente quanto colpevole di violenze efferate, il volume in molti passaggi risulta davvero urtante, sgradevole, doloroso. Gli assassini di cui il libro si occupa – tracciando gli schizzi biografici di personaggi come James Holmes, autore di una strage in un cinema del Colorado durante la prima del Cavaliere oscuro, come Pekka Auvinen, diciottenne che nel novembre del 2007 uccise nove coetanei in una scuola finlandese, come Seung-Hui Cho, studente di origine coreana colpevole del massacro di trentadue persone in un’università della Virginia, e come Andres Breivik, che il 22 luglio 2011 sterminò settantasette persone, a Oslo e nell’isola di Utoya, dove era in corso il raduno estivo dell’organizzazione giovanile del Partito laburista – non sono comunque considerati tanto nella loro specificità, ma piuttosto come segnali di un processo più ampio. «Non sono episodi marginali», scrive infatti Berardi, «dovremmo leggerli come il sintomo estremo di una sofferenza che dilaga al cuore della società contemporanea, perché il capitalismo finanziario è la fabbrica dell’infelicità, è un buco nero che inghiotte i beni comuni, il prodotto del lavoro, e soprattutto inghiotte la gioia, la speranza, e la possibilità stessa di vivere la vita» (H 12).
La scelta chiaramente provocatoria, spiazzante, di partire da casi tanto estremi per ricostruire un clima emotivo non può che calare sul libro un’ipoteca formidabile, suscettibile agli occhi di molti persino di squalificare l’intera operazione, perché quella scelta può apparire come una scorciatoia che dalle azioni di alcuni individui (i cui tratti sono peraltro desunti solo da informazioni giornalistiche) conduce sino alla società e a una condizione psicologica generale. A dispetto di tutte queste forzature, e delle provocazioni culturali, l’ipotesi che guida l’interpretazione di Berardi offre senz’altro degli elementi di riflessione tutt’altro che secondari, nella direzione di una ‘fenomenologia’ del presente, o persino di una «fenomenologia della fine», come recita il titolo di uno degli ultimi libri dell’intellettuale bolognese[8]. «Non credo che il suicidio si possa ridurre a un’unica causa, data la complessità psicologica della scelta di rinunciare alla vita», scrive Berardi, prevenendo le critiche di eccessiva semplificazione, ma, al tempo stesso, osserva che «quando i numeri sono così incredibilmente alti, quando il suicidio diviene un fenomeno di massa qualche motivazione comune deve esserci» (H 183). E la chiave del ragionamento, la spiegazione della dimensione di massa che assume il suicidio, sta – più che nei ritratti criminali, inevitabilmente grotteschi, un po’ come i ritratti della vecchia criminologia fin de siècle – nel titolo del volume, Heroes: un titolo il cui significato, però, si presta facilmente a essere frainteso, se non del tutto distorto. Il titolo si richiama infatti a un disco di David Bowie pubblicato nel 1977, nel quale l’artista britannico coglieva una trasformazione radicale nella figura dell’eroe: un eroe che non è più un soggetto, ma solo un oggetto, una cosa, un feticcio, riproducibile costantemente, all’interno di un quadro in cui dunque la realtà viene sostituita dalla simulazione e da simulacri. Come scrive Berardi nelle pagine introduttive: «La forma epica dell’eroismo è scomparsa verso la fine della modernità, quando la complessità e la velocità degli eventi umani hanno soverchiato la forza e la volontà. Quando il caos prevale l’eroismo epico è sostituito da grandi macchine di simulazione. Lo spazio del discorso epico viene occupato dalle corporazioni semiotiche, apparati che emanano illusioni largamente condivise. Questi giochi di simulazione spesso prendono forma di identità, come accade nelle sottoculture popolari, come il rock, il punk, la cybercultura e così via. Le origini della forma più moderna di tragedia stanno qui: sulla soglia le illusioni sono scambiate per realtà, e le identità sono percepite come un’autentica forma di appartenenza» (H 16-17). E proprio a partire dal fatidico 1977 – un anno per Berardi non solo simbolicamente cruciale – «il mondo trasmigrò dalla sfera dell’evoluzione umana alla sfera della de-evoluzione, o de-civilizzazione», gli eroi «si trasferirono in un’altra dimensione: si dissolsero, e divennero fantasmi», mentre «la razza umana, inseguendo finti eroi fatti di illusoria sostanza elettromagnetica, perse fede nella realtà della vita e dei suoi piaceri e cominciò a credere solo nell’infinita proliferazione delle immagini» (H 17). La trasformazione in simulacro della realtà – cui allude, un po’ cripticamente, il titolo del volume – è infatti per Berardi l’elemento cruciale della trasformazione che abbiamo vissuto nel corso dell’ultimo quarantennio, oltre che «la caratteristica quintessenziale del semiocapitalismo, il regime contemporaneo nel quale la valorizzazione del capitale è basata sulla costante emanazione di un’enorme quantità di informazione» (H 35).
Se nella lettura del «semiocapitalismo» proposta da Berardi un posto importante è occupato dalla «de-materializzazione» della produzione, ciò su cui attira soprattutto l’attenzione sono gli effetti che la trasformazione produce sugli individui, e cioè «la mutazione cognitiva e psichica che l’immersione prolungata in un ambiente digitale può produrre»: un’immersione che, al di là dei contenuti che vengono effettivamente proposti all’attenzione dei singoli, tende a produrre, soprattutto in virtù dell’iperstimolazione, «un effetto di desensibilizzazione all’esperienza corporea della sofferenza e del piacere» (H 59). E i terribili crimini di massa compiuti dagli individui considerati in Heroes costituiscono così «una manifestazione eccezionale di una tendenza generale di mutazione della reattività mentale» (H 59). A produrre la «desensibilizzazione» sono naturalmente molti processi, ma Berardi ne individua in particolare due, e cioè, da un lato, «la dissociazione dell’apprendimento linguistico dall’esperienza affettiva corporea», e, dall’altro, «la virtualizzazione dell’esperienza» (H 60). Nel quadro proposto da Berardi non può però mancare un riferimento alla dimensione più specificamente economica, e cioè non tanto al ruolo che le ‘macchine’ vengono a svolgere nell’interazione con gli individui, quanto all’utilizzo specifico che ne viene fatto all’interno del «semiocapitalismo», e dunque sulle conseguenze che da tale utilizzo derivano. «Il semiocapitalismo», scrive per esempio Berardi, «si fonda sullo sfruttamento delle energie mentali: l’attenzione è sotto assedio, sia nello spazio della produzione che in quello del consumo», e una simile iper-stimolazione dell’attenzione «implica un investimento costante di energia nervosa, […] molto più difficile da gestire e molto più imprevedibile di quanto lo fosse la forza muscolare che era al lavoro nella catena di montaggio industriale» (H 147). Quando evoca l’iper-stimolazione dell’attenzione, Berardi si riferisce a tutti quegli aspetti che vengono spesso ricondotti alle caratteristiche di ciò che è spesso definito «capitalismo cognitivo», «biocapitalismo» o «bioeconomia», ossia a una trasformazione – indagata a lungo dal post-operaismo, non senza qualche semplificazione e un’enfasi talvolta persino esasperata sulla tendenza[9] – che rende sempre più labili i confini tra vita e lavoro, e che viene invece a trasformare tutto il nostro tempo di vita in tempo di lavoro, grazie per esempio alla connessione costante in rete e alla telefonia mobile. In un contesto di questo tipo, molti degli strumenti tradizionalmente utilizzati dai lavoratori per negoziare il prezzo del proprio tempo di lavoro risultano del tutto inadeguati. «Il tempo di lavoro», scrive Berardi, «è frattalizzato, ridotto a frammenti minimi che possono essere riassemblati, e la frattalizzazione rende possibile per il capitale trovare continuamente le condizioni per il ridurre al minimo il salario» (H 150); inoltre, senza prossimità spaziale e continuità temporale, i singoli lavoratori non sembrano in grado di opporre alcuna significativa resistenza[10]. E anche perché non incontra alcuna resistenza reale, la stimolazione dell’attenzione che contrassegna il «semiocapitalismo» tende a innescare una vera e propria «mutazione». «L’organismo conscio e sensibile è sottoposto a una pressione competitiva crescente, a un’accelerazione degli stimoli, a uno stress costante dell’attenzione», tanto che – e qui si colloca un passaggio cruciale – «l’infosfera in cui la mente si forma ed entra in relazione con altre menti, diviene un’atmosfera psicopatogena» (H 151).
Naturalmente la connessione tra la formazione dell’«atmosfera patogena» e i casi estremi ricostruiti da Berardi nel volume non può che risultare labile, e in questo sta forse l’aspetto più provocatorio del volume. Un legame invece più forte appare quando lo sguardo si sposta su altri fenomeni di suicidio, in cui le dimensioni non possono far trascurare il peso delle influenze ambientali. In questo caso, Berardi si riferisce per esempio al suicidio cui ricorsero gli amerindiani dopo la colonizzazione spagnola, per sottrarsi alla condizione di schiavitù, o al Paputan balinese, esperienze che sono dolorosamente tornate alla mente in occasione per esempio della lunga catena di suicidi di dipendenti altamente qualificati di France Télécom[11], oppure al gesto estremo di quei giovani operai cinesi, che per protesta contro le terribili condizioni di lavoro negli impianti Foxconn, si sono tolti la vita gettandosi dal tetto delle fabbriche dormitorio in cui erano occupati, o alle migliaia di contadini indiani che dal 1997 si sono uccisi, schiacciati dai debiti contratti con la Monasanto per acquistare le sementi[12]. Questo tipo di suicidio, compiuto quasi sempre sul posto di lavoro, si avvicina infatti davvero molto – e probabilmente molto di più dei casi estremi e terrificanti degli stragisti cui è dedicata la prima parte di Heroes – a un comportamento in cui il suicidio diventa «la reazione degli esseri umani quando essi si trovano di fronte alla distruzione dei propri riferimenti culturali, e all’umiliazione della loro dignità», ossia proprio quella reazione che induce Berardi a riconoscere che «il suicidio segna così profondamente la scena del nostro tempo» (H 169). Ed è proprio il caso dei suicidi dei dipendenti di France Télécom a offrire la più nitida illustrazione di una logica terribile, che investe in modo specifico i lavoratori «cognitivi». Come scrive Berardi, «i lavoratori cognitivi sono stati costretti nella trappola della creatività: le loro aspettative sono sottomesse al ricatto produttivo, poiché sono obbligati a identificare la propria anima (la parte linguistica ed emozionale delle loro attività) con il proprio lavoro»; e dunque «i conflitti sociali e l’insoddisfazione sono percepiti come fallimenti psicologici, il cui effetto è la distruzione dell’autostima» (H 177). Gli strumenti adottati dalla direzione aziendale per aumentare la produttività – la meritocrazia, la competizione, l’individualismo – rompono la solidarietà fra colleghi, col risultato di lasciare solo il lavoratore dinanzi ai compiti crescenti richiesti, che vengono comunque accettati nonostante siano impossibili da svolgere. «Perché gli impiegati accettano questi compiti impossibili che gli vengono affidati?» si chiede Berardi, e la risposta che fornisce è centrata proprio sull’assenza di solidarietà fra colleghi: «perché la solidarietà è stata rotta, e ogni lavoratore è solo di fronte al ricatto del merito, e all’umiliazione della valutazione individuale che sta nelle mani di una gerarchia di mascalzoni», e ciò che segue «è un sentimento di colpevolezza, ansietà, risentimento reciproco per la percezione dell’incapacità di aiutarsi l’un l’altro e di creare solidarietà» (H 180). La «depressione condivisa» appare dunque, in questa prospettiva, come l’esito ricercato di una determinata strategia aziendale, «rivolta a esaurire le persone fino al punto in cui perdono ogni autonomia, ogni senso di solidarietà, così da diventare del tutto dipendenti dagli automatismi dello sfruttamento» (H 181).
La cifra distintiva, che definisce il contesto culturale e sociale in cui matura la diffusione di massa del suicidio, è dunque data dalla combinazione tra la «precarietà lavorativa» (intesa come «la cancellazione delle regole che sono state create nella relazione tra operai e capitale, e particolarmente la cancellazione del contratto che garantisce la continuità e la regolarità» H 215) e i due processi della diffusione delle tecnologie informatiche e della creazione della rete digitale: processi che hanno reso possibile la precarizzazione, nella misura in cui hanno consentito di ricombinare azioni produttive svolte in assenza di qualsiasi prossimità spaziale[13]. La convergenza di questi processi conduce però a un dato ulteriore, che Berardi identifica come la disgregazione dei due pilastri etici su cui si fondava la società moderna: per un verso, la responsabilità del borghese («davanti a Dio e di fronte alla comunità territoriale»), per l’altro la solidarietà tra lavoratori, in virtù della quale ogni singolo «era legato ai suoi compagni di lavoro dalla coscienza di condividere i medesimi interessi» (H 215). Oggi la situazione si profila invece come radicalmente opposta su entrambi i fronti. «Il capitalista post-borghese non si sente responsabile della comunità e del territorio, perché il capitalismo finanziario è totalmente deterritorializzato e non ha alcun interesse nel benessere futuro della comunità», mentre «il lavoratore post-fordista non ha più lo stesso interesse dei suoi colleghi, ma al contrario deve ogni giorno competere per il lavoro e il salario sul mercato deregolamentato e precario» (H 215-216).
L’obiettivo del libro di Berardi non consiste però solo nella denuncia del carattere ‘nichilista’ del capitalismo cognitivo, perché l’ambizione è anche quella di delineare – o forse solo prefigurare – una strategia capace di rispondere alla «partita del futuro»: una partita che si giocherà nei prossimi decenni tra le alternative di una «definitiva automazione del cervello collettivo» e l’«autonomia consapevole dell’intelletto generale» (H 216), tra la «sottomissione della mente alle regole della neuro-macchina globale secondo il principio competitivo dell’economia capitalista» e «l’emancipazione della potenza autonoma dell’intelletto generale» (H 219). L’ambizione è cioè quella di individuare «un metodo etico di sottrazione alla barbarie presente», oltre che di elaborare «il modo di interpretare i nuovi valori etici che la barbarie porta con sé» (H 220). E il fatto che venga evocato un «metodo etico», come possibile percorso di fuoriuscita dalla «barbarie», non è certo casuale, perché Berardi ritiene che il terreno della tradizionale azione politica sia, più che concretamente impraticabile, sostanzialmente incapace di incidere sulla realtà del mutamento.
La soluzione che viene profilata non può però non apparire deludente, o quantomeno ben poca cosa dinanzi alla capacità soverchiante del cupo panorama descritto nell’intero volume. Di fronte allo «spasmo» contemporaneo – «effetto della penetrazione violenta dello sfruttamento capitalista nel campo delle info-tecnologie, che coinvolge la sfera della cognizione, della sensibilità e dell’inconscio» – Berardi evoca infatti la «caosmosi» teorizzata da Felix Guattari nel suo ultimo libro, ossia «il passaggio osmotico da uno stato di caos a un nuovo ordine», inteso però solo nei termini di un’«armonia tra la mente e l’ambiente semiotico, e anche come condivisione simpatetica di un comune ambiente mentale» (H 232). In sostanza, dal momento che «la coscienza è troppo lenta per elaborare l’informazione che proviene dal mondo in accelerazione», e che dunque «il mondo non può essere tradotto in un cosmo, ordine mentale, sintonia e simpatia», «abbiamo bisogno di una trasformazione, il salto a un nuovo ritornello, a un nuovo ritmo: la caosmosi è il passaggio da un ritmo di elaborazione cosciente (ritornello) a un altro ritmo, che sia adatto a elaborare quel che il ritmo precedente non poteva elaborare», «un salto nella velocità della coscienza elaboratrice, e di conseguenza la creazione di un differente ordine di elaborazione mentale» (H 233-234). E sempre utilizzando la terminologia di Guattari, la strada che conduce alla «caosmosi» passa per la costruzione di un «caoide»: «un decodificatore vivente del caos», «una sorta di de-moltiplicatore, un agente di re-sintonizzazione, un agente linguistico che si liberi dal ritornello spasmico», «una forma di enunciazione (artistica, poetica, politica, scientifica) che riesce ad aprire i flussi linguistici a ritmi e cornici interpretative diverse» (H 234-235). Ma, in realtà, il «caoide» evocato nelle pagine finali rimane senza un volto, che non sia quello di una sottrazione rispetto alla politica e alla partecipazione politica, o quello di un’ironica presa di distanza da ogni profezia che riguardi il destino (più o meno catastrofico) dell’umanità[14]. E proprio per questo l’incubo totalitario dipinto in Heroes sembra in fondo destinato a non incontrare alcuna seria resistenza.
Il pessimismo che trasuda quasi da ogni pagina di Heroes, come d’altronde dagli altri libri recenti di Franco Berardi, può risultare sorprendente a chi non abbia seguito l’itinerario teorico compiuto negli ultimi anni dall’intellettuale bolognese, e forse soprattutto a quanti ricordino «Bifo» solo come il ‘profeta’ di quella «generazione dell’anno Nove» che, ormai quasi quarant’anni fa, privilegiava «una pratica della scrittura ‘trasversale’», si proponeva di «liberare il desiderio» e intendeva il linguaggio come una «pratica di sovversione permanente» capace di «far saltare la dittatura del significato» e «la dittatura del politico»[15]. A dispetto di questa immagine, il pessimismo di Heroes ha però radici molto profonde, che in qualche modo affondano proprio negli anni Settanta. Innanzitutto perché Heroes può essere letto come il provvisorio punto di approdo di un percorso di ricerca sulle trasformazioni del lavoro avviato più di quarant’anni fa, quando Berardi seppe cogliere – con indiscutibile lungimiranza – il ruolo che avrebbe avuto il lavoro intellettuale e intravedere la logica delle sue metamorfosi successive. Ma, in secondo luogo, anche perché il pessimismo che trapela da tutte le pagine di Heroes rappresenta per molti versi la conseguenza – forse imprevista – di quella «critica della politica» intrapresa negli anni Settanta, che ancora oggi – seppur in forme mutate – continua a contrassegnare la prospettiva di Berardi.
Le contraddizioni dell’«infosfera»
Nella ricca produzione teorico-politica di Berardi, Heroes è in effetti solo il capitolo più recente, nel quale è peraltro agevole ritrovare molti – se non tutti – i fili che tengono insieme la riflessione dell’intellettuale bolognese da più di trentacinque anni. Già all’inizio degli anni Settanta, Berardi cominciò infatti a interrogarsi sul significato politico che la creazione artistica poteva assumere nel nuovo contesto sociale e produttivo, e dunque a delineare il quadro in cui avrebbero preso forma le sperimentazioni ‘mao-dadaiste’ di «A/traverso»[16]. Contemporaneamente, iniziò però anche a indagare trasformazioni del lavoro e in particolare i processi che venivano a coinvolgere il lavoro intellettuale. Nelle pagine di Scrittura e movimento, riflettendo all’indomani della grande ondata di mobilitazioni che aveva investito nel 1973 il ciclo dell’auto in tutta Europa (e naturalmente a Torino), sosteneva che quel movimento aveva rappresentato per molti versi l’apice della parabola dell’operaio massa, e che proprio la vittoria di questa figura faceva prevedere l’inizio di una nuova fase e dunque la definizione di una differente configurazione. «In questa nuova composizione di classe», scriveva infatti, «il lavoro intellettuale e tecnico, l’intelligenza produttiva (la wissenschaft-technische-Intelligenz) tende a diventare determinante» (SM 8). E questo processo poneva una serie di problemi inediti, che riguardavano innanzitutto il tipo di organizzazione adottato dai diversi gruppi dell’estrema sinistra, inadeguato alle modificazioni in atto, ma anche la crisi della figura dell’intellettuale, il quale, pur assumendo ormai i tratti di «produttore di informazioni produttive», scriveva Berardi, non aveva fino a quel momento «saputo assumere coscientemente questo nuovo ruolo», continuando invece «ad agire entro la cultura come istituzione, a considerare separatamente la sua collocazione materiale dalla sua pratica testuale, dalla sua operatività cosciente» (SM 24). Le sperimentazioni comunicative di «A/traverso» e poi di Radio Alice costituivano in gran parte il tentativo di adottare uno stile comunicativo adeguato alla centralità del lavoro intellettuale e, al tempo stesso, un modo per prefigurare una nuova forma di azione politica[17]. E in questo senso, il ruolo ambivalente del processo di «massificazione della forza-lavoro intellettuale e tecnico-scientifica» era un elemento quasi fondativo nella riflessione di «A/traverso». Come si leggeva sulla rivista nell’ottobre del 1975: «L’intelligenza tecnico-scientifica è prodotta dentro il conflitto operai-capitale», ma, dal momento che «l’informatizzazione del processo lavorativo massifica e proletarizza uno strato sociale di lavoratori intellettuali, e questi si incontrano con la forza-lavoro scolarizzata e politicizzata che si è formata negli anni ‘60-’70, si apre una nuova decisiva contraddizione»[18]. In altre parole, «nel momento in cui il lavoro intellettuale si proletarizza, questo strato diviene portatore dei bisogni più avanzati, ma anche – come detentore del sapere sociale accumulato – diviene portatore della possibilità materiale di trasformazione operaia del meccanismo produttivo, da strumento di intensificazione dello sfruttamento a strumento di liberazione dal lavoro»[19]
Proprio nello spazio in cui i linguaggi delle avanguardie artistiche dei primi decenni del Novecento parevano diventare patrimonio di un critica di massa, andavano a collocarsi anche gli episodi principali della riflessione teorica condotta da Berardi negli anni Settanta. Al di là dell’efficacia di questi strumenti e dell’originalità dell’intera riflessione, lo scenario sociale doveva sensibilmente modificarsi alla svolta degli anni Ottanta, quando il mutamento del quadro politico faceva emergere le prime tracce di quel pessimismo radicale che oggi si ritrova nelle pagine di Berardi. Nel giugno del 1981, «A/traverso» per esempio scriveva che era cominciato «il tempo del dopo», un dopo che si presentava «come un deserto di cui non vediamo la fine»[20]. Ma ciò cui si riferiva questo testo non era il clima segnato dalla repressione e dalla spirale della violenza, seguita al rapimento di Aldo Moro, e neppure il «riflusso» che aveva spinto molti militanti ad allontanarsi dall’impegno politico. Il «deserto» cui alludeva «A/traverso» era piuttosto l’orizzonte della mutazione antropologica che si profilava ormai nitidamente. Una mutazione differente da quella di cui Pier Paolo Pasolini aveva intravisto i contorni qualche anno prima, nei famosi editoriali apparsi sul «Corriere della Sera»[21], ma i cui effetti non erano meno dirompenti. Citando McLuhan, «A/traverso» prevedeva infatti l’emergere di un processo di ‘ritribalizzazione’, innescato dalle nuove tecnologie, e in questa diagnosi affioravano già molti degli elementi che si riconoscono anche oggi nell’interpretazione di Berardi:
«oggi l’ambiente in cui viviamo è costituito non più di oggetti, ma di segnali la cui anima è il potere comunicativo e informativo di cui sono stati dotati. Viviamo in un ambiente definibile come infosfera, universo animato nel quale pulsano messaggi che qualcuno ha inviato perché altri possa riceverli, se vuole, o talvolta anche se non vuole. Una seconda caratteristica delle ritribalizzazioni delle facoltà intellettive è la rimitizzazione della memoria, con tutti gli effetti (spesso sconvolgenti) che questa può produrre. L’informatizzazione, l’immagazzinamento della conoscenza e della memoria e la loro automatizzazione, tendono a ridurre e cristallizzare la memoria viva, individuale del passato e del vissuto. La memoria tende ad essere sempre meno memoria umana, e sempre più memoria informatica. Questo produce effetti che oggi possiamo cominciare solo ad intravvedere. Il passato viene percepito come tempo senza profondità, come tempo non vissuto, come mera configurazione ottica. Alla percezione del vissuto e della sua pluralità si sostituisce la piattezza di una percezione tutta contemporaneizzata, senza dinamicità e senza diacronia. La fine della ragione critica è probabilmente inscritta inevitabilmente in questa de-memorizzazione. Ma al tempo stesso sono tutte da scoprire le potenzialità di rimitizzazione dell’universo»[22].
In quella fase, lo sguardo di Berardi non rinunciava a ritrovare, dentro la mutazione, delle potenzialità notevoli. In un frammento del gennaio 1980, poi pubblicato nel volume Presagi, scriveva per esempio che, «nella sincronizzazione senza sintesi e senza soggetto della percezione», era necessario «far funzionare nuovi punti di intersezione», «cercare e produrre i suoni capaci di attraversare e trasformare il ritmo della nostra epoca», «traversare il deserto fatto di segno che non si traducono in un unico linguaggio comprensibile»[23]. In altri termini, il nuovo nomadismo – ossia «la mobilità territoriale delle tribù videoelettronica» – poteva essere concepito anche come una realtà che consentiva «di fuggire costantemente dalle condizioni create dalla crisi capitalistica cercando dovunque possibilità di vita residuali»[24]. Un simile ottimismo doveva però mostrare di lì a poco tutta la sua ingenuità, e per questo risultano oggi molto più profetici i versi di Game over, un «poema videoelettronico» firmato da Berardi insieme a Enzo Crosio e apparso su «A/traverso» nell’ottobre 1981: «Vince sempre la macchina. La funzione esponenziale della velocità elettronica abbatte l’una dopo l’altra le funzioni della reattività biologica. / E prima o poi perdi»[25].
Anche se Berardi riconobbe negli anni Ottanta, oltre l’«omologazione» e la «superficialità», anche «un arcipelago di esperienze creative autentiche, di opere e di situazioni del tutto indifferenti alla logica del mercato», nel corso del decennio divenne piuttosto chiaro che si era ormai indirizzati verso «una mutazione antropologica, sociale, paradigmatica», verso un mutamento «confuso, e in molti punti inquietante», all’interno del quale si profilava anche «una nuova forma di totalitarismo, disincarnato ed astratto, ma non per ciò tollerabile»[26]. Quasi inevitabilmente, più che verso il futuro, lo sguardo di Berardi – un po’ come l’Angelus novus di Paul Klee – continuava a volgersi però verso il passato, nel tentativo di trovare una spiegazione alla catastrofe politica e esistenziale con cui si erano chiusi gli anni Settanta. Ed era in fondo per questo che, in occasione del decennale dal Settantasette, in Dell’innocenza, tornò a riflettere su quel movimento. Un movimento di cui «Bifo» non nascondeva affatto le ambiguità, che riconduceva alla compresenza di due diverse correnti. La prima «riproduceva il modello classico delle rivoluzioni del ventesimo secolo». La seconda invece «partiva dalla constatazione di un processo: il processo di liberazione del tempo umano dalla necessità del lavoro industriale» (I 37). Questa seconda corrente dunque «concepiva il movimento come consapevolezza pratica di un processo di proporzioni immense e dagli effetti sconvolgenti: il processo di estinzione del lavoro industriale e di generale trasformazione dell’attività umana» (I 38). E proprio in virtù di tale consapevolezza il Settantasette poteva essere considerato come un anno di «premonizione»: un anno in cui cioè, all’interno del movimento, emerse «la percezione (euforica prima e poi disperata) di un processo di mutazione dell’attività umana, dell’aggregazione e della comunicazione sociale, della stessa attività cognitiva e della trasmissione del sapere che oggi si sta dispiegando, e di cui ci manca ancora una comprensione adeguata» (I 38). Il titolo con cui nel giugno 1977 un numero di «Zut-A/traverso» annunciava, non senza qualche dose di provocazione goliardica, «la rivoluzione è finita, abbiamo vinto», stava a indicare così due processi distinti: da un lato, che la concezione moderna della rivoluzione doveva essere abbandonata per sempre, a vantaggio della «creazione di un’area sociale capace di incarnare l’utopia di una comunità che si sveglia e si riorganizza fuori dal modello predominante di scambio economico del lavoro e del salario» (I 49); dall’altro, quasi si trattasse di «una sorta di scongiuro», «l’indicazione di un atteggiamento mentale», il progetto «di creare le condizioni per affrontare in termini di sperimentazione consapevole e collettiva il processo di estinzione del lavoro» (I 50).
Se il Settantasette, secondo Berardi, tentò dunque di «dare una forma soggettiva, politica, riconoscibile e pratica a questo processo individuato astrattamente, in modo puramente teorico», questo sforzo naufragò dinanzi alla realtà di una transizione postindustriale che, di fatto, contrappose l’una all’altra «forza-invenzione» e «forza-lavoro»[27]. Ma la fine della rivoluzione sancita dal Settantasette era comunque, agli occhi di Berardi, un dato irreversibile, che chiudeva anche con la dialettica, nel senso che quella che «al pensiero dialettico appare come sofferta alienazione del lavoro, come dolorosa espropriazione dell’attività, può diventare estraneità gioiosa», e dunque non più «una destinazione finale, una soluzione dialettica, un aldilà storico nel Superamento», bensì «un attivo sottrarsi al lavoro ed una estraneità produttiva, utile» (I 70). Forse proprio qui stava l’eredità ancora preziosa del movimento sconfitto, nella sua «innocenza», ossia nella capacità di concepire «la condizione della rivolta non più come rivolta storica, come volontà di istituire un mondo storico giusto, ma come attivo sottrarsi, come saggezza», oltre che come «adattamento capace di rifiutare la menzogna storica, e dunque di sottrarsi alla dimensione dell’adattamento storico – per misurare direttamente l’esperienza del singolo su un ritmo che non è quello della storia, bensì del fluire del tempo storico» (I 107). E quando oggi, al termine di Heroes, Berardi evoca la necessità dell’ironia e della sottrazione, non fa altro che riproporre in modo solo leggermente diverso la «saggezza innocente» di cui il Settantasette – almeno in una sua componente – si fece portatore.
Nel corso degli anni Ottanta Berardi non cessò però di osservare quanto stava avvenendo al lavoro mentale nel corso della rivoluzione comunicativa. Nel saggio Il paradosso della libertà utilizzò infatti un’idea destinata a tornare molto spesso nei suoi scritti successivi. Riprendendo una formula di Ken Wilber, scrisse che «l’attività mentale è l’attività di un campo formato da flussi di energia e di informazione che si intersecano», e che possono essere visti come «sostanze che si mescolano nel cervello sociale», dando forma a una sorta di «psicochimica del sociale»[28]. E soprattutto chiarì in che termini la sempre più pervasiva rivoluzione comunicativa incidesse su questa «psicochimica»:
«Psicofarmaci, regolatori chimici del cervello […] si sommano in questo processo di produzione del sistema nervoso sociale, che diviene il processo di produzione centrale del sistema postindustriale. È per questo che il sistema potrebbe designarsi come società della produzione immateriale. Il campo mentale è pervaso e permeato da flussi materiali, in quanto materia sono le onde elettromagnetiche, e materia sono le pillole di Valium; ma il loro prodotto è immateriale. Il campo di circolazione di questi flussi possiamo definirlo infosfera. La mente individuale proietta il suo mondo come ecosfera»[29].
Anche se la fenomenologia della mutazione non poteva che essere solo ai capitoli iniziali, Berardi coglieva come la modificazione della «psicochimica sociale» avesse implicazioni dirompenti sul terreno della percezione sociale e sul terreno politico. Il principale effetto della «colonizzazione della mente umana» e della proliferazione dei segnali riguardava infatti la percezione del tempo e dunque la trasmissione della memoria. «Il modello dell’istanteneità comunicativa, la trasmissione di segni sostitutivi dell’evento reale», osservava, «determina una mutazione del meccanismo di base della memorizzazione: è azzerata la percezione stessa della diacronia, dello svolgersi degli eventi nel tempo, della successione degli istanti nel vissuto»[30]. E se tutto questo pareva determinare «una cancellazione della profondità temporale, della percezione stessa della continuità dell’esperienza personale nel passato nel presente verso il futuro»[31], sanciva anche, prevedibilmente, la chiusura definitiva di qualsiasi azione politica indirizzata verso il futuro, e dunque di qualsiasi progetto utopico di trasformazione radicale. Col risultato di rendere la depressione una condizione di massa:
«Quando l’immaginazione utopica ha mostrato segni di disattivazione, nel sistema cognitivo sociale, le antenne delle generazioni culturali che si erano formate nell’epoca di massima espansione di quella facoltà hanno cominciato a non ricevere più segnali. La depressione può essere interpretata come incapacità di decifrare e percepire coscientemente i segnali in arrivo. L’input di senso sembra ridursi a zero… Il narcisismo investito nella ricerca di senso si rovescia quindi in depressione. Il nichilismo spettacolare del sistema planetario militarizzato agisce come una bomba metafisica, come l’innesco di un processo di devitalizzazione di cellule informate secondo uno schema finalizzato, teologizzato, orientato verso il senso, verso l’utopia di un mondo razionale, verso il superamento dialettico. Il cervello sociale della generazione polarizzata sul senso si spappola e diviene incapace di immaginare, cioè di proiettare scenari concreti del futuro. Un disturbo dell’immaginazione è all’origine della depressione: l’immaginazione del futuro non ha più alcuna concretezza, alcuna vitalità. La depolarizzazione depressiva trova una traduzione adeguata ed un equilibrio nel regime psicochimico dell’eroina, assuefazione ossessiva, reazione obbligatoria ad uno stimolo ripetitivo. […] La depressione è azzeramento dell’input informativo, perché i recettori di impulsi, polarizzati sul senso, non riescono a registrare impulsi. Gli impulsi che circolano nell’infosfera videoelettronica funzionano secondo un codice indecifrabile: la ricezione consapevole tende a ridursi a zero, o forse il piano della consapevolezza si sposta. Si ha l’impressione che non accada più nulla, proprio mentre la quantità di informazione diviene infinitamente più alta. Ma in questo circolo può determinarsi una ripolarizzazione selvaggia […] Il mondo senza verità, resosi percepibile ad un cervello sociale privo del filtro del senso, bombarda il sistema nervoso inducendo dinamiche di panico o di conformismo ed omologazione»[32].
Benché il quadro iniziasse senz’altro a tingersi dei toni cupi del pessimismo, nella descrizione che forniva allora Berardi si poteva ravvisare ancora qualche traccia di ambiguità. La contrazione della percezione temporale e l’azzeramento della percezione della diacronia in qualche modo lasciavano ancora qualche elemento di speranza, se non altro perché, a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, in tutta Europa i movimenti subculturali giovanili avevano innalzato la bandiera del No-Future, in una chiave non lontana da quella logica di ‘sottrazione’ in cui Berardi indicava in fondo il nucleo portante della «saggezza innocente» del Settantasette. Il moderato ottimismo con cui al principio degli anni Ottanta si poteva guardare a questi movimenti metropolitani, alla fine del decennio non poteva essere però riformulato negli stessi termini, e non a caso Berardi enfatizzava soprattutto gli elementi critici del processo in atto[33]. La fenomenologia della mutazione doveva però procedere ulteriormente, in questa stessa direzione, nel corso del decennio seguente. Se nel volumetto Lavoro zero Berardi riproponeva l’attualità di un programma di riduzione dell’orario di lavoro, come perno di una piattaforma rivendicativa per i nuovi movimenti, in quel testo lambiva anche l’insieme delle trasformazioni che avevano investito il lavoro mentale. E scriveva, per esempio, che «il coinvolgimento dei lavoratori nel processo produttivo diviene essenzialmente coinvolgimento dell’energia nervosa», un coinvolgimento il cui effetto era la nascita di una forma di «psicopatia». «La contraddizione sociale si manifesta sempre più nella forma della sofferenza mentale», notava inoltre in un passaggio per la verità incidentale, e per questo «la sofferenza mentale non è più un margine della vita sociale, non è più un fenomeno limitato e segregabile, ma dilaga nel cuore stesso della vita produttiva, ne diviene il principale prodotto sociale»[34]. Ma l’intero ragionamento, oltre che a sostenere la necessità della riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, era finalizzato a mostrare la senescenza della logica economica di misurazione dell’attività intellettuale in base al tempo individuale di lavoro[35]. E proprio per la scarsa attenzione riservata alla radicalità della svolta in atto, Berardi sarebbe tornato criticamente su questa insufficienza del proprio volumetto, che, come avrebbe scritto in un testo pubblicato nel 1995, aveva dimenticato l’elemento cruciale, ossia l’integrazione fra l’«infoproduzione» e ciò che definiva come «Neuromagma». Un elemento che faceva presagire scenari catastrofici:
«Io vedo due processi dominanti nella nostra epoca, che sono diversi in tutto, ma convergono nel senso della catastrofe implosiva. Il primo processo è quello della deterritorializzazione tecnologica. Frammenti di sapere digitalizzato trasformano la produzione, la comunicazione, l’esperienza quotidiana in un Neuromagma modulare, sottoposto a una ininterrotta ricombinazione. Il ciberspazio si espande illimitatamente e a crescente velocità, mentre il tempo di elaborazione cosciente non può espandersi alla stessa maniera e alla stessa velocità. Quanto più si espande la sfera del conoscibile, tanto più aumenta l’indecidibilità e l’ansia dell’attore umano. Questo mette in moto un secondo processo, completamente diverso dal primo: il residuo di fisicità che la digitalizzazione non ha potuto eliminare dalla scena sociale reagisce con un movimento disperato di riterritorializzazione. Il cervello incapace di elaborare una infosfera troppo ampia, troppo veloce, troppo densa, si abbarbica alle (illusorie) certezze fondamentali: le certezze dell’identità, della terra, del sangue, del popolo, della fede» (N 25-26).
Negli anni Novanta, la mutazione appariva però a Berardi ancora ambivalente, nelle sue potenzialità. Certo per un verso si presentava come «un processo di irreversibile mutamento biologico e genetico dell’organismo», ma al tempo stesso, Berardi osservava: «Il processo di riorientamento non è certamente lineare né consapevole, ma segue percorsi difficili da comprendere, anche perché chi cerca di analizzare questo processo è coinvolto a sua volta», e perché in questo quadro «si sviluppano nuove competenze, e queste nuove competenze si trasmettono da un organismo a un altro come per via di un contagio virale» (MC 18-19). Se da un lato segnalava le conseguenze distruttive del panico, della depressione, del sovraccarico, dell’anestesia (MC 53), dall’altro non pareva escludere l’eventualità che si trattasse degli effetti legati a una transizione, e che – come voleva d’altronde l’utopia cyberpunk – esistessero i margini per una sorta di ‘riappropriazione’ della tecnologia. Così, seppur marginalmente, evocava la «sorpresa» del «riapparire improvviso di un ritmo singolare nella trama della realtà che pretende all’identico», la «sorpresa» dell’«attualizzarsi dell’evento». Una sorpresa che naturalmente comprendeva l’irruzione dei movimenti: «Anche i movimenti», scriveva infatti, «appartengono a questa categoria di condivisione di sogni, di creazione di mondi», perché il movimento si configurava ai suoi occhi come uno «spostamento del luogo che porta gli individui nella condizione di vedere in comune un nuovo orizzonte, un orizzonte che non si vede che da quel luogo deterritorializzato» (MC 172-173).
«Punto di non ritorno»
Qualche anno dopo, in Exit, il discorso si faceva da questo punto di vista più chiaro, anche se forse proprio in questa fase la posizione di Berardi risentiva in modo ambiguo della seduzione dell’estetica cyberpunk. La via d’uscita dalla prospettiva della devoluzione – e cioè da una prospettiva in cui lo sviluppo delle forze in campo progrediva, senza però permettere loro una espressione lineare, e dunque rimanendo «entro modelli inadeguati, limitanti, cancerogeni» – era individuata infatti in «una mutazione che istituisca una nuova sintonia tra organismo cosciente e ambiente, tra cervello umano in funzione e sfere dell’intelligenza passata accumulata» (E 17). L’«evoluzione» cui pensava non era comunque un processo politico, bensì un processo antropologico, di cui – con più di qualche ambiguità – tratteggiava i contorni:
«Lo strumento che appare capace di agire sulla relazione mente-mondo è l’ingegneria neurochimica, e l’arte, che poco alla volta prende coscienza di essere una funzione dell’ingegneria neurochimica. Occorre agire sulla forma della relazione mente-mondo, e sulla consistenza neurochimica dell’attività mentale. Il metodo “Prozac” tende a diventare il metodo generale dell’azione di re-sintonizzazione mutagena. Milioni di persone prendono capsule che riprogrammano la mente umana: qui sta la svolta essenziale della civiltà occidentale. La riprogrammazione postumana, la fuoriuscita dall’umanità. La libertà futura è quella di riprogrammare il proprio corpo, la propria mente, la propria reattività grazie a tecniche di alterazione psicochimica e biogenetica. Libertà di essere quello che si vuole essere, cioè di proiettare il mondo che si vuole proiettare» (E 30).
Quando alla metà degli anni Novanta del secolo scorso rintracciava nel «metodo Prozac» una delle vie che potevano condurre nella direzione della «riprogrammazione postumana» e della «re-sintonizzazione mutagena», Berardi subiva probabilmente l’influenza di una sorta di ‘neo-psichedelismo’, che puntava a stabilire una connessione tra le contro-culture degli anni Sessanta e le utopie cyberpunk, e che trovava un campo di elaborazione per esempio nei testi e nelle iniziative di Franco Bolelli[36], oltre che in alcune iniziative dell’editrice Castelvecchi[37]. Il fascino di questa opzione doveva però rapidamente dissolversi, e già pochi anni dopo, al volgere del millennio, nelle pagine di La fabbrica dell’infelicità la prospettiva almeno sotto questo profilo sembrava essersi nettamente modificata. Le coordinate interpretative generali della trasformazione rimanevano immutate, ma si approfondiva la fenomenologia della condizione del «lavoratore cognitivo», che sottolineava in particolare come questa nuova figura tenda a considerare il lavoro «come la parte più interessante della sua vita» e come, per questo, cessi di opporsi «al prolungamento della giornata di lavoro», estendendo anzi il tempo di lavoro «per propria decisione e volontà» (FI 55). Naturalmente la sensazione di indipendenza e di autonomia dell’«infolavoro» nascondeva la realtà di una «nuova forma di dipendenza», incarnata «nella fluidità automatica della rete», la quale consentiva già allora – per esempio mediante il telefono cellulare – la «ricombinazione continua di una miriade di frammenti di produzione, elaborazione, smistamento e decodifica dei segni, e di unità informazionali di ogni tipo» (FI 68-69)[38]. Se una componente rilevante del post-operaismo italiano vedeva in queste trasformazioni un segnale dell’esaurimento della legge del valore e, dunque, della caduta della razionalità produttiva del sistema basato sullo scambio mercantile, a Berardi interessavano più le conseguenze psico-sociali di un totalizzante investimento di desiderio nel lavoro. E cioè innanzitutto la «desolidarizzazione generalizzata» (FI 56), il panico e la «depressione di massa». «La depressione», scriveva per esempio, «è intimamente legata all’ideologia dell’autorealizzazione, e all’imperativo felicista», e proprio in questo senso notava anche che l’«uso delle sostanze psicostimolanti o antidepressive» era «l’altra faccia della nuova economia», e che «l’assuefazione alle sostanze psicotrope, quelle che si comprano in farmacia e quelle che si comprano al mercato illegale» era «un elemento strutturale dell’economia psicopatogena» (FI 76). Come si è visto, non si trattava di elementi nuovi, perché Berardi aveva già evocato il panico e la depressione come conseguenze della pervasività dell’infosfera, ma senza dubbio nella Fabbrica dell’infelicità – in chiave critica, nei confronti per esempio di entusiasti della Rete come Pierre Lévy, ma in realtà anche in chiave (implicitamente) autocritica, rispetto al moderato ottimismo di alcuni anni prima – l’enfasi sulle componenti «psicopatogene» della nuova economica cresceva notevolmente. E, soprattutto, queste componenti venivano a contrassegnare non tanto uno specifico utilizzo delle nuove tecnologie, quanto la stessa struttura dell’«infosfera»:
«L’infinita varietà dell’infosfera supera le capacità di elaborazione dell’organismo umano tanto quanto la sublime natura supera le capacità di sentimento dell’uomo greco, quando il dio Pan si presenta all’orizzonte. L’infinita velocità di espansione del ciberspazio e l’infinita velocità di esposizione di segnali che l’organismo percepisce come vitali per la sopravvivenza producono uno stress percettivo, cognitivo e psichico che culmina in un’accelerazione pericolosa di tutte le funzioni vitali, il respiro, il battito cardiaco, fino al collasso. […] non si tratta tanto di una psicopatia individuale, ma della manifestazione individuale di una psicopatia sociale largamente diffusa, tendenzialmente generalizzata. E il comportamento collettivo che mostra i segni più evidenti del panico. D’altra parte il panico collettivo genera fenomeni come l’aggressività irrazionale contro gli emigrati, come la violenza insensata di massa negli stadi, ma anche fenomeni apparentemente normali come quelli che caratterizzano le relazioni personali nello spazio urbano contemporaneo» (FI 78-79).
Sebbene non si trattasse di temi nuovi per la riflessione di Berardi, gli elementi della fenomenologia della «mutazione» parevano ormai coordinarsi sempre più strettamente dentro una visione quantomeno più cupa, in cui le tracce di speranza, se non svanivano del tutto, divenivano comunque più labili. E così appariva già nei suoi tratti di fondo l’ipotesi che sorregge Heroes, e che stabilisce una connessione diretta tra il «sovraccarico infosferico», la «desolidarizzazione» e le manifestazioni più o meno devastanti della «psicopatia sociale»:
«Questi comportamenti non possono essere affrontati con gli strumenti della persuasione politica o della repressione giudiziaria per il semplice fatto che non hanno quasi nulla a che fare con la politica, l’ideologia, ma dipendono da una psicopatia sociale scatenata dal sovraccarico infosferico, dall’iperstimolazione e dallo stress cognitivo ininterrotto a cui l’organismo sociale è sottoposto a causa dell’elettrocuzione permanente. E l’elettrocuzione permanente è la condizione normale di un sistema in cui le tecnologie comunicative di rete (che inserisce l’organismo in un flusso infinito iperveloce di segnali economicamente rilevanti) sono usate in condizione sociale competitiva. Quando l’organismo raggiunge un punto insostenibile di sovraccarico può manifestarsi una crisi di panico che lo porta al collasso, oppure può determinarsi uno scollegamento dell’organismo dal flusso della comunicazione, e una improvvisa demotivazione psichica che gli psicologi chiamano depressione» (FI 79).
Dinanzi alla portata di questa trasformazione, Berardi riconosceva però anche qualche ambivalenza, e in particolare ravvisava nel movimento di Seattle il primo segnale di una possibile azione di «ricombinazione». Il «cognitariato», e cioè il soggetto del lavoro cognitivo, non era comunque da interpretare come un soggetto più o meno potenzialmente ‘centrale’, come negli anni Sessanta era stato l’«operaio massa», e soprattutto la sua azione – che pure Berardi auspicava ponesse alla base la rivendicazione di un «salario minimo planetario» – non doveva essere intesa in termini politici, bensì come un’azione di «ricombinazione». «L’azione culturale, sociale, politica, che si svolge nella rete telematica non è affatto un processo sovrastrutturale», e proprio per questo la caratteristica necessaria per un movimento radicale doveva consistere «nella capacità di attraversare i circuiti della comunicazione globale con i flussi destrutturanti» (FI 188). Il concetto guida diventava così, ai suoi occhi, quello di «ricombinazione», sempre nella convinzione che «solo il lavoro cognitivo» potesse «decostruire e ricombinare la macchina di coordinazione produttiva del capitale globalizzato» (FI 190)[39].
Nei quindici anni che separano La fabbrica dell’infelicità da Heroes, Berardi non ha cessato di impegnarsi generosamente per dare concretezza all’idea della «ricombinazione» come forma di azione capace di contrastare la logica del «semiocapitalismo»[40]. L’11 settembre 2001 doveva però calare più di un’ombra sulle speranze della «ricombinazione», ed era proprio a ridosso degli attentati contro le Twin Towers che Berardi iniziava a delineare la sua previsione più fosca, secondo la quale il sucidio-omicidio si massa era destinato a diventare un’«epidemia». Dopo gli attacchi, in un testo in cui riprendeva alcune suggestioni di Jean Baudrillard, scriveva infatti che la vera novità emersa l’11 settembre, vero e proprio «punto di non ritorno», era il «suicidio micidiale»:
«Negli ultimi tempi abbiamo assistito alle prime manifestazioni di questa nuova moda, che nei prossimi anni è destinata a dilagare. Una pandemia di furiosa infelicità si sta diffondendo: seduzione consumista ed esclusione fanno una miscela spaventosa nella periferia povera del mondo. Il crollo delle illusioni idiote della new economy diffonde l’infelicità nelle stesse metropoli occidentali. Folle di giovani maschi umiliati si vestiranno di esplosivo e andranno a farsi esplodere nei bar affollati dell’ora di punta. […] Nessuna civiltà può resistere all’onda d’urto del suicidio di massa, e nessuna repressione potrà fermarla. […] Ciò che spinge al suicidio sono l’odio e la disperazione, due beni disponibili in grande e crescente quantità. A questo si aggiunge la disponibilità di strumenti di sterminio che può usare chiunque abbia una conoscenza tecnologica poco più che elementare. Il punto di non ritorno è superato. Il suicidio micidiale dilaga come un virus autoreplicante, provoca reazioni aggressive da parte dei dominatori, e queste a loro volta moltiplicano le azioni di suicidio micidiale. Nel pianeta dilaga il disumano, incontenibile perché pervasivo e autoreplicante»[41].
Nel clima successivo all’11 settembre 2001, Berardi non esitava a evocare anche lo scenario apocalittico di un futuro ormai prossimo, nel quale «il contagio cannibalistico» si sarebbe diffuso «nelle pieghe della vita quotidiana, eliminando centinaia di milioni di discendenti dell’uomo di Neanderthal, e distruggendo ogni residuo culturale di umanità, per lasciare in vita tribù ipertecnologiche disumane»[42]. E anche se avrebbe in seguito moderato i toni apocalittici, Berardi non avrebbe nella sostanza rivisto quell’ipotesi così fosca, che alcuni anni dopo – in Dopo il futuro, un saggio concepito come una sorta di contrappunto al Manifesto futurista di Marinetti, a un secolo dalla sua pubblicazione – tornò infatti a ribadire ulteriormente. A dispetto di ogni utopia, sosteneva allora Berardi, la net-economy aveva sancito una completa «flessibilizzazione» e «frattalizzazione» del lavoro, la «totale dipendenza del lavoro cognitivo dall’organizzazione capitalistica della rete globale» e la «dipendenza del pensiero dal flusso di informazione» (DF 107). Queste trasformazioni non producevano solo implicazioni politiche o economiche, perché in realtà innescavano soprattutto «una psicopatologizzazione della relazione sociale», di cui erano sintomi evidenti l’utilizzo massiccio di psicofarmaci, l’epidemia di disturbi dell’attenzione e anche la diffusione del suicidio. «Il fenomeno suicidiario», scriveva Berardi, «è divenuto l’atto politico cruciale sulla scena politica globale», un fenomeno che sembrava suggerire che il genere umano era ormai «fuori tempo massimo» e che la disperazione era diventata «il modo prevalente di pensiero sul futuro» (DF 108). «Ci stiamo abituando all’idea di convivere con una disperazione pericolosa che costeggia sempre più da vicino la vita quotidiana», e proprio in uno scenario in cui il futuro era destinato a divergere radicalmente dalla speranza, il suicidio acquistava un significato diverso rispetto al passato. «Il suicidio», e in particolare «il suicidio micidiale, la strage che si accompagna alla cancellazione della propria esistenza senza speranza e senza futuro», scriveva infatti Berardi, «è il vero fenomeno emergente dell’epoca che segue al crollo di ogni speranza, al dissolversi di ogni alternativa sociale e politica» (DF 127). E proprio questa ipotesi viene oggi a costituire il cuore di Heroes, oltre che l’elemento più sconcertante di un quadro sempre più privo di elementi di speranza, sempre più vicino a una distopia senza alcuna via d’uscita.
Certo l’odierno pessimismo di Berardi può apparire semplicemente come una conseguenza delle trasformazioni del «semiocapitalismo», ma probabilmente non è solo il frutto dell’indagine condotta – con indubbia coerenza – sulle metamorfosi del lavoro e, più in generale, sul complesso di una «mutazione» che viene a modificare la condizione umana. Oltre a scaturire dall’esplorazione degli effetti che comportano la «frammentazione» e la «frattalizzazione» del lavoro, il pessimismo di Heroes – come cercano di mostrare le prossime pagine – nasce infatti anche dalle conseguenze delle scelte teoriche compiute da Berardi negli anni Settanta, con l’obiettivo di contrastare le derive ‘politiciste’ dei gruppi della sinistra radicale e, al tempo stesso, di raccogliere la sfida che proveniva tanto dalla ‘rivoluzione’ femminista del «partire da sé», quanto dalla critica della «vita quotidiana» concretamente praticata dai movimenti metropolitani. È infatti proprio per un coerente sviluppo di quelle scelte che Berardi è giunto a ‘rimuovere’ dal proprio campo teorico la politica, e dunque a espellere qualsiasi elemento di potenziale conflitto dal cupo affresco del «semiocapitalismo».
Composizioni
Così come l’indagine sulla metamorfosi del lavoro, anche la critica della politica contrassegna fin dalle prime tappe il percorso di Berardi, anche perché essa viene intesa – non senza fondamento – come uno sviluppo del tutto lineare delle ipotesi operaista. Ipotesi cui certo l’intellettuale bolognese impresse una curva originale, ma di cui però non abbandonò le principali intuizioni. In effetti Berardi può essere considerato come il più visionario fra gli esponenti di quel filone teorico-politico – ben più eterogeneo di quanto spesso si riconosca – che fu l’operaismo italiano[43]. E da questo punto di vista, il suo primo libro, Contro il lavoro, che poco più che ventenne pubblicò nelle Edizioni della Libreria Feltrinelli[44], segnalava già in modo evidente come la sua lettura della «rivoluzione copernicana» proposta da Mario Tronti in Operai e capitale procedesse in una direzione ben diversa da quella seguita da quasi tutte le componenti dell’operaismo e del post-operaismo: non tanto perché riconosceva nelle lotte operaie il motore dell’innovazione tecnologica, quanto perché rompeva piuttosto nettamente con alcuni principi di fondo della tradizione novecentesca del movimento operaio, come soprattutto l’idea della conquista la macchina dello Stato come tappa necessaria verso l’edificazione del socialismo, e perché configurava la «rivoluzione» come un processo conflittuale che procedeva nella direzione di una progressiva riduzione dell’orario di lavoro[45]. Ma in questa rilettura, la posizione di Berardi era probabilmente molto più fedele al metodo indicato dalla «rivoluzione copernicana» di quanto non fossero invece le versioni che, al principio degli anni Settanta, ‘riscoprivano’ il leninismo e tornavano a riaffermare la necessità di un partito di avanguardie politiche. Proprio l’avversione al leninismo (e al ‘politicismo’ che ne derivava, nella lettura proposta dai principali gruppi della sinistra «extraparlamentare» dei primi anni Settanta) doveva indurre Berardi a mettere severamente in discussione non solo una specifica forma organizzativa, ma, per molti versi, la stessa idea di un’azione politica organizzata.
Il punto di avvio di questa critica – che si intreccia sempre con la riflessione sul nuovo ruolo del lavoro intellettuale – risale a più di quarant’anni fa, e cioè al momento in cui, già nel 1970, Berardi uscì da Potere operaio, sulla base delle convinzione che questa organizzazione avesse abbandonato l’impostazione originaria – che incentrava tutte le rivendicazioni su un piano strettamente salariale – e avesse invece adottato un quadro molto più tradizionale, segnato dal recupero del leninismo, da un marcato politicismo e da un esasperato volontarismo[46]. In questo modo – come avrebbe sostenuto retrospettivamente Berardi, quasi trent’anni dopo – Potere operaio aveva finito col recuperare una vocazione «prometeica», secondo la quale la conquista dello Stato (o quantomeno lo scontro con la «macchina» dello Stato) era il passaggio obbligato per realizzare un radicale progetto di trasformazione delle relazioni sociali. Ma, al tempo stesso, spostando l’asse della sua azione verso il confronto-scontro con lo Stato, Potere operaio aveva anche riconvertito i propri obiettivi, che erano passati dall’azione rivendicativa nei luoghi di lavoro alla costruzione di un «partito» rivoluzionario non molto lontano dal modello bolscevico (e dunque a un’attività indirizzata principalmente al proselitismo e alla formazione ideologica delle «avanguardie»)[47]. Proprio nel tentativo di contrastare la deriva imboccata da Potere operaio (e dallo stesso Negri), a partire dal 1970 Berardi intraprese una strada che l’avrebbe condotto a considerare come ormai inservibile il modello organizzativo ‘leninista’ o ‘neo-leninista’, centrato sul ruolo delle avanguardie (tanto ‘esterne’, quanto ‘interne’). Proseguendo quella stessa strada, in seguito Berardi avrebbe inoltre sviluppato una «critica della politica» sempre più radicale: una critica che sarebbe approdata non solo ad attaccare le ipotesi sull’«autonomia del politico», ma soprattutto a negare qualsiasi autonomia reale, e dunque qualsiasi potenzialità, all’azione politica. Lungo quel percorso – in cui Berardi avrebbe incontrato tanto il pensiero di Deleuze e Guattari quanto le sollecitazioni che provenivano dal movimento femminista – si sarebbe delineata una riflessione estremamente originale, che peraltro sviluppava fino al punto estremo alcune delle originarie ipotesi dell’operaismo di Tronti[48].
Il rifiuto della deriva leninista di Potere operaio indusse Berardi innanzitutto a storicizzare l’esperienza dei gruppi extra-parlamentari della fine degli anni Sessanta. «I gruppi rivoluzionari», si leggeva per esempio nelle pagine introduttive di Scrittura e movimento, datate aprile 1973, «hanno segnato l’inizio della loro fine proprio nel momento in cui hanno riscoperto il leninismo», perché da allora avevano iniziato a pensare «che il movimento dovesse essere diretto dal loro ‘progetto’» e che dunque «gli organismi di massa (comitati, nuclei, assemblee, consigli) fossero o dovessero funzionare come effettive cinghie di trasmissione della loro direzione» (SM 12). Al contrario, il movimento, secondo la lettura di Berardi, era ormai sostanzialmente in grado di determinare in modo del tutto autonomo dalle organizzazioni le proprie scadenze conflittuali, ma il dato era soprattutto che la proliferazione dei «comportamenti» conflittuali – attraverso un’estensione a cerchi concentrici, che dalla fabbrica raggiungeva il territorio – poneva una serie di problemi diversi rispetto al passato. Nonostante questa analisi sembrasse convergere con la lettura proposta in quegli stessi mesi da Negri (anche per l’utilizzo di espressioni fortemente ambigue)[49], in realtà lo sviluppo successivo andò in una direzione differente, che escludeva totalmente qualsiasi margine di riutilizzo di schemi anche vagamente ‘neo-leninisti’: la convinzione era infatti che i «comportamenti» e i «bisogni» contenessero in se stessi una potenzialità antisistemica (che non richiedeva alcuna mediazione politica), ma anche che qualsiasi mediazione organizzativa dovesse finire col riprodurre meccanismi distorsivi, destinati a deviare la spinta conflittuale verso obiettivi fittizi. Proprio in questa fase, d’altro canto, la crisi del gruppi innescò un lungo dibattito diretto contro l’idea di una militanza concepita come ‘missione’ e come ‘sacrificio’ personale. Come scrisse il Gruppo Gramsci in uno dei suoi documenti più significativi, era necessario «un diverso modo di fare politica», che non rimuovesse la dimensione ‘privata’ della vita, ma che, al contrario, prefigurasse «concretamente e praticamente i primi embrioni di vita diversa» [50]. Dal punto di vista teorico, uno degli sforzi principali di rilettura dell’operaismo, capace di tener conto di questa estensione del conflitto, fu senza dubbio la «teoria dei bisogni» sviluppata sulle pagine della rivista «aut aut», anche sulla scorta di alcune suggestioni di Ágnes Heller[51]. Anche Berardi – che peraltro fin dal 1973 non aveva esitato a scrivere che «La pratica della felicità è sovversiva», per celebrare «l’esperienza di migliaia di giovani, che nel loro modo stesso di vita quotidiana si pongono fuori dell’establishment» (SM 9) – imboccò questo stesso sentiero, ma probabilmente egli portò a conseguenze ancora più radicali, anche sul piano teorico, la critica alla militanza.
Attorno alla metà degli anni Settanta, la nuova centralità dei «bisogni» e dei «comportamenti» suggerì a molti intellettuali militanti – tra cui naturalmente lo stesso Berardi – la necessità di riprendere e sviluppare quella «critica della politica» che Marx aveva solo abbozzato. Il fatto che quel progetto fosse considerato così urgente era legato, oltre che alle dinamiche del conflitto sociale, all’esigenza di criticare le ipotesi sull’«autonomia del politico» avanzate in quegli anni dal padre dell’operaismo, Mario Tronti, anche perché quelle ipotesi erano allora intese da molti come una sorta di legittimazione teorica della strategia del «compromesso storico» enunciata da Enrico Berlinguer e concretizzatasi nell’appoggio del Pci ai governi a guida democristiana[52]. Lo stesso Berardi non mancò di criticare le ipotesi trontiane degli anni Settanta[53], ma – a differenza di molti altri, che intesero la critica della politica sostanzialmente come un’indagine rivolta a mettere in luce le funzioni capitalistiche dello Stato e a chiarire quali fossero i margini conflittuali che in quella sfera si aprivano – utilizzò quel grimaldello teorico anche contro le pretese della ‘politica rivoluzionaria’ portata avanti dai gruppi. In Teoria del valore e rimozione del soggetto, forse uno dei suoi libri più importanti, non veniva infatti semplicemente svolta – come recitava il sottotitolo – una Critica dei fondamenti teorici del riformismo, perché Berardi si scagliava in special modo contro le stesse premesse della teoria leninista del partito (e in particolare contro l’idea cardine della «coscienza di classe»). La premessa di tutto il discorso, in cui emergeva già la combinazione fra l’impostazione operaista e la filosofia di Deleuze e Guattari, era che la società capitalistica si fondasse su una «rimozione» fondamentale, «la rimozione della soggettività autonoma di classe operaia, della classe come movimento che realizza i suoi bisogni nella lotta contro l’organizzazione del lavoro e per il potere» (TV 31). Se il compito politico che Berardi si prefiggeva consisteva nel far riemergere il ‘rimosso’, dal punto di vista teorico l’esigenza era invece quella di mostrare i meccanismi con cui la teoria marxista aveva provveduto a ‘rimuovere’ comportamenti e i bisogni. In questa prospettiva, la «politica» diventava semplicemente «il luogo in cui i bisogni delle masse sono ridotti ad immagine spettacolare, a riflesso di un riflesso, ritualizzati e ridicolizzati, mentre la loro reale urgenza è rimossa, cancellata» (TV 139). Ma se questa rimozione – che aveva raggiunto il culmine tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta – era stata messa in crisi dall’eruzione dei «bisogni» alla fine degli anni Sessanta, i gruppi della sinistra radicale avevano finito col riprodurre i medesimi meccanismi di ‘rimozione’, che in particolare occultavano la trasformazione che si svolgeva nella «vita quotidiana»:
«L’esperienza dei gruppi ha esaurito la propria capacità di direzione rivoluzionaria e di trasformazione del movimento, proprio perché non è più mediazione politica delle esigenze materiali delle masse, ed invece riproduce un vecchio modo di comporre le spinte politiche rimuovendone l’autonomia e la materialità, e riducendole entro categorie teoriche e schemi organizzativi volontaristici ed in ultima analisi terroristici e polizieschi. La politica, nella pratica dei gruppi – come dei partiti della tradizione seconda e terzo internazionalista – è unificazione terroristica; il personale, la forma della vita quotidiana, nella sua funzionalità ed interdipendenza con la forma complessiva dei rapporti di classe, viene terroristicamente ridotta alla forma categorizzata, passata, (rituale) del politico; e se rifiuta di essere ridotta a questo schema, viene rimossa, espulsa dalla sfera della politica, eliminata come residuo irriducibile alla politica. Ma il terreno della liberazione del personale, della collettivizzazione del quotidiano è il terreno decisivo – non meramente come sfera del ‘personale’, ma come terreno di trasformazione (organizzativa) dell’esistenza delle masse» (TV 140-141).
Nelle pagine di Finalmente il cielo è caduto è caduto sulla terra, l’analisi teorica sulla ‘rimozione’ dei bisogni si spostava verso il presente, proponendo – come alternativa a ogni struttura organizzativa più o meno leninista – la formula del «piccolo gruppo in moltiplicazione ed in ricomposizione trasversale» (FC 8). Se per un verso riconfermava la convinzione che «sul terreno del quotidiano» i bisogni collettivi raggiungessero «la loro qualità politica» (FC 23), Berardi salutava però solennemente anche la «fine della politica». Una «fine» determinata dalla stessa modificazione del conflitto, il quale dai luoghi del lavoro concentrato si era esteso alla società, penetrando nel reticolo di micro-comportamenti, per loro stessa natura inafferrabili dalla logica della mediazione politica, e alla ricerca piuttosto della via della ‘sottrazione’, ossia di quella che Berardi chiamava allora «separ/Azioni»:
«il terreno della politica, da sempre terreno della rimozione del soggetto, non può più darsi che come spettacolo quando il soggetto si colloca altrove ed emerge sulla scena della storia. Ed allora anche per il capitale, se pure il nucleo centrale di ogni suo sforzo resta la trasformazione del tempo di vita in valore, per la mediazione del lavoro, il sistema di controllo non può che articolarsi e seguire – disperatamente, però – la dinamica delle separ/Azioni, delle fughe. Ed ecco il sistema del controllo rincorrere il movimento su questo terreno post-politico, e farsi criminologia, psichiatria, sociologia del lavoro, analisi del linguaggio, nuova didattica, sociologia. E mentre i loschi figuri del riformismo armano nuovi Noske contro gli operai, e i loro professori ex-marxisti cianciano di ‘autonomia del politico’, la realtà delle cose è la fine della politica, la sua definitiva trasformazione in spettacolo, in nostalgica messa in scena del controllo del tutto sulle parti» (FC 34).
Lette a quasi quarant’anni di distanza, è inevitabile che le valutazioni formulate allora da Berardi debbano apparire segnate, più che da distorsioni ideologiche, dalle urgenze politiche del momento. Ciò nondimeno, non può sfuggire la lucidità con cui veniva intravista nel «terreno post-politico», proprio dei comportamenti, la dimensione in cui – più ancora che al livello dello scontro politico (e della repressione) – si sarebbero effettivamente giocati i destini della ristrutturazione. Sotto il profilo della riflessione teorica, uno degli aspetti più significativi del discorso era la rivendicazione dell’eredità dell’operaismo italiano, o quantomeno di alcune sue intuizioni. In effetti, in alcuni passaggi fondamentali, Berardi indicava lo strumento che aveva consentito di rompere il meccanismo della ‘rimozione’ dei bisogni, e dunque di reinserire il soggetto nella teoria, nella nozione operaista di «composizione di classe»:
«Non si deve partire dal partito per parlare della classe, né dallo Stato per capire il movimento, né dal capitale per capire la lotta: la classe operaia è il motore dello sviluppo, ma è quindi agente reale della ristrutturazione, delle vicende che vengono trasferite nel cielo della politica. Ma come possiamo allora comprendere, interpretare quello che accade nella realtà di classe, se solo partendo di là possiamo capire tutto il resto? La risposta sta proprio nel concetto di «composizione di classe», nel quale si comprendono non solo le relazioni sociali fra settori proletari e operai, fra strati sociali proletarizzati, non solo il rapporto fra lavoro vivo e lavoro morto, operai e struttura tecnologica, ma anche il patrimonio organizzativo, culturale, di consapevolezza che nel corpo concreto della classe è inscritto. Ecco così che le forme organizzative sono comprese come articolazioni del soggetto reale, e non come suoi surrogati ipostatici; e la coscienza di classe non è più l’idea socialismo a cui la classe-reale deve adeguarsi, ma diventa anch’essa una articolazione del movimento reale del soggetto. Ecco così che la storia non è più lo svolgimento necessario in cui i soggetti trovano la loro identità e mediazione, ma lo spazio reale ed impregiudicato in cui il soggetto operaio sviluppa la «sua» storia contro lo stato, la cui storia si pretende ‘Storia’» (TV 24)[54].
Il rilievo che assegnava alla nozione di «composizione di classe» non era puramente rituale, perché effettivamente l’intera riflessione di Berardi può essere considerata come uno sviluppo, o forse una ‘dilatazione’, di questa intuizione. A ben vedere, d’altronde, già nel suo primo libro Berardi aveva sostenuto la necessità di scoprire, «all’interno della composizione di classe e nella complessità dei rapporti tra operai e capitale non semplicemente un dato tecnico», ma soprattutto «tutta una fascia di rapporti politici, di organizzazione e di repressione, che di volta in volta si cristallizzano in un dato livello di sviluppo economico-tecnologico»[55]. E non casualmente, più di recente Berardi ha proposto di non utilizzare il termine «operaismo» per indicare il paradigma teorico che prende forma a partire dai «Quaderni rossi» e dalla «rivoluzione copernicana» di Tronti, perché quel termine – coniato peraltro, almeno inizialmente, con finalità polemiche – tradirebbe le intuizioni principali dell’intero filone. In alternativa, ha sostenuto così l’utilità della formula «composizionismo», una formula che, proprio enfatizzando l’importanza della «composizione di classe», sarebbe in grado di cogliere «qualcosa di più essenziale nel metodo e nello stile di pensiero» dei teorici dell’operaismo, oltre che di evidenziare le connessioni con la riflessione di Deleuze e Guattari:
«Che cosa vuol dire composizionismo? Vuol dire metodologia che si propone di analizzare il processo storico come intersecarsi, districarsi, comporsi, separarsi di flussi che hanno una consistenza quasi gassosa. La scienza della trasformazione sociale sta molto più vicino alla chimica degli stati gassosi che alla meccanica sociologica. Non ci sono forze compatte, soggetti unitari, portatori di volontà univoche. Non ci sono volontà; ci sono flussi di immaginario, depressioni dell’umore collettivo, improvvise illuminazioni. Dispositivi astratti che concatenano flussi. Valvole, rubinetti, mixer che tagliano, mescolano, combinano flussi ed eventi. Non c’è un soggetto che si oppone ad altri soggetti, ma vi sono flussi trasversali di immaginario, di tecnologia, di desiderio, e questi producono visione od occultamento, felicità o depressione collettiva, ricchezza o miseria. D’altra parte il processo storico non è un piano omogeneo sul quale si oppongono soggettività omogenee, oppure progetti linearmente identificabili, e linearmente confliggenti. È piuttosto un divenire eterogeneo nel quale agiscono segmenti differenti come l’automazione tecnologica, la psicosi panica, la circolazione finanziaria e l’ossessione identitaria o competitiva»[56].
La terminologia adottata da Berardi nella propria definizione del «composizionismo» mostra forse qualche consonanza con le formule utilizzate dal post-operaismo degli ultimi vent’anni, se non altro per la centralità assegnata alla riflessione di Deleuze e Guattari anche nelle opere di Hardt e Negri, ma risulta invece abissalmente distante dal lessico dell’operaismo degli anni Sessanta, e in special modo dalla terminologia adottata nelle formulazioni più classiche della teoria della composizione di classe, che si possono trovare soprattutto negli scritti di Romano Alquati e nelle ricerche di Sergio Bologna, oltre che naturalmente (ma in realtà solo in modo piuttosto implicito) in Operai e capitale. A dispetto di questa ‘discontinuità’ terminologica, il «composizionismo» di Berardi, così come la centralità che negli anni Settanta assegnava ai comportamenti e ai bisogni per la definizione della «composizione di classe», non costituiscono affatto una rottura concettuale rispetto al quadro operaista, o quantomeno con le linee della «rivoluzione copernicana» proposta negli anni Sessanta. Benché soprattutto Tronti conservasse anche allora più di qualche legame (non solo sentimentale) con la tradizione del movimento operaio e con il leninismo, la principale operazione compiuta in Operai e capitale consisteva infatti proprio nell’idea secondo cui il potenziale antagonista dei comportamenti operai all’interno del processo di produzione non richiedeva alcuna mediazione politica, e proprio questa idea avrebbe d’altronde suggerito l’immagine della «rude razza pagana», che, a dispetto della propria assenza di «ideali», disponeva della formidabile arma della pressione sul salario nella propria lotta contro il capitale. Già in quegli anni alcuni indizi facevano intravedere le prime tracce della svolta di Tronti verso l’«autonomia del politico»[57], ma l’idea di base formulata in Operai e capitale e al fondo dell’esperienza di «Classe operaia» sembrava comunque riconoscere una sostanziale autonomia, un carattere immediatamente ‘politico’ e una ‘oggettiva’ centralità proprio ai comportamenti operai. «La classe operaia», aveva scritto infatti Tronti, «possiede una strategia spontanea dei propri movimenti», mentre il partito «non ha che da rilevarla, esprimerla, organizzarla»[58]. E nel saggio più lungo compreso in Operai e capitale, ribadendo l’idea secondo cui la classe era «solo strategia», aveva anche precisato che «la strategia vive […] a quel livello in forma tutta oggettiva», nel senso che «una prospettiva strategica, come quel del rifiuto, si presenta materialmente incorporata nei movimenti di classe della massa sociale operaia»[59]. Nonostante una simile impostazione, lasciasse più di qualche margine alla reintroduzione di un ruolo del partito (se non altro perché non chiariva quali fossero i limiti entro cui poteva operare la «tattica»), Berardi non avrebbe fatto altro che sviluppare fino alle estreme conseguenze ‘spontaneiste’ la tesi trontiana che assegnava la definizione della «strategia» ai comportamenti materialmente depositati nella «composizione di classe». E d’altronde, quando nel 1970 polemizzò con la deriva leninista di Potere operaio, utilizzò proprio la vecchia tesi secondo cui la strategia si trovava tutta «nella classe» e nei «grandi movimenti che dentro le masse avvengono»[60].
Se dunque il «composizionismo» può essere considerato come uno dei più originali (e coerenti) sviluppi delle intuizioni operaiste, probabilmente quella impostazione era destinata a produrre delle conseguenze impreviste. Come avrebbe sostenuto Tronti negli anni Settanta, e come è tornato a sottolineare più di recente Carlo Formenti, l’operaismo tendeva infatti a trascurare l’«autonomia» della politica: un’autonomia che non coincide soltanto con l’autonomia della sfera istituzionale dalle logiche dall’accumulazione capitalistica, ma che comprende anche l’autonomia del ceto politico dalla ‘società’ e, forse soprattutto, i meccanismi di formazione delle identità collettive. Naturalmente non è solo questa sottovalutazione della complessità della politica a spiegare gli esiti successivi – talvolta abissalmente distanti, e in qualche caso persino contraddittori – del post-operaismo. Ma, forse, è proprio questa ‘rimozione’ della politica a chiarire quali siano le radici del pessimismo odierno di Berardi. Al termine di un più che quarantennale percorso – un percorso che si snoda dalla critica della struttura organizzativa ‘neo-leninista’ adottata dai gruppi della sinistra extra-parlamentare, alle sperimentazioni degli anni Settanta, alla ‘traversata del deserto’ compiuta negli anni Ottanta – oggi Berardi giunge infatti non tanto ad articolare una semplice ‘critica’ della politica, quanto a operare una vera e propria ‘rimozione’ della politica. E – come si vedrà nelle prossime pagine – è quella stessa ‘rimozione’ che oggi conduce verso il vicolo cieco di un implacabile pessimismo, e – non senza paradossi – ad accantonare quelle medesime intuizioni del filone teorico «operaista» di cui pure Berardi (pur con qualche piccola riserva) ha sempre tentato di custodire l’eredità più preziosa.
«Fine della politica»
Non è certo difficile trovare qualche dimostrazione all’ipotesi secondo cui Berardi avrebbe eliminato la politica dal proprio quando teorico. Persino il più distratto lettore di «Bifo» è anzi destinato a trovare nei suoi testi degli ultimi trent’anni decine di passaggi in cui si avverte che le strategie per affrontare la «mutazione» e le sue insidie non possono essere rinvenute sul terreno ‘politico’. Al principio degli anni Novanta, scriveva per esempio che, dinanzi al «mutamento paradigmatico», «i tempi della politica non sono più capaci di interagire utilmente con quelli della mutazione in corso», e che per questo era necessario «pensare ad altre temporalità, quella lentissima dell’adeguamento culturale e quella velocissima delle tempeste neurochimiche»[61]. In Neuromagma, pochi anni dopo, questa tesi sarebbe ritornata rafforzata dall’idea secondo cui la mutazione in corso determinava una sorta di ‘estinzione’ della politica come sfera della decisione autonoma rispetto al circuito produttivo e alla dimensione della programmazione. «Il problema della politica», scriveva infatti commentando Pierre Lévy, «viene interamente assorbito dentro l’attività stessa del lavoratore mentale, e in particolare del programmatore», con una serie di conseguenze radicali. «La scelta tra alternative», per un verso, «non si colloca più al livello della macropolitica, delle decisioni globali che si prendono dall’alto dello Stato, ma a un livello microfisico, microsociale, delle interfacce tecniche e delle interfacce tecnosociali, a un livello che possiamo definire nanopolitico» (N 46). Dall’altro, precisava, «la politica non può più essere considerata come scelta globale sull’insieme delle funzioni sociali esercitata dall’alto di una funzione decisionale estranea alla produzione», perché «diviene scelta puntuale e determinata fra alternative d’uso di un sapere, invenzione di interfacce tra informazione cristallizzata e uso sociale, architettura congitiva, ecologia della comunicazione» (N 48). E nella Fabbrica dell’infelicità tornava a ripetere, ancora una volta:
«Forse è della politica che occorre propriamente sbarazzarsi. Quest’arte del governo non ha infatti più alcun realismo in una società infinitamente complessa, nella quale la volontà è incapace di perseguire i suoi scopi, e nella quale gli scopi sono miraggi, perché non poggiamo più i piedi su un terreno stabile, ma navighiamo in un oceano assolutamente instabile. Siamo alla ricerca di un metodo del cambiamento che sia libero dalle premesse (ora ingannevoli) della governabilità, della finalità, della riducibilità del mondo a disegni razionali. La politica fu una tecnica capace di produrre effetti d’insieme a partire dal governo di un certo numero di processi decisivi. Noi dobbiamo agire in una situazione nella quale i processi decisivi sono infiniti, ingovernabili, e i mutamenti hanno carattere frattale e ricombinante. È del tutto insensato proporsi un rovesciamento dell’oceano frattale nel quale navighiamo. Solo andando nel senso del processo possiamo introdurre elementi di modificazione del processo. La modificazione può avere solo un carattere frattale, e in nessun modo un carattere frontale» (FI 23).
Anche se le pagine finali di Heroes riformulano in termini sostanzialmente analoghi a trent’anni fa la proposta di una «saggezza innocente» e dell’ironia, si potrebbero leggere come piccole indizi di una almeno implicita revisione della valutazione sul ruolo della politica l’interesse e la speranza con cui Berardi ha negli ultimi anni guardato a Occupy Wall Street, alla Primavera araba, agli Indignados (ossia a movimenti capaci di «riattivare la dinamica sociale della solidarietà e della lotta consapevole della classe sfruttata per farla finita con lo sfruttamento»[62]), e anche la simpatia con cui ha osservato l’ascesa del Movimento 5 Stelle in Italia e la vittoria elettorale di Syriza[63]. Ma la ‘revisione’ operata su questo punto non deve essere sovradimensionata, perché – a dispetto di queste tracce – Berardi continua a ribadire ancora una volta la medesima sfiducia nelle possibilità dell’azione politica.
Nel recente La nonna di Schäuble, un volume nel quale raccoglie alcuni scritti dedicati alla crisi dell’Unione europea, Berardi aggiunge per esempio ulteriori motivi al suo pessimismo, affiancando all’analisi delle conseguenze ‘strutturali’ dei processi descritti in Heroes, anche una diagnosi spietata del drammatico fallimento di tutte quelle speranze che avevano visto nell’Europa unita uno spazio possibile per estendere la democrazia e la cittadinanza: un fallimento che, per Berardi, è destinato a innescare derive incontrollabili verso la violenza e persino verso la guerra. La sconfitta politica patita dal governo greco nel luglio 2015, dopo che gli elettori ellenici si erano dichiarati in maggioranza per il «No» alle condizioni poste dalle istituzioni internazionali per rifinanziare il debito, segna infatti per Berardi – e non senza ragioni – il capolinea del progetto europeo[64]. E, da questo punto di vista, con un’onestà intellettuale che neppure il suo più acerrimo critico potrebbe negargli, compie un’autocritica radicale, nella quale rimprovera a se stesso – e a buona parte degli intellettuali radicali europei – il sostegno alla causa europeista, e dunque di non avere compreso quale fosse il destino inevitabile scritto a Maastricht un quarto di secolo fa. «Troppo a lungo abbiamo creduto che il problema fosse ‘più Europa politica’, più democrazia e simili baggianate», scrive nell’introduzione al volume, «mentre da Maastricht in poi si stava costituendo un dispositivo assolutamente originale la cui funzione va intesa in una prospettiva molto più ampia», una prospettiva che ambiva a «cancellare la specificità europea del secolo operaio, la specificità europea della democrazia sociale e della solidarietà» (NS 20-21)[65]. E in questo senso riconosce il clamoroso errore di appoggiare la causa del «Sì» in occasione dei referendum del 2005 sulla Costituzione europea in Francia e Olanda, una sorta di punto di snodo di tutte le vicende successive, nella convinzione – del tutto ‘progressista’ – che la realizzazione di un mercato europeo effettivamente unico e privo di barriere fosse la condizione necessaria per avviare un processo liberatorio[66].
La sconfitta di Alexis Tsipras nella trattativa con le istituzioni europee, agli occhi di Berardi, sembra dunque confermare in modo inequivocabile l’impossibilità, a qualsiasi livello, di un’inversione di rotta. È facile prevedere che l’effetto della resa di Syriza sarà il crollo della residua credibilità delle forze politiche di sinistra», scrive per esempio, non senza aggiungere – in termini che non sembrano lasciare margini di ambiguità – che «la nuova composizione precaria del lavoro sembra impedire la formazione di un movimento di lotta sociale», che «nella composizione sociale del presente non sembra potersi formare resistenza, né opposizione politica, perché la struttura produttiva precaria rende impossibile l’organizzazione solidale», e che «cinismo isolamento depressione sono le conseguenze di questa condizione» (NS 16-17). La valutazione generale del ruolo e delle potenzialità della politica sembra dunque uscire addirittura rafforzata dalla catastrofe europea e dalla visione cupa – ma al tempo stesso realistica – della deriva nazionalista che attende il Vecchio continente. E naturalmente secondo Berardi la via d’uscita da questo micidiale circolo vizioso non può passare dalla politica, ma solo – ancora una volta – da una logica di ‘sottrazione’:
«Occorre partire dal coraggio della disperazione, occorre fare di questo coraggio il punto di formazione di un nuovo stile culturale che sta al di là della pretesa politica di governare il futuro. Ciò significa prima di tutto: dire la verità, senza riproporre soluzioni che non funzionano più, e senza attribuire alla volontà una funzione che la volontà non ha più. Salvaguardare il nucleo di possibilità progressiva che il capitalismo non ha finora potuto distruggere, che consiste nel contenuto scientifico e tecnico del lavoro cognitivo. Inventare forme di sopravvivenza e di felicità nei margini, e avviare un processo lento di autonomia, che sia al contempo lento sgretolamento del castello malefico del capitalismo finanziario» (NS 22-23)[67].
Come si è visto, una concezione tanto radicale quanto duratura dell’impotenza della politica non nasce da vicende contingenti, ma è il frutto di un lungo percorso anche auto-critico, un percorso le cui prime tappe risalgono già ai primi anni Settanta. È importante però notare che, quando Berardi liquida la «politica», relegandola tra i relitti del passato novecentesco, in realtà si riferisce a due aspetti differenti (anche se fra loro connessi). Innanzitutto, allude all’idea secondo cui la politica identifica una sfera di decisione non solo autonoma rispetto alle dinamiche economico-sociali, ma dalla quale sia possibile operare in modo ‘demiurgico’ sulla società, dando compimento concreto a un progetto di trasformazione. In secondo luogo, intende indicare la dimensione ‘ideologica’ della politica, ossia la sfera delle identità cristallizzate, che finiscono col limitare la libertà del singolo e con l’indirizzare il suo comportamento. Anche in questo caso le radici di una simile impostazione vanno individuate nella combinazione tra l’operaismo e la filosofia di Deleuze e Guattari, oltre che naturalmente nel coerente sviluppo della critica della politica articolata negli anni Settanta. Ma ciò che più importa è la critica all’«identità» e alle sue «trappole» dell’identità, una critica di cui non è certo difficile trovare le tracce nelle pagine di Berardi, e che riveste davvero un ruolo chiave per spiegare gli sviluppi odierni della riflessione dell’intellettuale bolognese.
«L’identità», scriveva per esempio Berardi in Neuromagma, «nasce dal bisogno di affermare la verità in nome di un’appartenenza, e costituisce un surrogato di sicurezza», perché, dal momento che «non possiamo trarre sicurezza dalla realtà», «speriamo di trovare sicurezza nell’identità, nella continuità fanatica delle nostre proiezioni, nell’ossessione di una corrispondenza tra queste proiezioni e la realtà» (N 12). «L’identità», precisava inoltre, «è il sé visto dall’altro, la delimitazione del sé da parte dell’altro, e dunque anche la definizione dell’altro come limitazione, pericolo, potenziale aggressione» (N 13). Una simile caratterizzazione dell’identità chiarisce già come per Berardi l’identità tenda a costituire una «trappola», che impedisce le relazioni con l’altro, che alimenta la contrapposizione, che costruisce barriere ‘fittizie’ fra gli individui, e non è affatto sorprendente allora che scriva che «i confini dell’identità etnica, linguistica, sessuale possono essere definiti soltanto con un’operazione di violenza e di ignoranza» (N 13). Ma questi aspetti così negativi vengono ulteriormente aggravati dalla «mutazione» in corso, perché, dinanzi alla «frammentazione» e alla «frattalizzazione» dell’esperienza, la risposta tende a essere quella che Berardi definisce – seguendo ancora una volta Deleuze e Guattari – una «riterritorializzazione» aggressiva. Lo sradicamento e la deterritorializzazione prodotta dal capitalismo produce infatti una tendenza a ricostruire nuove identità: «La perdita d’identità produce una reazione di paura, d’insicurezza psichica», scriveva per esempio al principio degli anni Novanta, «e può mettere in moto processi di ricerca disperata di un’identità nell’unico modo che resta possibile: attraverso l’aggressione nei confronti dei diversi, attraverso una riaffermazione artificiosa ma violenta di un rapporto con l’origine, con la radice, con il mito di superiorità che l’omologazione capitalistica ha inesorabilmente cancellato»[68]. Coerentemente, l’«ossessione dell’identità» è allora «indissociabile dell’aggressione e dall’odio, perché non si può più ritrovare la propria origine se non attraverso il sangue dell’altro, non si può ritrovare la propria verità se non leggendola attraverso la distorsione che l’altro ne compie» (MC 100-101). Proprio ribadendo questa convinzione in Heroes Berardi scrive allora che l’«ossessione dell’identità primitiva» non può essere altro che «un vicolo cieco, perché la verità sul tuo essere è nelle mani del tuo nemico, e solo la trasgressione del divieto dell’oppressore ti conduce al nucleo della tua appartenenza», tanto che, per questo, «afroamericani e armeni, tibetani e tamil, tutte le popolazioni che hanno perduto la relazione vivente con la loro tradizione possono trovarla solo negli occhi dell’oppressore» (H 139).
La critica all’identità e alle sue implicazioni politiche è comprensibile, e per molti versi condivisibile. Ma, a ben vedere, non si tratta solo di una critica indirizzata alle pretese delle identità etniche di essere ‘naturali’ o ‘originarie’. Oltre a riconoscere che tutte le identità – specie nel processo di deterritorializzazione – non possono che essere costruzioni ‘culturali’, Berardi tende a considerare l’identità – e dunque ogni identità – come una «trappola», che tende a bloccare il processo conoscitivo e a innescare meccanismi di ‘ritribalizzazione’. «L’identità», scriveva per esempio in Mutazione e cyberpunk, «è una mappa che pretende di guidare lungo il percorso, ma mente», «è il meccanismo in base al quale noi pretendiamo di ‘riconoscere’, di conoscere già, di possedere per appartenenza il sistema di valori, il sistema delle ritualità adatte per tenere il mondo sotto controllo», e in questo senso non è altro che «una menzogna, un fattore di irrigidimento» (MC 92-93). Ed è proprio l’idea secondo cui l’identità è una «menzogna» e «un fattore di irrigidimento» a costituire un ostacolo non da poco per la riflessione di Berardi. Se infatti la visione dell’identità è del tutto coerente con la proposta di Deleuze e Guattari, e se rappresenta anche un lineare svolgimento della critica della politica articolata nel corso degli anni Settanta, è però anche un elemento che tende a indirizzare le ipotesi di «Bifo» verso un vicolo cieco teorico. Un vicolo cieco che, per un verso viene, a ‘neutralizzare’ le intuizioni del metodo «composizionista», mentre, per l’altro, conduce la ricerca verso un pessimismo assoluto, dal quale sparisce ogni margine di conflitto possibile.
Da un punto di vista generale, la visione dell’identità proposta da Berardi può suggerire una serie di obiezioni, o quantomeno di quesiti, la cui risposta è tutt’altro che scontata. Innanzitutto, pur concordando con l’idea secondo la quale non esistono identità ‘originarie’ e secondo cui dunque tutte le identità sono sempre ‘invenzioni’ più o meno riuscite, ci si può chiedere se sia veramente possibile essere ‘senza identità’, o se si debba invece, più semplicemente, distinguere tra identità più ‘rigide’ e identità più ‘fluide’, o persino ‘liquide’, come vuole la metafora proposta da Zygmunt Bauman. Ma, se si riconosce che tutte le identità sono prodotti ‘culturali’, è inevitabile trovarsi dinanzi alla difficoltà di una loro valutazione ‘politica’, perché ovviamente non è possibile considerare un’identità come ‘più progressista’ di un’altra, o più ‘reazionaria’ e retriva di un’altra, se non attingendo all’immagine illuminista del progresso, o recuperando invece una filosofia della storia che assegna allo sviluppo capitalistico una funzione civilizzatrice e dunque la capacità di creare un soggetto ‘universale’ come la classe operaia. Talvolta Berardi sembra proprio evocare una simile raffigurazione, come per esempio nel caso in cui in Heroes scrive che «la classe operaia è lo spazio dell’assoluto sradicamento, dell’attiva dimenticazione di ogni identità», e che «grazie allo sradicamento divenne possibile la ricerca di un principio universale di emancipazione» (H 140). Ma evidentemente, se seguisse davvero questa strada (che certo consentirebbe di stabilire un discrimine netto tra un’identità universale ‘buona’ e un’identità originaria ‘cattiva’ e fittizia), Berardi si troverebbe a revocare le proprie ipotesi di fondo almeno sotto due profili. Innanzitutto, perché si troverebbe a reintrodurre surrettiziamente quella filosofia della storia ‘progressista’ che ha strenuamente combattuto per quasi mezzo secolo, e, dunque, perché attribuirebbe all’«assoluto sradicamento» prodotto dalla deterritorializzazione capitalistica una funzione ‘positiva’, a prescindere dall’analisi dell’autonomia espressa dai lavoratori, per i quali la «perdita di umanità» (H 140), e cioè l’aumento dello sfruttamento reale, sembrerebbe invece un presupposto di liberazione. In secondo luogo, perché si troverebbe costretto a replicare quella distorsione teorica che aveva rimproverato al riformismo, ossia una ‘rimozione’ della realtà della classe, in virtù della quale l’unità della classe viene ricostruita non sulla base dell’analisi dei suoi movimenti spontanei, ma sulla base di una teoria capace di valutare il carattere ‘universale’ della coscienza della classe operaia (nella misura in cui essa possiede una visione corretta della ‘totalità’ del processo storico). Naturalmente Berardi – a dispetto dell’utilizzo di alcune espressioni – non può procedere in questa direzione, e così le tracce di un implicito ‘progressismo’ sono soltanto molto labili, e non devono neppure essere prese troppo sul serio. Ciò nondimeno, le insidie che presenta l’attacco costante indirizzato dall’intellettuale bolognese contro l’«ossessione identitaria» non possono essere liquidate come effetti di semplici infortuni linguistici, o come il pegno da pagare a un lessico militante stratificatosi nei decenni. Quelle insidie devono essere interpretate infatti come le spie di una contraddizione che mina dall’interno il quadro concettuale allestito da Bifo. Una contraddizione che pone l’uno contro l’altro il metodo «composizionista» e la «schizoanalisi» di Deleuze e Guattari, ma dinanzi alla quale Berardi non sembra disponibile a decidere. E il risultato di questa ‘indecisione’ – che per un verso spinge a ritenere centrale il metodo «composizionista», mentre dall’altro non rinuncia alla critica dell’identità (e della politica) mutuato dai due pensatori francesi – finisce col chiudere ogni spazio teorico al conflitto e, soprattutto, col neutralizzare lo stesso concetto di «composizione di classe».
Scomposizioni
Fin dagli anni Settanta, come si è visto, Berardi è un convinto sostenitore del concetto di «composizione di classe», un concetto elaborato originariamente da Alquati sulle pagine di «classe operaia» ma in seguito al centro di diverse rielaborazioni[69]. Il ricercatore cremonese, con quella formula si riferiva ai «movimenti» con cui «la classe operaia italiana tende oggi a rovesciare la propria dinamica di forza-lavoro del capitale internazionale in una lotta ‘sociale’», e, dunque, sia ai «meccanismi materiali che già li unificano parzialmente a livello sociale in potenziale di lotta politica», sia alla «catena delle complesse mediazioni attraverso le quali si esprimono, a volte, sul terreno politico diretto»[70]. Per Alquati, come d’altronde per Tronti, la distinzione cruciale era tra «forza lavoro» e «classe operaia», ossia tra il lavoro come elemento passivo del processo produttivo e il soggetto politico, in grado di rifiutare il semplice ruolo di inerme fattore di produzione mediante la propria autonomia. A questa prima distinzione si affiancò però ben presto, soprattutto grazie ad alcune ipotesi formulate da Sergio Bologna sul finire degli anni Sessanta, anche la dicotomia di «composizione tecnica» e «composizione politica», una dicotomia in cui non erano assenti alcune ombre di determinismo, perché essa tendeva a suggerire l’idea che, a ogni determinata composizione tecnica della forza lavoro, dovesse corrispondere – più o meno inevitabilmente – una determinata composizione politica della classe operaia[71]. Se Negri continuò ad adottare quella distinzione (che ancora oggi compare nei suoi libri, pur senza la vecchia impronta materialistica), Bologna, a partire dagli anni Settanta e nel lavoro compiuto con la rivista «Primo maggio», incominciò a problematizzare il concetto di «composizione di classe», e la stessa distinzione tra composizione «tecnica» e «politica», con l’intento principale di ‘storicizzare’ e ‘relativizzare’ la centralità dell’operaio massa[72]. Per esempio, nelle Otto tesi per la storia militante, redatte da Bologna nel 1978 come documento di lavoro per avviare un dibattito fra «storici militanti», si chiariva che, per ricostruire l’assetto della composizione di classe, era necessario considerare «non soltanto la composizione tecnica, la struttura della forza-lavoro, ma anche la somma e l’intreccio delle forme di cultura e dei comportamenti sia dell’operaio massa che di tutti gli strati sussunti al capitale»[73]. In questa prospettiva, era chiaro che la composizione «politica» doveva essere concepita come una dimensione tutt’altro che ‘determinata’ dal semplice assetto ‘tecnico’ del processo lavorativo: la «composizione di classe» doveva cioè essere considerata come «la somma e l’intreccio delle forme di cultura e dei comportamenti» degli strati sussunti al capitale. In altre parole, dunque, la dimensione ‘politica’ – che poteva concretizzarsi, di volta in volta, in sedimentazioni ideologiche, in tradizioni conflittuali, nella memoria politica – poteva trasferirsi da un segmento all’altro della forza lavoro, senza che tali settori avessero in comune le medesime condizioni ‘tecniche’ di lavoro, e proprio per questo la stessa distinzione fra una composizione «tecnica» e una composizione «politica» doveva essere considerata con molta cautela, evitando cioè qualsiasi tentazione determinista.
Benché il percorso di Berardi abbia solo occasionalmente intersecato quello di Sergio Bologna, sono piuttosto evidenti alcune analogie nel loro approccio: analogie che non comprendevano solo una severa critica al leninismo (e al ‘neo-leninismo di Potere operaio, che indusse entrambi a lasciare l’organizzazione pochi mesi dopo la sua fondazione)[74], ma che si estendevano anche al modo di concepire la «composizione di classe». In modo sostanzialmente convergente con quanto sostenevano le Otto tesi, Berardi, come si è visto, aveva infatti definito la «composizione di classe» come una dimensione a cui andavano ricondotte non solo «le relazioni sociali fra settori proletari e operai, fra strati sociali proletarizzati», o «il rapporto fra lavoro vivo e lavoro morto, operai e struttura tecnologica», ma anche «il patrimonio organizzativo, culturale, di consapevolezza che nel corpo concreto della classe è inscritto». Questa concezione riconosceva l’autonomia (almeno relativa) dei «comportamenti» e dei «bisogni», ‘cristallizzati’ nella struttura soggettiva dei diversi settori, e in particolare implicava la possibilità (anche se certo non la necessità) che i «comportamenti» e i «bisogni» si comunicassero tra diversi settori di forza lavoro. In altri termini, ciò significava che Berardi, nella propria definizione della «composizione di classe» riconosceva ampi margini all’autonomia ‘culturale’ e ‘politica’ di bisogni e comportamenti, nel senso che forme ‘culturali’, sedimentazioni ideologico-politiche, tradizioni più o meno definite (e mitizzate) potevano andare a consolidarsi nella struttura soggettiva e ‘comunicarsi’ tra settori di forza lavoro contrassegnati da una differente composizione «tecnica». E, d’altro canto, quando propone oggi la nozione di «composizionismo», in alternativa a quella a suo avviso fuorviante di «operaismo», mette in evidenza proprio questi aspetti, perché, contro ogni determinismo, il metodo centrato sulla «composizione» consentirebbe di «intravedere gli elementi di una concezione del processo sociale inteso come divenire eterogeneo nel quale intervengono segmenti tecnologici, sedimentazioni culturali, intenzioni politiche e rappresentazioni ideologiche, concatenazioni macchiniche e comunicazionali, insomma tutto ciò che sfugge alle riduzioni della politica e della sociologia»[75].
Una simile impostazione doveva combinarsi con la critica della politica sviluppata da Berardi nella seconda metà degli anni Settanta, perché in quella fase la «critica della politica» implicava soprattutto un attacco alle forme di appartenenza identitarie – ascrivibili ai ‘gruppi’, ma ovviamente anche al Pci – che impedivano di riconoscere la portata radicale delle trasformazioni che maturavano nella «vita quotidiana». Ma in realtà quelle due differenti componenti mostravano almeno una potenziale divergenza, che riguardava proprio le forme dell’identità e dunque dell’appartenenza. Per un verso, Berardi riconosceva infatti che la composizione di classe comprendeva anche «il patrimonio organizzativo, culturale, di consapevolezza» consolidato nella classe, mentre, per l’altro, tendeva a considerare ogni forma di identificazione come una nuova replica del meccanismo di rimozione. Da un lato riconosceva cioè che «il patrimonio organizzativo, culturale, di consapevolezza che nel corpo concreto della classe è inscritto» si andavano a depositare nella struttura della «composizione di classe», e dunque ammetteva che una serie di elementi ‘politici’ e i processi di identificazione – per esempio con organizzazioni o con subculture – potessero andare a determinare il livello storico del «lavoro socialmente necessario»[76]. Dall’altro però – sulla scorta di Deleuze e Guattari, ma anche sull’onda della critica della «vita quotidiana» sviluppata dai movimenti giovanili e dai gruppi femministi – Berardi sosteneva che qualsiasi processo organizzativo e ogni processo di identificazione politica tendeva inevitabilmente a perpetuare la ‘rimozione’ dei bisogni. In sostanza, la politica, a qualsiasi livello, era sempre un terreno nel quale la soggettività storica, per sua natura irrappresentabile, veniva ‘rimossa’. «La storia della politica», scriveva per esempio in Finalmente il cielo è caduto sulla terra, «è storia di una rimozione e di una sostituzione», perché «sul terreno istituzionale della politica, l’unità diviene possibile a partire dalla rimozione dell’autonomia e dalla rimozione del soggetto stesso, come soggetto storico di bisogni, desideri, di comportamenti», e perché «l’organizzazione si installa nello spazio di questa rimozione del soggetto, come strutturazione di un soggetto ipostatico e volontaristico» (FC 57). E da questo punto di vista, ogni forma di azione ‘politica’ non poteva che ricadere in questo meccanismo, perché l’unità espressa dall’azione politica – nelle sue diverse espressioni, dalla manifestazione di piazza alle elezioni – «non si definisce sulla base del […] bisogno, ma anzi ne rimuove la materialità, toglie completamente di mezzo la esistenza di un soggetto in liberazione, in movimento e quindi in contraddizione» (FC 57).
La lacerazione che si annidava nel ragionamento di Berardi nasceva evidentemente dal fatto che nel suo schema teorico convivevano due diverse immagini dell’identificazione: da un lato, un’immagine che considerava la costruzione di un’identità collettiva come l’esito di un processo politico-culturale necessario non solo per l’articolazione di un conflitto, ma anche per il consolidamento dei bisogni; dall’altro, un’immagine che invece raffigurava la costruzione di un’identità collettiva come un processo dagli esiti invariabilmente negativi. Nella posizione odierna di Berardi, è evidente come riemerga proprio questa seconda visione dell’identità, e – come si è visto – non è certo difficile trovare numerose conferme del sospetto con cui l’intellettuale oggi continua a guardare all’«ossessione identitaria», alla ricerca di immaginarie identità nel passato, alla costruzione di mitologie irrealistiche, alla perpetuazione di memorie che rimandano a un passato reinventato, oltre che naturalmente ai meccanismi di ostilità nei confronti dell’altro (e cioè a quei meccanismi che la costruzione di qualsiasi identità fatalmente comporta). E si tratta evidentemente di una lacerazione che non può essere realmente sanata, ma forse solo occultata, dal concetto di «soggettivazione», perché la soggettivazione secondo Berardi – che ovviamente in questo segue Deleuze e Guattari – nel momento in cui si consolida in una vera e propria identità assume i contorni di un ‘assoggettamento’[77].
La contrapposizione fra queste due componenti non contrassegna solo la riflessione di Berardi, perché in qualche modo coinvolge l’intera riflessione radicale italiana, tanto da determinare una vera e propria divaricazione che porta alla luce divergenze passate inosservate (o quasi inosservate) per tutti gli anni Settanta. Per quanto concerne la vicenda dell’operaismo, l’evento in cui simbolicamente si consumò la più fragorosa rottura fra le anime che, più o meno pacificamente avevano convissuto per un decennio, fu il convegno su Memoria operaia e nuova composizione di classe organizzato a Mantova, nell’ottobre 1981, dalla rivista «Primo maggio» e dall’Istituto de Martino[78]. A un anno di distanza dalla fatale «marcia dei quarantamila», il convegno – che nelle intenzioni doveva dar forma a una «società di storici militanti» – si trasformò in una sorta di psicodramma collettivo, in cui, insieme ai motivi di attrito accumulati nel corso degli anni, vennero in superficie anche concezioni del processo storico diametralmente opposte. In particolare, Valerio Marchetti, intervenendo a margine della contrapposizione tra operaio di mestiere e operaio massa evocata da Giulio Sapelli, esponeva alcune tesi, scopertamente provocatorie, intorno al nesso tra composizione di classe e memoria. «C’è una specie di luogo comune intorno al quale ha gravitato la maggioranza di questo convegno», un luogo comune che, chiariva Marchetti, consisteva nel «rendere positiva la memoria», ossia nel «considerare la memoria come uno strumento che ha un’importanza centrale nella organizzazione dei cicli di lotta»[79]. Quando si stabiliva un nesso fra «memoria» e «composizione di classe» in realtà ci si poneva su un terreno puramente storico, osservava però Marchetti, nel quale la protagonista non era la «classe», ma una generazione di storici militanti, o meglio, un ceto politico sconfitto che coltivava la propria memoria. «La memoria di cui parla il ceto politico operaio», secondo Marchetti, non aveva però «niente a che fare con la memoria operaia», ma era solo «una scheggia del proprio disegno politico». Oltre a polemizzare con l’intera prospettiva di una storia militante – che, come tutti gli storici, non poteva fare altro che «pura e semplice necrofilia», «parlare di cadaveri, del già spento, di quello che è morto, di quello che non c’è più» – Marchetti metteva però in questione la stessa ipotesi secondo cui la «memoria», il consolidamento di un patrimonio di lotte e di una ‘cultura’ antagonista, erano sempre elementi di sviluppo del conflitto. La «memoria» – questo era il cuore della sua provocazione – poteva infatti anche essere una forma di auto-disciplinamento, destinata a ostacolare l’emergere di nuovi processi conflittuali:
«E se la memoria fosse una struttura disciplinare? Se la memoria fosse lo strumento attraverso il quale noi conserviamo? E se la memoria – ultima conclusione – fosse lo strumento attraverso il quale noi giudichiamo quello che viene fuori, la novità? La memoria dell’operaio di mestiere è una memoria che ha giudicato i comportamenti dell’operaio-massa. E li ha giudicati così duramente, in maniera così inflessibile, da non entrare – molto spesso – nelle lotte che ha condotto l’operaio massa, fino al punto di allontanarsi da questo tipo di lotta che è stata condotta in un determinato periodo storico. La memoria ha sancito la differenza. Per quale motivo? Perché l’operaio di mestiere voleva le lotte così come le aveva sempre viste. La memoria è quella cosa oscena che secondo me fa dire – di fronte a quello che accade, a quello che viene fuori, alla novità – “questo l’ho già visto!” “Questa cosa c’è già stata!”. E allora lavora sul piano dell’analogia storica: tutto si riproduce così come è sempre stato. E allora vengono fuori dei comportamenti che non sono più assimilabili a quelli conservati dalla memoria operaia e si dice: “Questi comportamenti sono fascisti!”. È qui la memoria che giudica. Sono comportamenti che non si capiscono»[80].
Nel suo intervento, Marchetti si collocava su una linea simile a quella che pochi mesi prima Negri aveva esposto in un suo articolo polemicamente dedicato a un Elogio dell’assenza di memoria, nel quale aveva sostenuto che la «composizione di classe del soggetto metropolitano non ha memoria perché non ha lavoro, perché non vuole lavoro comandato, lavoro dialettico», e perché «solo il lavoro può costituire per il proletariato un rapporto con la storia passata»[81]. E infatti, benché non cedesse all’ottimismo (un po’ forzato) di Negri, anche Marchetti metteva in primo piano il problema rappresentato dalla nuova forza lavoro che emergeva «da un territorio che non ha nessun rapporto con la memoria di classe», e neppure con «la memoria dello sfruttamento, dello sfruttamento secolare»[82]. Ma era proprio in questo quadro che Marchetti, toccando un punto che più tardi avrebbe ampiamente coltivato anche Berardi, si chiedeva se avesse ancora un senso parlare di «memoria» per generazioni destinate a interagire con le macchine in modi completamente diversi rispetto al passato:
«di fronte ai nuovi circuiti che attraversa la memoria, di fronte alla memoria stampata, che cosa succede? Di fronte a un cervello che non ha più come livello di apprendistato la scuola o la professionalità operaia all’interno delle scuole professionali o della fabbrica, ma che impara in un luogo totalmente altro, vale a dire nel tempo libero? […] Che cosa significa, all’interno della struttura del tempo libero, lavorare il proprio gioco o giocare il proprio lavoro di fronte a un computer il quale realizza tecnicamente la fusione di comando-esecuzione? I flipper, come voi saprete, sono strumenti antiquati: ci giocavano gli operai-massa, erano strumenti che lasciavano un margine di creatività, uno spingeva, quell’altro cercava di far rimbalzare la pallina, e i punti si accumulavano. Provate oggi ad andare di fronte a uno di questi strumenti di gioco che non danno più nessuna possibilità che intervenga la mano, la creatività e tutte queste balle che fanno gioco nell’immaginario del ceto politico degli operai. Probabilmente ci sono altri luoghi di riproduzione dentro i quali il cervello impara a pensare altre cose, impara a pensare in un altro modo. Questa è la memoria di una forza lavoro senza memoria. È una memoria stampata. Una memoria che non prevede più il ripensamento sull’esecuzione. Bene. Che rapporto esiste tra il tempo libero e le nuove tecnologie introdotte all’interno delle fabbriche? Perché finalmente si lavora e si gioca con gli stessi strumenti o si comincia a lavorare con gli stessi strumenti con cui si gioca?»[83]
Molte delle domande che si poneva allora Marchetti, all’alba della rivoluzione microelettronica, sono per molti versi le stesse che continuiamo a porci oggi, e sono anche le stesse che da più di trent’anni indirizzano la ricerca di Berardi sulla «mutazione». Forse ancora più che per le domande che poneva, l’intervento di Marchetti era però significativo perché, negando un valore unificante alla «memoria» storica delle lotte, faceva affiorare le lacerazioni che esistevano tra gli stessi ricercatori di formazione operaista. All’interno di «Primo maggio», accanto alla componente ‘operaista’, rappresentata innanzitutto da Sergio Bologna, era tutt’altro che marginale anche una componente che rimandava alla ricerca sulle «forme di espressione ‘spontanee’ del mondo popolare e proletario», a Gianni Bosio e Danilo Montaldi: una linea che era rappresentata innanzitutto da Cesare Bermani, ma che si era saldata con il progetto di ripensamento del concetto di «composizione di classe» portato avanti dalla rivista anche grazie ad allora giovani ricercatori come Marco Revelli. Proprio Revelli, che nelle proprie indagini sulla classe operaia torinese aveva portato alla luce non solo l’importanza delle memorie dei vecchi militanti ma anche il ruolo delle memorie contadine degli operai massa immigrati dal Sud, non poteva evitare di replicare nettamente alle provocazioni di Marchetti, anche perché dietro l’esaltazione della svolta tecnologica, intravedeva tutte le ambiguità della celebrazione di un «individuo senza identità»:
«io credo esista un rapporto strettissimo fra memoria e identità; credo anche che la memoria sia un elemento costitutivo dell’identità. Stiamo attenti, compagni, a teorizzare il valore positivo e liberatorio della mancanza di identità, perché il soggetto privo di identità è in primo luogo un soggetto disponibile a realizzarsi nella volontà di potenza. Mi fa paura questa esaltazione della mancanza totale della identità, perché lascia aperti spiragli su tempi storici che io non voglio rivedere. L’individuo senza identità è, a mio avviso, il prototipo dell’uomo fascista; è il prototipo dell’uomo degli anni ’20 che, appunto, attraverso la mediazione con la potenza, ha risolto la propria crisi di identità»[84].

La contrapposizione che a Mantova emerse tra la posizione di Marchetti e quella di Revelli era davvero molto simile a quella che percorreva la riflessione di Berardi in quello stesso periodo. Per un verso, anche Berardi, come Revelli, aveva riconosciuto il ruolo essenziale della memoria e delle sedimentazioni delle lotte passate per la definizione della «composizione di classe». Per l’altro, sviluppando per intero la propria critica della politica, era però giunto a una posizione simile a quella di Marchetti, non solo a proposito dell’assenza di memoria delle nuove generazioni, ma soprattutto a proposito del ruolo sostanzialmente negativo della memoria e dell’identità. Dal momento che l’identità» per Berardi, come si è visto, «è una mappa che pretende di guidare lungo il percorso, ma mente» – dato che è un «meccanismo in base al quale noi pretendiamo di ‘riconoscere’, di conoscere già, di possedere per appartenenza il sistema di valori, il sistema delle ritualità adatte per tenere il mondo sotto controllo», dato che l’identità non è altro che «una menzogna, un fattore di irrigidimento» – la memoria non può essere altro che un riflesso dell’identità, che ne replica il meccanismo. «La memoria non è un diritto, ma è parte dell’identità», scrive per esempio in Heroes, «e l’identità non si fonda sulla memoria», perché semmai «l’identità crea la memoria» (H 137). «La frase “La memoria è un diritto” non è solo una provocazione», dunque, «ma una dichiarazione di guerra, dato che memorie diverse confliggono tra loro»: una dichiarazione di «guerra senza fine» che – come per esempio nel caso della fondazione di Israele – «è contenuta come una necessità inevitabile nella manipolazione della memoria e del diritto» (H 137). Ed è proprio per effetto di questa contraddizione teorica irrisolta – tra il «composizionismo» e la «critica della politica» – che Berardi è costretto nel vicolo cieco di un pessimismo radicale. Un pessimismo che, come si è visto, trapela da ogni pagina di Heroes, ma che scaturisce, ben prima ancora che dalla realtà della trasformazione tecnologica e dalla pervasività della «mutazione», dalla stessa impossibilità teorica di concepire il conflitto.
Rimozioni
Benché le ipotesi di Berardi sul significato del suicidio, come sintomo più evidente di una «psicopatia di massa», possano apparire un’estremizzazione eccessiva, anche altri osservatori delle trasformazioni contemporanee hanno proposto un’interpretazione simile. Bernand Stiegler ha sostenuto per esempio che la «sincronizzazione di massa» della coscienza e della memoria avrebbe prodotto l’effetto di uno smarrimento dell’identità soggettiva e, dunque, proprio la distruzione del «narcisismo primordiale» potrebbe essere considerata come la causa anche della diffusione dei casi di suicidio/omicidio di massa[85]. Questa lettura viene tra l’altro ripresa da Jonathan Crary nel suo 24/7, la cui interpretazione generale non appare molto distante, o comunque incompatibile, con la descrizione degli effetti della penetrazione dell’«infosfera» proposta da Berardi[86]. Ma è stato probabilmente Jean-Paul Gilbert, in modo certo provocatorio, a sostenere che esiste un legame stretto tra l’«epidemia di suicidi» e la logica dell’«ipercapitalismo», «un modo di distruzione che», come scrive, «raggiunge una redditività assoluta, sfruttando quanti sono capaci di iperlavoro e distruggendo tutti quelli che non lo sono»[87].
Al di là delle suggestioni di queste letture, a ciascuna di esse – e anche a quella di Berardi – è naturalmente legittimo (e forse persino doveroso) muovere la critica di un eccesso di semplificazione e di una forzatura provocatoria che finisce col desumere il tratto di un’intera epoca da fenomeni che rimangono marginali. Accantonando simili osservazioni, è però evidente – anche a chi sia meglio disposto nei confronti delle ipotesi al cuore di Heroes – che nel discorso di Berardi si intrecciano due piani piuttosto differenti, che pur avendo più di qualche possibile intersezione reciproca, non è inopportuno tenere distinti. Da un lato, infatti, la lettura di Berardi si concentra sugli aspetti strettamente tecnologici che sarebbero all’origine dell’«epidemia» di suicidi: in questo caso, riemergono tutti i fili dell’analisi dedicata da più di un trentennio all’«infosfera», alla sua capacità di penetrazione e ai suoi effetti di «desolidarizzazione». In altre parole, seguendo questa prima pista, gli elementi determinanti della «psicopatia di massa» devono essere ricercati nella «frattalizzazione della percezione di sé», ma anche nello squilibrio tra «l’infinita velocità di espansione del ciberspazio» e la limitata capacità percettiva dell’organismo umano: uno squilibrio da cui – come Berardi sostiene da molti anni – scaturiscono tanto il panico quanto la depressione, che possono anche condurre a comportamenti aggressivi e distruttivi. E Berardi non ha grosse difficoltà a considerare come testimonianza estrema di questa tendenza alla «desolidarizzazione» i comportamenti degli autori di massacri di massa, o un fenomeno come quello degli Hikikomori giapponesi, che interrompono volontariamente qualsiasi contatto con altri esseri umani per vivere chiusi nella loro stanza. Accanto a questa prima linea interpretativa – che è per molti versi quella cui Berardi ha lavorato con più insistenza nel corso degli anni – si trova però un’altra argomentazione, che pone in primo piano, più che gli aspetti strettamente tecnologici, degli elementi ‘politici’. Quando evoca i casi dei suicidi degli operai cinesi che si gettano dal tetto delle fabbriche-dormitorio, quando ricorda la sequenza di suicidi di dipendenti di France Télécom, o quando ricostruisce la lunga catena di suicidi di contadini indiani indebitati con la Monsanto, è evidente che all’elemento ‘tecnologico’ non può essere affidato il ruolo principale. Il fattore a cui è pressoché inevitabile ricondurre questi suicidi è semmai una strategia ‘politica’ di gestione della forza lavoro, e cioè una strategia che implica l’esercizio di un potere finalizzato a perseguire gli obiettivi dell’azienda. E, in questo caso, la «desolidarizzazione» non è, almeno principalmente, l’effetto di una trasformazione tecnologica e della «mutazione antropologica» che la accompagna, bensì l’esito di una gestione del personale che punta a distruggere qualsiasi coesione tra i lavoratori, per esempio mediante l’introduzione di criteri meritocratici o rendendo ‘strutturalmente’ instabile la relazione lavorativa.
Ovviamente si potrebbe obiettare che queste due linee argomentative – l’una basata sulla dimensione ‘tecnologica’ della «mutazione», l’altra invece sulla dimensione ‘politica’ della «frammentazione» del lavoro – possono essere ricondotte a una logica comune, perché, per esempio, le potenzialità delle nuove tecnologie vengono utilizzate per «frammentare» e «frattalizzare» il lavoro, e cioè per dissolvere ogni traccia di solidarietà fra i colleghi. Benché siano evidenti nella realtà i margini di intersezione fra le due dinamiche, Berardi sembra però privilegiare dal punto di vista teorico la prima linea di argomentazione, e cioè quella linea – già al centro della sua riflessione fin dagli anni Ottanta – che si concentra sulle conseguenze ‘strutturali’ della «mutazione», sugli effetti pressoché inevitabili di ‘desocializzazione’ e ‘desensibilizzazione’. Naturalmente Berardi ha più di qualche ragione nel sospettare che questa «mutazione» abbia conseguenze dirompenti sotto molti profili, anche perché nessuna persona ragionevole può liquidare queste fosche previsioni solo in nome del vecchio anatema contro il catastrofismo apocalittico. Ciò nonostante, non si può evitare di riconoscere che questo modo di interpretare le trasformazioni ha implicazioni notevoli, che non consistono tanto nella tendenza a considerare il processo come un destino in fondo ineluttabile, quanto soprattutto nella sostanziale rimozione dal quadro analitico di qualsiasi elemento conflittuale (anche solo potenziale). Se infatti la «depressione di massa», insieme alle sue manifestazioni più drammatiche, viene intesa come il riflesso di un determinato ciclo storico-politico, o come l’esito di strategie di controllo della forza-lavoro, o anche come la testimonianza di uno Zeitgeist che, celebrando la «fine della Storia», sancisce l’esaurimento dell’immaginario progressista occidentale, le conseguenze sono diverse: non tanto perché si venga a escludere che il futuro possa davvero procedere nella direzione di una costante ‘desocializzazione’ e ‘densibilizzazione’ del mondo, ma perché l’assenza o la presenza di vincoli di «solidarietà» vengono ricondotte a fattori ‘politici’, alla contingenza di conflitti che, pur inquadrandosi all’interno di un determinato assetto tecnologico, non hanno un destino predeterminato. Se invece si attribuisce la «psicopatia di massa» alla formazione dell’«infosfera», alla proliferazione informativa e alla pervasività dei flussi comunicativi, alla «frattalizzazione» del sé, è evidente che l’unica possibilità di superare questa condizione deve essere collocata su un piano antropologico: deve cioè essere imputata a una modificazione delle modalità di interazione fra essere umano e ambiente inevitabilmente proiettata in un incerto futuro «postumano», e che sarebbe quantomeno ingenuo pensare possa essere determinata in tempi brevi da un’azione politico-culturale. Ed è proprio quest’ultima versione a emergere come prevalente nelle interpretazioni di Berardi, il cui pessimismo non può per questo non apparire sempre più cupo e totalizzante, tanto da rendere persino effimera qualsiasi ipotesi di invertire, o «ricombinare», la logica della trasformazione.
A uno sguardo superficiale, il pessimismo di Berardi potrebbe apparire come una sorta di reazione a quell’infatuazione per le nuove tecnologie di cui furono vittima molti teorici radicali soprattutto negli anni Novanta (e che induce ancora oggi molti esponenti del post-operaismo italiano a vedere nello sviluppo delle ‘macchine’ una sorta di «pre-requisito» per il superamento del capitalismo). Il pensiero di Berardi, in altre parole, potrebbe sembrare una reazione che, pur rovesciando la logica dell’ottimismo, conserverebbe l’idea di un processo in fondo irreversibile[88]. Liquidare in questo modo un percorso di riflessione portato avanti per decenni con passione e coerenza sarebbe però, oltre che ingeneroso nei confronti di Berardi, anche riduttivo, se non altro perché così si finirebbero per trascurare le motivazioni che conducono oggi a delineare un quadro tanto pessimista, nel quale ogni margine di conflittualità sembra assorbito dalla logica totalitaria del «semiocapitalismo». Le radici della posizione cui oggi giunge Berardi – come si è visto nelle pagine precedenti – sono infatti molte profonde, e non coincidono con quelle che, per esempio, alimentano da più di quarant’anni la ricerca di Negri e di altri esponenti dell’«Italian Theory»[89]. Le ipotesi che oggi formula Berardi sono anzi proprio l’esito estremo di un percorso che, al principio degli anni Settanta, prese avvio da una critica radicale delle posizioni allora adottate da Negri e da altri esponenti dell’operaismo. Ma forse è proprio negli approdi di quella critica che è possibile ravvisare i presupposti del cupo pessimismo cui perviene oggi. Perché, probabilmente, è nella negazione del ruolo della dimensione politica – o meglio, nell’espulsione dal quadro analitico della politica – compiuta da Berardi a partire dagli anni Settanta che si possono ravvisare le radici del pessimismo che emerge da Heroes e da tutti gli scritti più recenti di Berardi.
Nel discorso di Berardi c’è un tratto comune a quello che indirizza le diagnosi formulate negli ultimi anni da Tronti sulla «fine della politica». A dispetto delle enormi differenze che distinguono le due analisi, alla base di entrambe si può infatti riconoscere lo stesso presupposto, ossia l’idea – non sempre esplicitata chiaramente – secondo cui solo la «concentrazione» dei lavoratori in uno stesso luogo, solo la «prossimità», solo la condivisione di uno spazio fisico comune, consentirebbe meccanismi di ricomposizione. «La solidarietà sociale», scrive per esempio Berardi, «non è un valore morale o ideologico: essa dipende dalla continuità del rapporto tra individui nel tempo e nello spazio», ma «a partire dagli anni Ottanta si mise in moto un processo di vera e propria disaggregazione della composizione sociale operaia», all’interno del quale la precarizzazione realizzò «la distruzione della coerenza degli interessi nel campo del lavoro»[90]. Per Tronti, invece, «la concentrazione dei lavoratori nel luogo di lavoro determinava le masse, senza fare massa», e cioè determinava la nascita delle «masse lavoratrici, sindacalmente e politicamente organizzate», che «erano a loro volta il contrario dei processi di massificazione, indotti dalle produzioni, dai consumi, dalle comunicazioni, appunto di massa»[91]. Per entrambi, il riconoscimento della fine della «prossimità» e della «concentrazione» non può che condurre alla conclusione logica del venir meno delle basi materiali della solidarietà e dunque del conflitto. Ed è infatti proprio questo l’approdo cui pervengono entrambi, nonostante il fatto che Berardi oggi assegni a un elemento ‘tecnico’, come la «prossimità» spaziale, un ruolo cruciale nella genesi del conflitto sia evidentemente in contrasto con quanto aveva sostenuto negli anni Settanta, a proposito dell’autonomia di bisogni e comportamenti (e benché l’enfasi sulla dimensione ‘oggettiva’ del processo lavorativo sia in patente contraddizione con la definizione che più volte ha fornito del «composizionismo», una definizione tutt’altro che timida nel riconoscere il peso fondamentale delle componenti ‘soggettive’ e ‘politiche’, cristallizzate nei rapporti di forza e nella struttura soggettiva della forza lavoro)[92].
Un’alternativa a questa conclusione così pessimista potrebbe essere naturalmente rappresentata dal classico ottimismo post-operaista, che – come avviene in modo paradigmatico nella riflessione di Negri – assegna al capitale il compito di predisporre le condizioni per far nascere un nuovo soggetto conflittuale e dunque di plasmare la nuova «composizione tecnica» da cui dovrebbe scaturire il volto di una radicale «composizione politica». Ma Berardi – come si è ben capito – è invece molto lontano dall’assecondare questo atteggiamento, nel quale peraltro continuano a sopravvivere tutti i miti del progressismo novecentesco (oltre a qualche traccia della vecchia teoria del «crollo»). Al tempo stesso, proprio per l’‘onda lunga’ della vecchia critica della politica sviluppata negli anni Settanta, Berardi non può rinvenire neppure labili tracce di resistenza nelle sedimentazioni politiche e culturali, come invece fanno per esempio Carlo Formenti e (seppur in termini problematici) lo stesso Tronti[93]. Come si è visto nelle pagine precedenti, agli occhi di Berardi qualsiasi ipotesi che torni a cercare al livello del ‘politico’ – un livello che comprende non solo la dimensione istituzionale, ma anche la dimensione delle identità collettive, delle costruzioni culturali, delle forme in cui viene pensato il «comune» – non può che essere segnato da uno stigma originario e incancellabile. Ed è in fondo proprio per questo che tutta la sua riflessione sul disagio dell’«ipermodernità» deve risolversi in un circolo vizioso che chiude ogni porta all’ingresso di tensioni conflittuali. Dal momento che qualsiasi forma di identità collettiva è destinata a ‘rimuovere’ i bisogni reali, a negare la realtà dei comportamenti, a riprodurre i meccanismi spettacolari della politica, allora la solidarietà non è neppure pensabile, perché non esiste nessuna base – che non sia la base ‘tecnica’ offerta dalla stessa cooperazione lavorativa allestita dal capitale – in grado di sorreggerla. Detto in altri termini, la costituzione di un ‘soggetto collettivo’ e la costruzione di un’identità comune – a prescindere dal tipo di identità che si punti a costruire – non può che proiettare il conflitto, dal piano della vita quotidiana, verso una sfera estranea, verso un conflitto simulato, verso una contesa i cui protagonisti non sono altro che finzioni che nulla hanno a che vedere con i bisogni individuali. Per quanto questo discorso abbia senz’altro un fondamento concreto – se non altro perché mostra ancora una volta come la politica moderna sia un regno popolato di ‘finzioni’ – l’approdo non può che essere un pessimismo implacabile, perché, dinanzi alla penetrazione del «semiocapitalismo», non ci può essere altro che ‘desolidarizzazione’. E dal momento che per Berardi la politica è sempre e inevitabilmente il regno della ‘rimozione’, la conseguenza paradossale cui approda la sua ricerca finisce per essere la ‘rimozione’ del conflitto, e cioè l’impossibilità stessa di pensare il conflitto.
Un altro cielo
A dispetto della morsa teorica che stringe Berardi in un pessimismo così cupo, sarebbe ingenuo pensare di liquidare le sue argomentazioni come gli inconvenienti di una contraddizione logica. Per quanto risulti segnato da toni tanto foschi, il quadro che l’intellettuale dipinge è infatti in gran parte realistico, e in particolare le previsioni che formula sul nostro prossimo futuro – e sul futuro dell’Unione Europea – andrebbero prese in considerazione molto più seriamente di quanto si tenda a fare. Il punto è però che il ‘ragionevole pessimismo’ di Berardi tende a diventare un incubo senza via d’uscita, descrivendo una traiettoria in fondo non molto diversa da quella che indusse i filosofi di Francoforte a leggere nella catastrofe tedesca degli anni Trenta il destino ineluttabile della modernità. A dispetto della sua originalità e delle intuizioni preziose che consegna alla fenomenologia del presente, il percorso teorico di Franco Berardi e il pessimismo dei suoi approdi sono comunque interessanti anche perché consentono di ricostruire i meccanismi teorici che condussero buona parte della teoria radicale italiana a rimuovere la politica (nella sua multidimensionalità) dal proprio spettro di indagine. Dopo gli anni Settanta, una buona parte degli esponenti della teoria radicale italiana, e in particolare gli eredi dell’operaismo, non rinunciarono interamente alle vecchie ipotesi, ma – per motivi certo del tutto comprensibili – le declinarono in una direzione che finiva davvero per espellere la politica e tutte le sue dimensioni problematiche. Abbandonando fra i cascami della storia – insieme al leninismo esasperato, al volontarismo estetizzante, al «prometeismo» incondizionato cui molti avevano ceduto nel decennio fatale del «maggio strisciante» – anche tutti gli strumenti della politica ‘novecentesca’, quei vecchi protagonisti concentrarono invece i loro sforzi nella costruzione di dispositivi teorici in cui il mutamento veniva affidato alla logica stessa dello sviluppo, o meglio, a una sorta di rivisitazione all’apparenza ‘soggettivista’ della vecchia Zusammenbruchtheorie, da cui naturalmente – a dispetto dell’enfasi sull’«ontologia» del soggetto – si smarriva proprio l’elemento conflittuale che aveva contrassegnato la «differenza italiana». Naturalmente, così come fu ben lontano dal cedere al fascino del leninismo, Berardi ha imboccato una strada ben diversa da quella seguita da molti esponenti del «post-operaismo» e dai più ottimisti teorici del «comune». Ma, pur seguendo una direzione opposta, con un’operazione per molti versi speculare, ha proceduto a espellere dal proprio campo teorico la politica, considerata semplicemente come un relitto del passato, come uno strumento inadeguato per fronteggiare la «mutazione», oltre che, soprattutto, come uno strumento inevitabilmente contaminato dal veleno della ‘rimozione’ della «vita quotidiana». E proprio per questo la tenaglia della sua teoria non può che chiudere in un pessimismo totalizzante ogni possibilità di conflitto, neutralizzando anche le intuizioni del «composizionismo».
Riconoscere i limiti del «pessimismo della ragione» cui indulge Berardi non può certo indurre a ritenere più meritevole, o preferibile, un incondizionato «ottimismo della volontà». Ma forse può contribuire a confermare la necessità di tenere teoricamente aperti gli spazi – per quanto marginali essi siano – con cui pensare le tensioni conflittuali: tensioni che non scaturiscono dall’inflessibile logica provvidenziale dello sviluppo, ma che maturano anche sul terreno scivoloso nel quale si muovono e si aggregano le identità collettive, i soggetti, le ‘finzioni’ politiche. Così, se si vuole evitare che tutti i nostri più fondati e meditati motivi di pessimismo vengano a stringere il credibile scenario del ‘disagio dell’ipermodernità’ nell’abbraccio mortale del disagio della nostra teoria, diventa infatti necessario riconoscere che, per superare davvero il Novecento e i suoi traumi, non è probabilmente sufficiente ‘rimuovere’ la politica o cancellarla dal proprio quadro visuale, ma è necessario ripensarla, senza dimenticare naturalmente le sue insidie. Perché la politica è anche la dimensione in cui si costruiscono ‘simbolicamente’ i soggetti politici, e in cui si ridefiniscono – nel conflitto quotidiano – le identità collettive. E perché l’«autonomia del politico», più ancora che l’autonomia dello Stato dalle logiche dell’accumulazione, identifica l’autonomia relativa dei processi di costruzione ‘culturale’ delle identità collettive, l’autonomia dei processi che ‘plasmano’ politicamente «società» e che danno forma alle sue «parti». Ciò non vuol dire naturalmente che la critica della politica non debba restare nel nostro armamentario anche nel mondo «post-politico» che ci circonda, che non si debba diffidare delle ‘finzioni’ che affollano il «cielo» della politica moderna, o che si debba scambiare ancora una volta una specifica ‘finzione’ per l’artefice della storia universale. Ma significa piuttosto che – per superare davvero il Novecento – diventa oggi indispensabile tornare a confrontarsi con le ambigue suggestioni della politica, con tutte le sue ingombranti ‘finzioni’ e con le insidie dei suoi miti. E significa soprattutto che – se non terminerà l’«eclissi» che proietta un’ombra tanto sinistra sul nostro futuro – davvero diventerà indispensabile «inventarsi un altro cielo»[94].
Note
[1] S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), in S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, p. 280.
[2] Ibi, p. 246.
[3] Cfr. S. Freud, Psicologia di massa e analisi dell’Io (1921), Einaudi, Torino, 2013, in cui è da vedere anche l’introduzione di D. Tarizzo, Quando un popolo muore, ibi, pp. VII-LI.
[4] Cfr. W. Reich, Psicologia di massa del fascismo (1933), Mondadori, Milano, 1974, E. Fromm, Fuga dalla libertà (1941), Mondadori, Milano, 1994, H. Marcuse, Eros e civiltà (1958), Einaudi, Torino, 1967, F. Fornari, Psicanalisi della guerra atomica, Comunità, Milano, 1964, e Id., Psicoanalisi della guerra (1966), Feltrinelli, Milano, 1988.
[5] M. Recalcati, Quei ragazzi terroristi in fuga dalla libertà, in «la Repubblica», 7 febbraio 2015, p. 19.
[6] In questo articolo alcune opere di Franco Berardi «Bifo» verranno indicate con le seguenti abbreviazioni, accompagnate dal numero di pagina a cui rimanda il riferimento: DF = Dopo il futuro. Dal futurismo al Cyberpunk. L’esaurimento della Modernità, DeriveApprodi, Roma, 2013; E = Exit. Il nostro contributo all’estinzione della civiltà, Costa & Nolan, Milano, 1997; FC = Finalmente il cielo è caduto sulla terra. Proletariato giovanile e movimento di liberazione, Squilibri, Milano, 1978; FI = La fabbrica dell’infelicità. New economy e movimento del cognitariato, DeriveApprodi, Roma, 2001; H = Heroes. Suicidio e omicidi di massa, Baldini & Castoldi, Milano, 2015; I = Dell’innocenza. 1977: l’anno della premonizione, Ombre corte, Verona, 1997, p. 54 (I ed. Agalev, Bologna, 1987); MC = Mutazione e cyberpunk. Immaginario e tecnologia negli scenari di fine millennio, Costa & Nolan, Genova, 1994; N = Neuromagma. Lavoro cognitivo e infoproduzione, Castelvecchi, Roma, 1995; SM = Scrittura e movimento, Marsilio, Padova, 1974; NS = La nonna di Schäuble. Come il colonialismo finanziario ha distrutto il progetto europeo, Ombre corte, Verona, 2015; TV = Teoria del valore e rimozione del soggetto. Critica dei fondamenti teorici del riformismo, Bertani, Verona, 1977.
[7] Traggo la formula «ipermodernità» proprio da Berardi, che qualche anno fa definì in questo modo la fase storica in cui ci troviamo, in implicita polemica con l’idea di «postmodernità»: «’Iper’ è l’effetto di costante ridefinizione che noi compiamo rispetto al passato. […] Il prefisso ‘iper’ rende questo effetto di risemiotizzazione, che si verifica quando alla cognizione sociale data si sovrappone una macchina enunciativa più complessa. Nel corso di questa sovrapposizione il mondo esistente non scompare, non viene cancellato e neppure superato. Piuttosto viene risemiotizzato, cioè viene visto secondo una prospettiva che ne muta il significato e il funzionamento. Perciò è legittimo definire il passaggio di fine millennio come il passaggio dell’ipermodernità. Ipermoderno è il mondo in cui le realtà culturali esistenti, l’eredità concreta della storia moderna e della tradizione arcaica, vengono risemiotizzate da un principio di tipo astratto e digitale che tende all’uniformità su scala planetaria. Il principio uniformante della digitalizzazione non cancella le differenze bensì le integra, modificandone l’interpretazione e la percezione da parte dei soggetti stessi che in quelle culture vivono» (N 167).
[8] Cfr. F. Berardi, And. Phenomenology of the end. Cognition and sensibility in the transition from conjunctive to connective mode of social communication, Aalto Arts Books, Helsinki, 2014.
[9] Cfr. per esempio F. Chicchi – G. Roggero, Introduzione. Le ambivalenze del lavoro nell’orizzonte del capitalismo cognitivo, in «Sociologia del Lavoro», n. 115, 2009, pp. 7-27, A. Fumagalli, Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci, Roma, 2007, A. Fumagalli – S. Lucarelli, A Model of Cognitive Capitalism: a Preliminary Analysis, in «European Journal of Economic and Social Systems», n. 1, vol. 20, pp. 117-133, A. Fumagalli – S. Mezzadra (a cura di), Crisi dell’economia globale. Mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Ombre corte – UniNomade, Verona, 2011, Y. Moulier-Boutang (a cura di), L’età del capitalismo cognitivo. Innovazione, proprietà e cooperazione delle moltitudini, Ombre Corte, Verona, 2002, e C. Vercellone, (a cura di), Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca postfordista, Manifestolibri, Roma, 2006.
[10] «Perché le lotte possano creare un ciclo» scrive Berardi, «ci deve essere una prossimità spaziale dei corpi del lavoro, una continuità esistenziale nel tempo. Senza questa continuità e questa prossimità le condizioni perché i corpi cellularizzati possano divenire comunità non si danno. Il comportamento può diventare onda solo quando c’è una prossimità continua nel tempo di cui il semio-lavoro non dispone più» (H 150-151).
[11] A questo era dedicato uno degli ultimi scritti di Pino Ferraris, Francia: i suicidi sul posto di lavoro di dipendenti altamente qualificati (2010), in «Progetto Lavoro», n. 16, 2012, pp. 58-63.
[12] Un documento importante è offerto, per questi casi, da P. Ngai – J. Chan – M. Selden, Morire per un iPhone. La Apple, la Foxconn e la lotta degli operai cinesi, a cura di F. Gambino e D. Sacchetto, Jaca Book, 2015.
[13] Come sintetizza Berardi questo passaggio, tutt’altro che secondario: «La precarizzazione è stata resa possibile dalla diffusione delle tecnologie informatiche e dalla creazione della rete digitale. Quando la produzione di beni si trasforma in informazione e la rete diviene la sfera di ricombinazione delle azioni produttive che si verificano in luoghi distanti dello spazio e in momenti distanti del tempo, il capitalista non ha più bisogno di comprare tutto il tempo di vita dell’operaio, gli bastano solo dei frammenti. La rete è la macchina che incessantemente cattura e ricombina frammenti di info-tempo dall’oceano della vita e dell’intelligenza sociale. Perciò la precarietà invade ogni spazio della vita sociale, e permea le aspettative e le emozioni degli individui il cui tempo è frammentato, frattalizzato, cellularizzato» (H 215).
[14] E dunque scrive, proprio alla conclusione di Heroes: «Non prendere parte al gioco, non attendere alcuna soluzione dalla politica, non attaccarti alle cose, non sperare. L’ironia distopica è il linguaggio dell’autonomia. Sii scettico, non credere alle tue certezze e alle tue previsioni (e neppure alle mie). E non smettere di ribellarti. Ribellarti contro il potere è necessario anche se non sai come vincere. Non appartenere. Distingui il tuo destino dal destino dell’umanità. Se vogliono fare la guerra, sii un disertore. Se sono schiavi e vogliono che tu soffra come loro, non accettare il ricatto» (H 237).
[15] U. Eco, Anno Nove (1977), in Id., Sette anni di desiderio, Bompiani, Milano, 1983, p. 61.
[16] Cfr. per esempio F. Berardi, Prassi e scrittura, in R. Alonge – F. Berardi – P. Bertetto – R. Tessari, Cultura lavoro intellettuale e lotta di classe, Guida, Napoli, 1973, pp. 135-182.
[17] A/traverso, Alice è il diavolo, L’Erbavoglio, Milano, 1976. Interessanti per ricostruire le coordinate teoriche dell’operazione, è anche F. Berardi, La barca dell’amore s’è spezzata, SugarCo, Milano, 1978, e Id., Chi ha ucciso Majakovskij?, Squilibri, Milano, 1977, oltre che il saggio di K. Gruber, L’Avaguardia inaudita, Costa & Nolan, Milano, 1997, mentre, per una sorta di viaggio dentro le sperimentazioni del «mediattivismo», cfr. F. Berardi, Skizomedia (tre decenni di mediattivismo), DeriveApprodi, Roma, 2006.
[18] Grande disordine sotto il cielo, in «A/traverso», ottobre 1975 (I 54).
[19] Ibi (I 54-55).
[20] La traversata del deserto, in «A/traverso», giugno 1981 (E 79).
[21] Berardi ha dedicato alcune considerazioni alla riflessione di Pasolini sulla «mutazione», per esempio, in DF 66-69, oltre che in alcuni articoli apparsi in occasione del quarantennale della morte del poeta: F. Berardi, Lo sguardo lungo di Pasolini, 4 novembre 2015, in «zeroviolenza.it».
[22] Tribù videoelettroniche, in «A/traverso», giugno 1981, poi ripubblicato in E 82-83.
[23] F. Berardi, Traiettorie, in F. Berardi – F. Bolelli, Presagi. L’Arte e l’Immaginazione visionaria negli anni ottanta, Agalev, Bologna, 1988, p. 41.
[24] Ibi, p. 83.
[25] F. Berardi – E. Crosio, Game Over. Poema videolettronico, in «A/traverso» ottobre 1981, poi ripubblicato in E 82-83.
[26] F. Berardi, L’altra faccia del tempo presente, in F. Berardi – F. Bolelli, Presagi, cit., p. 11.
[27] «Un segmento del lavoro sociale è opposto all’altro, mentre il progetto del ‘77 consisteva essenzialmente proprio nella ricomposizione dell’invenzione e della estinzione del lavoro. Il prodotto di questa divergenza tra i due segmenti del lavoro sociale si è oggi consolidato sotto i nostri occhi» (I 53).
[28] F. Berardi, Il paradosso della libertà, in Id., Uno sguardo dall’esterno. Perdere. Il paradosso della libertà, Agalev, Bologna, 1990, p. 156.
[29] Ibidem.
[30] Ibi, p. 159.
[31] Ibi, pp. 159-160.
[32] Ibi, pp. 162-163.
[33] Significativi, anche perché iniziavano a riconoscere l’importanza della produzione «immateriale», erano alcuni brevi contributi centrati sulla trasformazione di New York, scritti al principio degli anni Ottanta: cfr. F. Berardi, New York terminal, in «Metropoli», 1980, n. 2, pp. 26-28, e R. De Maria – F. Berardi, New York: città della produzione immateriale, in «Metropoli», 1981, n. 6, pp. 59-62.
[34] F. Berardi, Lavoro Zero, cit., p. 83.
[35] «Il denaro (cioè l’economia) e lo Stato (cioè la politica) non possono più governare né disciplinare il mondo produttivo, quando al centro del mondo produttivo troviamo non più la forza decerebrata, il tempo di lavoro manuale uguale, quantificabile, ma il fluido psichico, l’eterea sostanza dell’intelligenza, che sfugge ad ogni misura, che non si può piegare ad alcuna regola senza produrre enormi patologie, senza produrre un vero e proprio impazzimento, una vera e propria paralisi nella cognizione e nell’affettività» (ibi, p. 99).
[36] Cfr. per esempio F. Bolelli, Le nuove droghe. Dalla sintesi vegetale all’estasi sintetica, Castelvecchi, Roma, 1995, e Id., (a cura di), Starship. Viaggio nella cultura psichedelica, Castelvecchi, Roma, 1995, e Id., Vota te stesso, Id., Castelvecchi, Roma, 1996.
[37] Un esempio era, per esempio, «Passaggi e Mutazioni di Fine Millennio» (a cura di), Come si diventa uno zippy. Neo-hippy e tecnologie d’avanguardia, Castelvecchi, Roma, 1995, ma, in questa esplorazione degli immaginari tecnologici, si inserivano anche i volumi, curati dallo stesso Berardi, Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia. Elementi di psiconautica, Castelvecchi, Roma, 1994, Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia. Ciberfilosofia, Castelvecchi, Roma, 1995, e Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia. Internet e il futuro della comunicazione, Castelvecchi, Roma, 1995.
[38] Sotto questo profilo, mostrando l’indubbia capacità di cogliere il senso delle tendenze, Berardi riconosceva la pervasività consentita dalla telefonia mobile: «L’infolavoratore si muove […] continuamente lungo le linee di lunghezza, larghezza e profondità della sfera ciberspaziale; si muove per reperire segni, elaborare esperienza, o semplicemente seguire i percorsi della sua esistenza. Ma in ogni momento e luogo egli è raggiungibile, e può essere richiamato a svolgere la sua funzione produttiva, e reinserito nel ciclo globale dell’infoproduzione. In un certo senso, il cellulare è la realizzazione del sogno del capitale che consiste nel succhiare ogni possibile atomo di tempo produttivo nell’esatto momento in cui il ciclo produttivo ne ha bisogno, in modo da disporre dell’intera giornata del lavoratore pagando solo i momenti in cui viene cellularizzato. L’infoproduttore (o neurolavoratore) predispone il suo sistema nervoso come apparato ricevente attivo quanto più tempo è possibile. L’intera giornata vissuta diviene sensibile all’attivazione semiotica, che si fa direttamente produttiva solo quando questo è necessario» (FI 70).
[39] «Perciò», scriveva ancora, «il cognitariato va considerato come l’agente del processo di ricombinazione capace di funzionare trasversalmente all’intero campo del sociale. Cognitariato è l’area di coloro che elaborano, creano, fanno circolare le interfacce tecnolinguistiche, tecnofinanziarie, tecnosociali, tecno-mediche ecc. che innervano sempre più profondamente la società contemporanea. […] Solo coloro che svolgono il lavoro di costruzione degli automatismi possono decostruirli e riorientarli» (FI 200-201).
[40] Cfr., per il concetto di «ricombinazione», anche il volume F. Berardi – A. Sarti, Run. Forma, Vita, Ricombinazione, Mimesis, Milano, 2008.
[41] F. Berardi, Due civiltà ripugnanti si fanno la guerra, in AA.VV., La guerra d’Occidente. Scenari d’Occidente dopo le Twin Towers, DeriveApprodi, Roma, 2002, pp. 71-72.
[42] Ibi, p. 73. Cfr. anche F. Berardi, Un’estate all’inferno, Sossella, Roma, 2002.
[43] Sulla storia dell’operaismo, cfr. almeno G. Trotta – F. Milana (a cura di), L’operaismo degli anni Sessanta da «Quaderni rossi» a «classe operaia», Derive Approdi, Roma, 2008, e il testo di S. Wright, L’assalto al cielo. Per una storia dell’operaismo (2002), Alegre, Roma, 2008.
[44] Cfr. F. Berardi, Contro il lavoro, Libreria Feltrinelli, Milano, 1970.
[45] Più di vent’anni dopo, Berardi ripropose questa prospettiva nel volumetto Lavoro Zero, Castelvecchi, Roma, 1994.
[46] Per una ricostruzione autobiografica di Berardi, cfr. le interviste riportate in G. Borio – F. Pozzi – G. Roggero (a cura di), Gli operaisti, DeriveApprodi, Roma, 2005, pp. 75-88, e A. Grandi, Insurrezione armata, Rizzoli, Milano, 2005, pp. 53-63.
[47] Nel convegno fiorentino di Potere operaio, tenutosi nel gennaio 1970, il gruppo secondo Berardi imboccò la strada verso la trasformazione in una sorta di partito neo-bolscevico. Come scrive, a proposito di quella discussione: «Potere operaio perde di vista la specifica novità metodologica e filosofica della sua esperienza politica, per rientrare, armi e bagagli, nella tradizione volontaristica del marxismo-leninismo scolastico, del dogmatismo terzinternazionalista. In quel momento Potere operaio perde il senso della sua specificità teorica, che è racchiusa nell’intuizione che la strategia sta tutta nella composizione sociale, nel divenire intellettuale, culturale, psichico, relazionale, comunicativo, desiderante della socialità operaia. […] Riproporre il leninismo significa proprio ritornare alla religione volontaristica che ha prodotto il socialismo reale, lo stalinismo, la violenza autoritaria dei partiti comunisti della Terza Internazionale e così via» (F. Berardi, La nefasta utopia di Potere operaio. Lavoro tecnica movimento nel laboratorio politico del Sessantotto italiano, Castelvecchi, Roma, 1998, p. 117).
[48] Forse la più completa discussione critica della riflessione operaista di Tronti è svolta in F. Berardi, The soul at work. From alienation to autonomy, Semitext(e), Los Angeles, 2007. Berardi ha dedicato anche al pensiero di Deleuze e soprattutto di Guattari vari scritti, tra cui, in particolare F. Berardi, Felix, Sossella, Roma, 2001. Forse vale però la pensa di ricordare anche F. Guattari, Desiderio e rivoluzione, a cura di Paolo Bertetto, Squilibri, Milano, 1978, nel quale la voce Bifo compariva spesso come contrappunto polemico a quella del filosofo francese, soprattutto a proposito della concezione della «classe operaia». Berardi per esempio osservava: «Sono convinto che il soggetto del processo rivoluzionario sia e continui ad essere la classe operaia», anche se precisava che con questo termine si dovevano intendere «tutti gli strati sociali, tutte le forme di esistenza, di espressione politica e microstrasformazionale che sono legate al rifiuto del lavoro» (ibi, p. 28). Al contrario, Guattari replicava: «La tua definizione della classe operaia non corrisponde alla realtà: è una definizione ammirevole, ma la classe operaia non è questo. La classe operaia rischia di continuare ad essere il soggetto della storia» (ibi, p. 29).
[49] Cfr. per esempio A. Negri, Partito operaio contro il lavoro, in S. Bologna – P. Carpignano – A. Negri, Crisi e organizzazione operaia, Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 99-193.
[50] Gruppo Gramsci, Una proposta per un diverso modo di fare politica, in «Rosso», n. 7, dicembre 1973, in L. Castellano (a cura di), Aut.Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia organizzata, Savelli, Roma, 1980. p. 96.
[51] Cfr. P.A. Rovatti – R. Tomassini – A. Vigorelli, Bisogni e teoria marxista, cit., A. Negri – P.A. Rovatti – A. Vigorelli, La discussione su «i bisogni e il politico», in «Aut aut», 1976, n. 155-156, AA.VV., Bisogni, crisi della militanza, organizzazione proletaria, in «Quaderni di Ombre rosse», n. 1, Savelli, Roma, 1977. Per la riflessione sui «bisogni» di Heller, cfr. soprattutto A. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano, 1974, Id., La teoria, la prassi e i bisogni, a cura di L. Manconi e A. Vigorelli, Savelli, Roma, 1978, e Id., Morale e rivoluzione, a cura di L. Boella e A. Vigorelli, Savelli, Roma, 1979.
[52] Cfr. M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, Milano, 1977. Una ricostruzione del dibattito è offerta da A. De Martinis e A. Piazzi, Alle origini dell’autonomia del politico, in M. Tronti, Soggetti, crisi, potere. Antologia di scritti e interventi, a cura di Antonio De Martinis e Alessandro Piazzi, Cappelli, Bologna, 1980, pp. I-XXVIII. Tra le critiche a Tronti, particolarmente importante (per la notevole consonanza con la posizione di Berardi) era quella di F. Stame, Società civile e critica delle istituzioni, Feltrinelli, Milano, 1977, e Id., Movimento e istituzioni nella crisi, Savelli, Roma, 1978.
[53] «Nella concezione trontiana dell’autonomia del politico», scriveva per esempio nel 1977, «scompare la determinatezza storica, la materialità di classe delle istituzioni in quanto è occultata l’irriducibilità del soggetto-classe alle leggi dell’economia capitalistica» (TV 17).
[54] Lo stesso passo è riprodotto, con lievi variazioni, in FC 53.
[55] F. Berardi, Contro il lavoro, cit., p. 24.
[56] F. Berardi, La nefasta utopia di Potere operaio, cit., p. 148. Per un’altra definizione di «composizionismo», cfr. anche F. Berardi, The soul at work, cit., pp. 33-34.
[57] Al proposito rimando a D. Palano, L’ultimo lampo del Novecento. Appunti di lettura intorno a «Dello spirito libero» di Mario Tronti, in «Tysm», vol. 28, 2 ottobre 2015 [http://tysm.org/mario-tronti].
[58] M. Tronti, Classe e partito (1964), in Id., Operai e capitale, cit., p. 113.
[59] M. Tronti, Marx, forza-lavoro, classe operaia, in Id., Operai e capitale, cit., p. 257.
[60] L’intervento pronunciato da Berardi a nome della sezione fiorentina di Potere operaio al convegno del gennaio 1970 – pubblicato (anonimo) col titolo Teoria, tattica, strategia, in «Potere operaio», Atti del convegno di Firenze, Roma, 1970, e ripreso in F. Berardi, La nefasta utopia di Potere operaio, cit., p. 16 – merita di essere riletto, per cogliere la continuità reale tra le ipotesi degli anni Sessanta e il discorso sul «composizionismo»: «Che la strategia è tutta nella classe, questo è l’assunto da cui la ricerca è partita ed è ripartita e deve ora ritornare per poter ulteriormente andare avanti. Strategia sono i grandi movimenti che dentro la masse avvengono, il trasformarsi del proletariato in classe operaia, l’emergere oggettivo di centri direzione politica di coagulo della lotta dentro il tessuto generale della classe. La strategia è il modo in cui il lavoro vivo si compone e organizza la classe operaia, rifiuta se stesso come forza-lavoro, costringe il capitale a subire il dispotismo della sua organizzazione. Strategia è questo processo che si svolge e si realizza».
[61] F. Berardi, Uno sguardo dall’esterno, in Id., Il paradosso della libertà, cit., p. 79. Più precisamente, osservava: «Alla politica deve sostituirsi una paradigmatica, in quanto il campo delle scelte si trasferisce dall’ambito della decisione politica all’ambito dei paradigmi fondamentali che mettono in forma l’intero sistema della percezione e della proiezione, ma quindi anche l’intero sistema delle abitudini di vita, degli stili, delle attese e dei bisogni, e di conseguenza anche di produzione e di consumo» (ibi, p. 78).
[62] F. Berardi, La sollevazione. Collasso europeo e prospettive del movimento, Manni, Lecce, 2011, p. 60.
[63] Il nodo dei movimento è toccato anche in F. Berardi, Sciame/interruzione, in A. Simoncini (a cura di), Una rivoluzione dall’alto. A partire dalla crisi globale, Mimesis, Milano, 2012, pp. 125-162.
[64] «Alla fine dell’estate», scrive, «quella speranza è sfumata per lasciare il posto a un’agonia rancorosa. È chiaro a tutti che il progetto europeo è irrimediabilmente fallito, anche se non si può dire. Gravemente indebolito dalla crisi finanziaria del 2008, politicamente fragile e scarsamente democratico (per usare un eufemismo), è stato colpito al cuore dall’arroganza del governo tedesco e dall’ottusità della grande maggioranza (occorre dirlo) del popolo tedesco» (NS 13) Ma aggiunge anche, contro ogni speranza di rivalsa: «Da trent’anni ormai, ogni battaglia, ogni scontro, ogni confronto con la realtà si risolvono in un arretrare della società, per ricomporre le fila qualche metro più indietro, pensando che al prossimo assalto resisteremo, e che forse inizieremo la riscossa. È ora di piantarla: non ci sarà resistenza, non ci sarà riscossa. Non ci sarà sinistra, perché nel Novecento la sinistra ha compiuto le scelte che hanno portato i lavoratori alla sconfitta e alla subalternità» (NS 14-15).
[65] Per la verità, non si può dire che Berardi non avesse compreso, almeno in parte, la logica di Maastricht, perché per esempio aveva scritto: «Il Trattato di Maastricht appesta le società europee, nella produzione nella cultura nella psiche e nella vita quotidiana. Non si potrebbe immaginare un percorso più assurdo per costruire un’entità politica viva di quello scelto da coloro che hanno avviato l’unificazione europea sulla base di un vincolo finanziario che costringe entro i suoi parametri ogni formula di vita sociale». Cfr. F. Berardi, Politiche nEUROPAtogene, (1996), in NS 41.
[66] Con estrema franchezza, scrive: «Finì che noi allocchi, guidati dai super-allocchi Dani Cohn-Bendit e Toni Negri, ci ritrovammo a sostenere il sì insieme al programma dei truffatori neoliberisti, mentre i fascisti del Front National interpretarono un sentimento maggioritario, e vinsero il referendum» (NS 29).
[67] In un saggio sul pensiero di Deleuze e Guattari, Berardi scrive, sempre in questa direzione: «La politica del futuro non assomiglierà a quella del passato. La ‘politica del futuro’, poi: chissà se c’è il futuro? Chissà se c’è la politica? Se vogliamo immaginarci un ‘Che fare?’ ‘Come agire?’ ‘Come immaginare?’, dovremmo farlo ipotizzando l’idea (che naturalmente riconduce a Deleuze e soprattutto a Guattari) che non ci sarà politica. Ci sarà terapia: e la terapia è, in una certa misura, destinata a prendere il posto della politica. […] Non credo che potremo mai disinnescare la bomba psichica con gli strumenti della politica; con gli strumenti della terapia schizoanalitica forse sì, ma questi sono in gran parte da inventare. In questo senso, forse, il terreno della sofferenza, della sofferenza psichica, è probabilmente quello su cui diventerà più facile costruire comprensione, condivisione». Cfr. F. Berardi, Introduzione al pensiero DG. Che cosa c’è dopo la fine del futuro?, in A. Simoncini (a cura di), Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente, Mimesis, Milano, 2015, pp. 210-212.
[68] F. Berardi, Come si cura il nazi. Iperliberismo e ossessioni identitarie, Ombre corte, Verona, 2009, p. 74 (I ed. Castelvecchi, Roma, 1993).
[69] Composizione della classe, in «Classe Operaia», 1965, n. 1, p. 8.
[70] r.a. [Romano Alquati], Una ricerca sulla struttura interna della classe operaia in Italia, in «Classe Operaia», 1965, n. 1, p. 8.
[71] S. Bologna, Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare, in S. Bologna et al., Operai e Stato. Lotte operaie e riforma dello stato capitalistico tra rivoluzione d’Ottobre e New Deal, Feltrinelli, Milano, 1972, pp. 13-46.
[72] Cfr. C. Bermani (a cura di), La rivista «Primo maggio». 1973-1988, Derive Approdi, Roma, 2010. Ma, su questa riflessione, rimando anche a Nel cervello della crisi. La «storia militante» di Sergio Bologna tra passato e presente, in «tysm literary review», 2013, n. 6 [http://tysm.org/wp-content/uploads/2013/11/Damiano-Palano-La-storia-militante-di-Sergio-Bologna.pdf].
[73] Primo Maggio, Otto tesi per la storia militante, in «Primo maggio», 1978, n. 11, p. 62.
[74] A questa convergenza (che in realtà non ebbe mai alcuno sviluppo politico-teorico), Berardi si riferisce per esempio in testimonianze riportate in A. Grandi, La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, Einaudi, Torino, 2003, pp. 115-116.
[75] F. Berardi, La nefasta utopia di Potere operaio, cit., p. 18.
[76] Per evitare fraintendimenti, è opportuno osservare che l’espressione «lavoro necessario» può essere utilizzata (ed è spesso utilizzata anche all’interno della riflessione operaista e soprattutto post-operaista), in modi differenti e con implicazioni teorico-politiche persino opposte. Berardi utilizza infatti l’espressione «lavoro necessario» per esplicitare l’idea secondo cui la componente di lavoro umano nel processo di produzione si riduce sempre di più, in conseguenza della sostituzione del lavoro umano con processi automatizzati. In questo senso, per esempio, negli anni Settanta scriveva: «La forma principale della modificazione tecnologica, della composizione organica del capitale, nel modo in cui si dà, è aumento dello sfruttamento operaio, è aumento della capacità di dominio del capitale sul lavoro. La riduzione del lavoro necessario, se segna una accresicuta capacità produttiva degli operai, si accompagna però a un aumento di plusvalore relativo, della quantità sottratta al lavoro nell’unità di tempo. La riduzione del tempo di lavoro necessario rende possibile la sostituzione del lavoro vivo; l’interesse storico degli operai è la riduzione del lavoro, ma l’uso che il capitale ne fa è nel senso contrario all’interesse operaio» (FC 39). Secondo l’uso che ne fa Marx nel Primo libro del Capitale, il tempo di «lavoro necessario» identifica invece la parte della giornata lavorativa nel quale l’operaio «produce solo il valore della propria forza-lavoro, cioè il valore dei mezzi di sussistenza che gli sono necessari», col risultato che, come si legge nel settimo capitolo: «La parte della sua giornata lavorativa ch’egli consuma a questo scopo è maggiore o minore a seconda del valore della media quotidiana dei mezzi di sussistenza che gli sono necessari, dunque a seconda del tempo di lavoro medio richiesto per la loro produzione» (K. Marx, Il Capitale. Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1989, I, p. 249). Nella prospettiva della «rivoluzione copernicana» introdotta dall’operaismo, il «lavoro necessario», inteso come frazione della giornata lavorativa «necessaria» per riprodurre il valore della forza lavoro, non è determinata da fattori ‘oggettivi’, ma è il risultato della sedimentazione dei conflitti. Proprio in questo senso nella «composizione di classe» si trova fissato il livello storicamente consolidato del «lavoro necessario» (ossia il costo della riproduzione della forza lavoro che la classe operaia è stata in grado di imporre con le proprie lotte), e per questo il saggio del plusvalore (dato dal rapporto tra pluslavoro e lavoro necessario) è determinato non solo da fattori ‘tecnici’ e ‘oggettivi’, ma anche da un elemento ‘politico’ come il livello del lavoro necessario, materializzato nel «salario necessario». Lo stesso Negri adottava questa seconda accezione in diversi scritti degli anni Sessanta e Settanta. Nel 1968 scriveva per esempio che il ciclo dello sviluppo «funziona e si articola sullo scontro di due strategie: quella operaia che dal livello della mera esistenza si svolge sino a comprimere il profitto mediante l’innalzamento del salario necessario, quella del padrone collettivo costretto a rispondere strategicamente all’attacco operaio e quindi a muovere l’intero proprio potenziale economico e politico in questo scontro». Cfr. A. Negri, Marx sul ciclo e la crisi (1968), in S. Bologna et al., Operai e Stato, cit., p. 214. Alcuni anni dopo, adottava questo schema per interpretare la crisi dello «Stato-piano»: «Lo Stato delle proporzioni determinate è caduto dinanzi alla massificazione delle lotte, all’estendersi della richiesta di salario – è caduto nello scontro che gli opponeva il lavoro astratto unificatosi come prassi collettiva nella richiesta di un innalzamento del valore del lavoro necessario. Ciò ha prodotto quello scarto delle proporzioni determinate fra lavoro necessario e pluslavoro che si chiama inflazione» (A. Negri, Crisi dello Stato-piano, Feltrinelli, Milano, 1974, p. 32).
[77] «Il soggetto è qualcosa di costituito, di solido, qualcosa che ha a che fare con la verità in una certa maniera», scrive Berardi, mentre «per Deleuze e Guattari l’importante non è il soggetto, non è la soggettività; ciò che conta è la soggettivazione, cioè il processo attraverso il quale si costituisce e si definisce il campo della soggettività» (F. Berardi, Introduzione al pensiero DG. Che cosa c’è dopo la «fine del futuro»?, cit., p. 206). Nell’Anti-Edipo, Deleuze e Guattari contrapponevano per esempio il «gruppo assoggettato», nel quale la produzione desiderante viene schiacciata, al «gruppo soggetto», un gruppo cioè in «i cui investimenti libidinali sono in sé rivoluzionari». Cfr. G. Deleuze – F. Guattari, L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia (1972), Einaudi, Torino, 2002, p. 400.
[78] C. Bermani – F. Coggiola (a cura di), Memoria operaia e nuova composizione di classe. Problemi e metodi della storiografia sul proletariato, Maggioli, Rimini, 1986.
[79] Ibi, p. 350.
[80] Ibi, p. 351.
[81] Cfr. A. Negri (Erkenntnisstheorie. Elogio dell’assenza di memoria, in «Metropoli», n. 5, 1981, poi in Id., Fabbriche del soggetto. Profili, protesi, transiti, macchine, paradossi, passaggi, sistemi, potenze: appunti per un dispositivo ontologico, XXI Secolo, Livorno, 1987, p. 160.
[82] C. Bermani – F. Coggiola (a cura di), Memoria operaia e nuova composizione di classe, cit., p. 352.
[83] Ibi, pp. 352-353.
[84] M. Revelli, Osservazioni e riflessioni sull’inchiesta operaia, in C. Bermani – F. Coggiola (a cura di), Memoria operaia e nuova composizione di classe, cit., p. 454.
[85] B. Stiegler, Passer à l’acte, Galilée, Paris, 2003.
[86] Cfr. J. Crary, 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno (2013), Einaudi, Torino, 2015.
[87] J.-P. Galibert, Suicidio e sacrificio. Il modo di distruzione ipercapitalistico (2012), Stampa Alternativa, Viterbo, 2015, p. 16. Secondo l’argomentazione di Galibert: «L’ipercapitalismo non si accontenta di estorcere qualche ora al giorno di lavoro non pagato. Pretende e ottiene la totalità della vostra esistenza: vuole che gli sacrifichiate tutta la vostra vita. E vi lascia liberi di scegliere il modo in cui offrirgliela: tutta insieme, oppure un po’ alla volta, goccia a goccia, accettando l’iperlavoro permanente che vi viene proposto. L’ipercapitalismo spinge al suicidio, perché suscita le due forme di sacrificio assoluto da cui trae profitto; il sacrificio definitivo del suicida e il sacrifico permanente del suicidiario. Le società della disciplina e del controllo cedono ormai il passo alle società del sacrificio» (ibi, p. 19).
[88] Per uno sviluppo di questa critica rinvio a D. Palano, Il bandolo della matassa. Forza lavoro, composizione di classe, capitale sociale: note sul metodo dell’inchiesta, in «Intermarx», 2001 [www.intermarx.org], ora in Id., Il bandolo della matassa. Pensiero critico nella società senza centro, Multimedia Publishing, Milano, 2009, pp. 115-167, e Id., Dioniso Postmoderno. Classe e Stato nella teoria radicale di Antonio Negri (2000), Multimedia Publishing, Milano, 2008, oltre che a Id., The «excesses» of cognitive capitalism, in «Historical Materialism», n. 3, 2013, pp. 229-245.
[89] Sull’«Italian Theory», cfr. D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna, 2012, D. Gentili – E. Stimilli (a cura di), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Derive Approdi, Roma, 2015, A. Toscano – L. Chiesa (eds.), The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, Re.Press, Victoria – Australia, 2009, ma anche R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino, 2010, e A. Negri, La differenza italiana, Nottetempo, Roma, 2005.
[90] F. Berardi, La sollevazione, cit., pp. 111-112.
[91] M. Tronti, Noi operaisti, DeriveApprodi, Roma, 2009, p. 58.
[92] Per un esame del percorso di Tronti, rinvio in particolare al saggio Il crepuscolo dell’operaismo (2001), compreso in D. Palano, I bagliori del crepuscolo. Critica e politica al termine del Novecento, Aracne, Roma, 2009, pp. 69-160, e a Id., L’ultimo lampo del Novecento, cit.
[93] Per quanto riguarda Formenti, la sua rivalutazione della dimensione dell’«autonomia del politico» emerge soprattutto in C. Formenti, Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011, e Id., Utopie letali. Contro l’ideologia postmoderna, Jaca Book, Milano, 2013. Al proposito, rinvio alle considerazioni svolte in D. Palano, Lenin a Pechino? Leggendo «Utopie letali» di Carlo Formenti, in «Tysm», vol. 10, n. 15, giugno 2014.
[94] F. Berardi – C. Formenti, L’eclissi. Dialogo precario sulla crisi della civiltà capitalistica, Manni, Lecce, 2011, p. 78.
[cite]
tysm review
philosophy and social criticism
vol. 23, issue no. 33, february 2016
issn: 2037-0857
creative commons license this opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license.
based on a work at www.tysm.org

